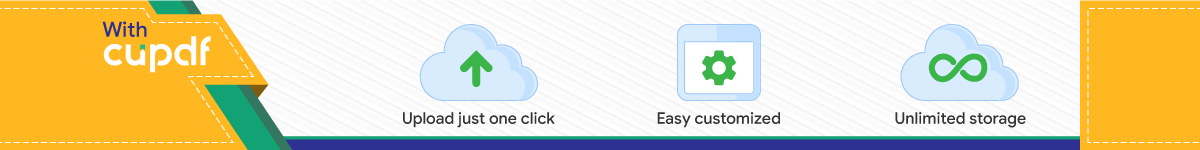

CAP.4 RISPONDERE ALLA
PAROLA DELLA RESURREZIONE
L'esistenza umana redenta santificata, sulla via della sua divinizza-zione, è una realtà che sussiste solo "dopo la Resurrezione, a causa del-la Resurrezione, a partire dalla Resurrezione".
Essa si configura per ciò stesso come la risposta, o purtroppo la mancata risposta all'unico Evento vero della storia, quello che da esi-stenza e significato a tutti gli altri eventi, sacri e profani: il fatto storico che Cristo Signore Crocifisso dagli uomini fu resuscitato dal Padre ad opera dello Spirito Santo.
Tale Evento viene agli uomini dalla testimonianza autentica e veridi-ca di uomini che assisterono agli Eventi divini inoppugnabili, al Miste-ro mentre teofanicamente si fa incontro agli uomini. Quella Testimo-nianza, che è degli Apostoli, è divina ed apostolica, parla ancora e sem-pre del Mistero nella Parola divina.
H Mistero divino unico indivisibile indicibile salvifico trasformante divinizzante, per sé è rivelato solo dalla Parola divina nella storia, letta nella Tradizione. Ed opera nella storia solo a partire dalla Parola divina. Come si disse, tuttavia, Parola divina non inerte. È quella letta studiata meditata compresa spiegata mistagogizzata celebrata dalla Chiesa Una Santa. Nell'ininterrotta grande Tradizione mistagogica, ed in continuo approfondimento ed accrescimento dottrinale e spirituale. Ad opera dell'unico Spirito Santo che rivela il Mistero nelle Scritture che ha ispi-rato. Che guida la Chiesa nella sua mistagogia. Che spinge alla celebra-zione. Che dona la ricchezza della dottrina, assistendo sempre la Chie-sa che legge le Scritture, e dando forma alla sua Tradizione ininterrotta.
E la Parola divina produce, come si è visto e si vedrà, un'inscindibi-le globalità, la quale nella Tradizione mistagogica porta tutti insieme i contenuti, ed in specie i contenuti della celebrazione, in "linguistica ce-lebrativa". Si può chiamare tutto questo 1'"universo simbolico biblico" cristiano, la cui forma più propria di lettura è la "teologia simbolica", di cui si è parlato.
1. Se si parla di "Lezionario"
Nella terminologia degli studiosi, occidentali e di formazione cultu-rale latina, usando la terminologia della tradizione liturgica latina si chiama "lezionario" da una parte gli elenchi numerici delle pericope da leggere durante le varie celebrazioni; dall'altra, il libro liturgico che ri-porta per esteso i testi divisi nelle pericope indicate da quegli elenchi. Di fatto nei codici esistono ambedue le forme di tale "ordine" delle
98

rCAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
Letture bibliche, in genere una per gli Evangeli, una per le Epistole. L'uso antico universale qui era promiscuo, in quanto poteva annotare le singole pericope da leggere al margine del testo sacro riportato per esteso, ossia senza interruzione.
Nella Liturgia bizantina prevalse l'uso di "ordinare" le Letture sacre in due libri principali, il Théion kài hierón Euaggélion, "divino e sacro Evangelo", e VApóstolos, ètoi Prdxeis kài epistolài tòn Apostólòn, "Apostolo, ossia Atti ed Epistole degli Apostoli", i quali riportano in apposite tabelle, tra altri dati, anche l'elenco ordinato delle Letture con le loro occasioni. Per la parte da cantare nelle singole occasioni, VApó-stolos offre anche i Salmi (Antifone delle Feste, Versetti prima dell'E-pistola, Prokéimena, Alleluia per l'È vangelo). Questo non va confuso con il ed. Lectionarium byzantinum, che negli studi critici biblici indica l'edizione curata dal Patriarca S. Fozio, che ha particolarità interessanti.
Qui di seguito, "Lezionario" indicherà in genere il "sistema delle Letture bibliche" come una quantità globalmente presa, mentre si rife-rirà di volta in volta alle sue specificità nei Libri liturgici che sono VApóstolos e VEuaggélion. Così "Lezionario" intenderà in pratica la lettura come tale della Parola divina durante la Divina Liturgia.
Sarà spiegato a parte il complesso delle particolarità, in specie in rapporto alle "linee" degli Evangeli e degli Apóstoloi.
2. La Parola ordinata nei Divini Misteri
La Santa Scrittura quasi naturalmente si presta ad essere disposta secondo una "forma" che diventa quella principale nella vita della Co-munità di fede, ossia facilmente si può "ordinare" secondo un "Lezio-nario". Benché forme stabili di "lezionario" ebraico siano conosciute solo dal sec. 5° d.C, nelle comunità di Babilonia, si sa che al tempo di Cristo gli Ebrei in sinagoga, e così fino ad oggi, usavano un "sistema di Letture" bibliche. Essi avevano ordinato (i vari sistemi non sono co-nosciuti per quell'epoca) le letture bibliche secondo una duplice linea: a) la Tóràh, il Pentateuco, diviso inpàràsòt, "divisioni" operikopdi, per l'uso sinagogale sabbatico, in un ciclo annuale (ma si è quasi certi che esistessero cicli biennali e triennali, secondo usi locali palestine-si); b) i "Profeti", ossia il resto della Scrittura dell'A.T., ordinati in hqftàròt, o "chiudere", destinate ad illustrare e quindi a "chiudere» le pàràsòt. In questo aveva ricevuto un "ordine" di canto anche il Salte-rio. La celebrazione sabatica e festiva aveva dunque un esuberante materiale biblico, dove il canto mostrava la gioia dell'ascolto. Era uso sinagogale poi di procedere all'omelia sulla Tóràh, spiegata anche dal riflusso dei Profeti.
99

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
Nelle Chiese si può parlare di "Lezionario" come "sistema di lettu-re" verso la fine del sec. 4°, quando si comincia la lettura ordinata, do-menicale e festiva. Nasce allora stabilmente il corso dell'"anno liturgi-co". Nel sec. 5° si conoscono ormai diverse forme di Lezionari per cia-scuna Chiesa, d'Oriente come d'Occidente.
Come per la Sinagoga, così per la Chiesa, che anche in questo segue gli usi ebraici, il Lezionario è egualmente il modo primordiale di legge-re le Sante Scritture. Come "libro liturgico" che comprende i diversi volumi dell'A.T., dei Salmi, del N.T., dei 4 Evangeli, esso è primordia-le, insostituibile e di fatto mai sostituito, nella celebrazione della Chie-sa. È la fede della Chiesa portata dal Mistero divino. Delle Sante Scrit-ture il Lezionario è la "lettura normale", domenicale, festiva e quotidia-na che la Chiesa svolge di continuo. Poiché celebrando a partire dalla Parola il suo Signore, la Chiesa vive ama spera crede conosce progetta. Non solo, ma adora, è santificata, è avviata alla sua divinizzazione: già in questa Lettura principale, continua, di fede, in crescendo di fede e di intelligenza, e dunque di amore. La Chiesa per sé non legge semplice-mente "la Bibbia" come il libro stampato, ormai posseduto dai fedeli in centinaia di milioni di esemplari in tutte le lingue. Nessuna meraviglia né irritazione degli specialisti. La Chiesa legge principalmente "la Bib-bia" come Lezionario biblico. E solo in modo subordinato, come resto dell'insegnamento, come difesa della fede, come apologetica, legge "la Bibbia" che si usa stampare in volume.
Qui si pone come molto opportuno l'avvertimento del Signore:
Ed Egli parlò ad essi:Per questo, ogni scriba reso discepolo del Regno dei cieliè simile all'uomo padre di famiglia,il quale fa uscire dal Tesoro suorealtà nuove e realtà antiche (Mt 13,52).
La lettura dal Lezionario è perciò quella "normale", autentica, della Chiesa nella pienezza e nel possesso pacifico della sua fede, che cele-bra. Così che la pratica assidua, quotidiana, amorevole dei contenuti or-dinati del Lezionario è un ausilio opportuno, provvidenziale. Anzitutto al lavoro della Grazia divina che deve trovare dimore pronte nelle ani-me. E poi al resto della mistagogia della Chiesa in ogni suo aspetto: ce-lebrativo, ecclesiale, morale, sociale.
Esistono però diversi Lezionari, oltre quello della Divina Liturgia, e di questo occorre avere coscienza, o più acuta consapevolezza. Ogni Mistero celebrato, anzitutto quello dell'iniziazione cristiana, ed ogni ri-to della Chiesa, ha un Lezionario, ampio o ridotto che sia (cf. ad es. le consacrazioni, la dedicazione della chiesa, e così via). Infine esiste
100

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
quello quotidiano ed integrato, usato per la celebrazione delle Ore sante della Chiesa. Un immenso complesso, dove praticamente tutta la Santa Scrittura è trattata, disposta, ordinata, offerta da leggere e celebrare per la nostra gioia.
Qui restringiamo qualche considerazione al Lezionario della Divina Liturgia. Il maggiore per ampiezza e completezza. Il più importante per la dignità dei Misteri divini celebrati. Il più diffuso perché, almeno ogni Domenica e Festa, è posto a contatto diretto con tutto il popolo partecipante.
3. Il Mistero divino nelle strutture del "Lezionario"
II Lezionario della Divina Liturgia vuole per sé contenere per intero il Mistero divino di continuo celebrato.
Esso per sua natura presenta un ordine molto coerente, il quale de-riva in via diretta dalla stessa mistagogia del Signore, ad esempio sul-la via di Emmaus (cf. Le 24,27-49), che procede per queste linee ne-cessarie:
a) Cristo Risorto con lo Spirito, la sua presenza totale con lo Spirito,punto invariabile di ogni partenza;
b) il rinvio cogente ai fatti della vita storica del Signore, ossia quantoEgli stesso aveva "parlato ed operato", dunque l'EVANGELO;
e) il rinvio altrettanto cogente alla Preparazione antica, adesso adem-piuta con il Dono inconsumabile dello Spirito Santo: ossia l'A.T., quando si ha (cf. le Grandi Ore);
d) ridiscesa, per così dire, alla vita di fede degli Apostoli nella Chiesa, le "memorie degli Apostoli", il resto del N.T., le "epistole" o gli Atti o l'Apocalisse. Il complesso globale dunque che la Chiesa poi chiamerà specificamente l'"Apostolo".
Nella sua struttura, il Lezionario quindi consiste dal vario connettersi di testi della Scrittura dei Due Testamenti, con l'Evangelo al centro. L'Evangelo, nel libro necessario, prescritto, che è l'Evangeliario, è co-me il fine ed il centro del Lezionario. E di stretta necessità. Poiché pro-priamente, come si deve insistere, noi cristiani possiamo celebrare solo Cristo Risorto con lo Spirito, nei fatti della sua vita storica di Risorto, ma battezzato e trasfigurato, che è "passato Operatore-del-bene" nella potenza dello Spirito Santo, fino alla santa Croce (cf. ancora i? 10,38). E solo celebrando il Signore Risorto con lo Spirito entriamo all'adora-zione al Padre "nello Spirito e nella Verità" (cf. Gv 4,23). E tale adora-
101

L
CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
zione unica e indivisibile va al Padre mediante il Figlio-Verità nello Spirito. E nel Padre adoriamo la Triade santa consustanziale e indivisi-bile del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio Unico. L'A.T. ed il resto del N.T. sono come 1'"illustrazione", benché necessaria, dell'E-vangelo del Signore, dove i Salmi svolgono una funzione singolare di canto di gioia e di accettazione.
La celebrazione si fonda dunque sulla "linea degli Evangeli", mai su altro, portando gli Evangeli, giorno per giorno, i contenuti da celebrare. Infatti, se si toglie la pericope evangelica, la celebrazione è cieca e vuo-ta. Ricollocata la pericope evangelica dove le spetta, la celebrazione è luce e pienezza.
La "linea degli Evangeli" forma il "continuo celebrativo" del "tem-po della Chiesa", da due millenni.
Qui si può richiamare solo quanto sarà spiegato in seguito, la linea continua formata nella Liturgia bizantina dalla successione mirabile de-gli evangeli di Giovanni, di Matteo, di Luca, e di Marco, che se è varia-mente usato, occupa poi per tanta parte il tempo del Digiuno grande, la santa e spirituale Quaresima.
Spicca qui la funzione singolare ed insostituibile dell'omelia mista-gogica celebrativa, la quale deve ricollocare l'Evangelo del giorno nella costitutiva contiguità, con brevi allusioni, sempre, agli Evangeli pre-cedenti, e a quelli che seguiranno; è la contestualità, tanto illuminante. E la "linea degli Evangeli" fonda la "ermeneutica normale" della Chie-sa, esigita dalla "lettura normale" che la Chiesa fa della Scrittura, come si è detto. È un'ermeneutica di fede, ermeneutica celebrativa. La più alta e la più completa. La quale di per sé è semplicemente "la ermeneutica" della Chiesa: "come si celebra, così si deve credere".
Di questo grande motivo, che poi nei secoli sarà riassunto dal cele-bre adagio "affinchè la norma del celebrare statuisca la norma del cre-dere", da già testimonianza verso il 180 il grande S. Ireneo di Smirne, quando in un testo lapidario e denso afferma con pacifica tranquillità:
II nostro sentire (gnome) è consonante (symphónos) con l'eucarestia, ed a sua volta l'eucarestia conferma (bebaióò) il nostro sentire (gnòme) (Adversus haereses 4,18,5, in PG 7,1028-1029).
Esiste dunque il rigore della coerenza tra la realtà dei divini Misteri, e quello che con l'aiuto della Grazia dello Spirito Santo gli uomini fe-deli possono e debbono di essenziale e determinante per la loro esistenza ricavare dalla contemplazione delle Scritture, dove la celebrazione è il punto insieme d'arrivo e di sigillatura, ed è il punto fontale da cui ef-fluisce il crescendo di vita, nella contemplazione delle Scritture in vista di celebrazioni sempre più intense e vissute.
102

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
È l'ermeneutica continua, che non dovrebbe subire diminuzioni né arresti, né sussulti né deviazioni. L'equilibrio spetta nella Chiesa alla santa Gerarchia, ed insieme ai grandi spirituali che della Gerarchia sono il necessario sussidio, silenzioso e valido per le anime.
"Ermeneutica" significa a sua volta interpretare per applicare ed at-tuare. Essa deve procedere infatti, secondo le leggi interne della Rivela-zione, dall'Omega verso l'Alfa. In altre parole rispetto a quanto appena detto, dall'Omega, Cristo Risorto con lo Spirito e qui presente con lo Spirito, verso l'Alfa della salvezza, l'A.T. Per ridiscendere all'Alfa-Omega nella loro visuale piena, la vita di fede della Chiesa degli Apo-stoli, che hanno già sperimentato, ed essi soli, questo Alfa-Omega divi-no.
Questa non è complicazione di studiosi antichi o moderni: oltre che nel N.T., ad esempio nelle parole del Signore sulla via di Emmaus, e analogicamente già nello stesso A.T., è il modo preciso di leggere le Realtà divine della salvezza.
Possiamo così tranquillamente parlare di "lettura Omega". Ancora una volta i Padri lo avevano acutamente, e meravigliosamente, compre-so e obicttivato, come ci attesta uno splendido testo di S. Ireneo, pieno di questa "ermeneutica retrospettica", l'unica valida:
Chi legge attentamente le Scritture, sentirà parlare di Cristo, e vi tro-verà prefigurata la vocazione nuova. Egli è il Tesoro nascosto nel campo, ossia in questo mondo, "il campo è questo mondo" (Mt 13,38, spiegazione della parabola della zizania). E Cristo sta nasco-sto nelle Scritture in quanto vi è indicato attraverso tipi e parabole. Questo non poteva essere compreso dall'uomo prima che venisse l'adempimento della Realtà, la Venuta di Cristo. E questo significa quanto fu parlato a Daniele profeta: "Sigilla i discorsi e contrasse-gna il libro fino al tempo del compimento, affinchè molti compren-dano, e la lettera sia adempiuta. Quando avverrà la dispersione, essi comprenderanno tutti questi fatti" {Dan 12,4.7). Anche Geremia parla: "Negli ultimi tempi, essi lo comprenderanno" (Ger 23,20). Ogni profezia prima che sia avverata è enigmatica ed ambigua per gli uomini. Ma venuto il tempo e adempiutosi quanto è predetto, al-lora le profezie hanno significato chiaro e certo. Perciò quando ai giorni nostri gli Ebrei leggono la Legge, per essi è come leggere un racconto, poiché essi non hanno la conoscenza completa sulla Venuta del Figlio di Dio nella natura umana. Mentre quando è letta dai cristiani, essa è // Tesoro nascosto nel campo, rivelato e spiegato dalla Croce dì Cristo, la quale manifesta la Sapienza di Dio ed i Di-segni suoi sugli uomini, prepara il Regno di Cristo ed annuncia l'E-redità della Gerusalemme santa, afferma che l'uomo deve progredi-
103

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
re di continuo nell'amare Dio finché contemplerà Dio ed ascolterà la Voce di Lui, e (afferma) che ascoltando la Parola sua (l'uomo) sarà tanto glorificato, che gli altri non potranno fissare il suo volto, come fu parlato da Daniele: "I sapienti risplenderanno quali stelle del cie-lo, e molti giusti saranno quali stelle per secoli e secoli" (Dan 12,3; cit. da Mt 13,43).Come dicemmo, chi legge le Scritture — Gesù le aprì ai discepoli dopo la Resurrezione, mostrando con le medesime Scritture "che il Cristo avrebbe dovuto soffrire (cf. Is 52,13 - 53,12) ed entrare così nella Gloria sua, e che si sarebbe dovuto predicare nel Nome suo la remissione dei peccati nel mondo intero" (Le 24,26.47) — sarà il perfetto discepolo, e simile al "padre di famiglia, il quale fa uscire dal Tesoro suo realtà nuove e realtà antiche" (Mt 13,52) (S. IRENEO, Adversus haereses 4,26,1, in PG 7,1050 A - 1053C).
La potenza della predicazione dei Padri, oltre che dall'assistenza fe-dele dello Spirito Santo, non poco derivava anche dalla consapevolezza determinante dell'efficacia di questa "lettura Omega".
Il Signore Risorto per questo "rimanda" alla sua vita storica, all'A.T., alla vita della Chiesa; affinchè nelle generazioni risplenda di luce gioiosa l'intera e indivisibile "Manifestazione" dell'Amore divino nella storia, dall'inizio alla consumazione, dalla consumazione fino a comprendere il misterioso inizio. La Parola contiene tutta la Manifesta-zione. In specie la accentua il Lezionario.
Questa è la globalità, vitalità ed efficacia del Lezionario.
4. La "lettura celebrativa": strutture e tecniche
Si richiama qui il Cap. 3, che va integrato con altre nozioni.La necessità urgente è sempre e comunque: conoscere a fondo la Pa-
rola di Dio, in specie neh" "ordine" preparato per la celebrazione, dunque nel "Lezionario". Questa conoscenza, oltre quanto detto e quanto sarà ancora da dirsi, è anche una del tutto singolare, mirabile avventura spiri-tuale ed intellettuale. La quale è volta a vincere ogni pigrizia mentale, ogni reticenza e ritardo, e quindi a vincere l'ignoranza, e questo è ap-profondire senza cessare, a coltivarsi sempre di più, e se si opera con im-pegno nella pastorale, a restare senza scampo nella via tracciata. Ed infi-ne, tutto questo chiede molta preghiera: l'epiclesi al Padre per ottenere lo Spirito della divina Sapienza, quella che "conosce per solo amore".
L'esempio preclaro per la "lettura" della Parola divina può essere cercato a Gerusalemme, la Chiesa Madre, che celebrava l'Evangelo sui luoghi stessi degli eventi narrati, e che verso la fine del sec. 4° aveva organizzato un imponente "sistema" delle Letture bibliche. Per com-
104

L
CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
prendere l'importanza delle scelte sempre illuminate ed illuminanti dei Padri nostri, si deve tenere presente l'antica struttura del sistema delle Letture per i divini Misteri (il discorso dovrebbe proseguire per le Ore sante):
A)A.T.- libri storici: 1 lettura come "testa di serie", altre eventuali;-libri profetici: idem;-libri sapienziali: idem;-Salmi tra le Letture;
B)N.T.-Apóstolos: 1 lettura come "testa di serie", altre eventuali;-Atti: idem;-Epistole cattoliche: idem;-Salmi tra le Letture;
C)EVANGELO-1 proclamazione come "testa di serie", altre eventuali;-acclamazione salmica prima, dossologia dopo.
Le Chiese nei secoli (in Occidente durante il 6° secolo, in Oriente alla fine del 7° secolo) hanno abbandonato l'A.T. durante la lettura della Parola divina nella celebrazione dei Misteri eucaristici. Lo conservano solo i Siri orientali (Nestoriani, Caldei, Malabaresi). Le altre Chiese lo ritrovano nella celebrazione delle Grandi Ore, quando riemerge la parte più antica della santa Liturgia. La Liturgia romana ha recuperato l'A.T. con il "Salmo responsoriale" solo con la riforma impostata dal Concilio Vaticano II; il nuovo "Lezionario" fu edito per la prima volta nel 1969.
Anche a restare alla lettura dell'Apóstolos e dell'Evangelo, si deve considerare che qui vinse la "legge del minimo sforzo", che è anche quella che di molte sante Anafore ne lascia in uso solo poche, e poi da queste poche in genere sceglie la più breve.
Comunque, per la Liturgia bizantina un ottimo esempio del Leziona-rio antico, esemplato sul tipo gerosolimitano, è quello che poi sarà pre-sentato per il Sabato santo e grande, sfociante nella Divina Liturgia di S. Basilio, dove si daranno alcune considerazioni, e saranno visibili an-che le "teste di serie".
Per le strutture del Lezionario sarà qui da accennare che sono previ-ste, e di fatto applicate, "letture" di vario genere ed estensione:
a) lettura corsiva, o continua, che legge un testo senza interruzione; è abbastanza rara nell'uso;
105

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
b) lettura semi-corsiva: quando si legge gran parte di un testo in una successione qua e là interrotta; così, grosso modo, l'Evangelo nel pe-riodo dalla Domenica della Resurrezione a quello del Triódion (salve sempre le particolarità calendariali);e) lettura tematica: quando l'Evangelo è scelto in base al "tema" di una festa, e tutto è raccordato secondo questo tema ali'Evangelo stesso.
Di per sé le prime due sarebbero più naturali e ricche, più mistago-giche nella loro progressione.
La tecnica della "lettura" dei testi, adesso, deve essere vista sotto l'angolo, insieme, del "continuo celebrativo", e della "linguistica cele-brativa", ossia in questo secondo caso tenendo conto dell'intero com-plesso di un dato giorno, per sé "da Vespro a Vespro", con i divini Mi-steri al centro, e l'Evangelo al centro di questi.
Il primo di tali modi di lettura si può chiamare "diacronico", ossia progressivo; il secondo sincronico, o globale. Sotto questo secondo cri-terio si deve sempre tenere presente il fatto che il raccordo comunque avviene intorno all'Evangelo del giorno. L'Evangelo è la chiave emer-neutica unica. Gli altri testi formano il contesto celebrativo, che potrebbe mutare, quando ad esempio il medesimo Evangelo, si pensi a quello della Visitazione di Maria ad Elisabetta, Le 1,39-56, è usato per altre oc-casioni, e sempre con testi biblici e liturgici che possono essere diversi.
Avviene qui il mirabile fenomeno della virtualità della Parola, sem-pre illimitatamente ricca di nuovi temi e visuali e contenuti, che scatu-riscono dal raccostamento di tanti e diversi testi tra loro. E tale fenome-no è ancora più complesso, in quanto i problemi "critici" moderni sono qui come assorbiti e superati. La Chiesa orante ne suppone lo studio, ne tiene anche conto. Ma quando celebra, dispone i Testi nel suo ordine coerente, ed in modo sovrano.
Appena va qui accennato un tratto, che merita di essere svolto a lun-go, organicamente. Se si tiene conto delle due leggi celebrative, del "continuo celebrativo", la diacronia secondo la linea degli Evangeli, e della "linguistica celebrativa", la sincronia che contempla tutti i testi e tutti i "segni", i temi della celebrazione nella loro totalità sarebbero enucleati solo da una indagine che andasse "da Vespro a Vespro", con i divini Misteri al centro: di un giorno, dunque, la globalità di quanto la Chiesa celebra.
Di fatto, la struttura della celebrazione dei Misteri, "la Cena del Si-gnore", che risale al N.T. e che possiamo seguire dalla prima patristica (S. Giustino Martire, e. 155, 1 Apologia 67, in un contesto di iniziazio-ne battesimale), comprende per sua essenza i tre momenti di "comunio-ne al triplice Corpo di Cristo":
106

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
A) alla Parola divina, Pane dello Spirito Santo (Gv 6,63), che "si mangia" (cf. Mt 4,4; Le 4,4; Dt 8,3), e del quale si fa omelia;
B) alla Mensa dei Misteri, dove si vive e si esprime la fede con i gestidel Convito del Regno, mangiare e bere (cf. 1 Cor 11,26; 10,16-17;12,13;Le 22,10-19);
C) alla Chiesa Sposa del Signore.
Nella terminologia odierna, le parti essenziali della celebrazione ri-salenti all'epoca apostolica, sono, e restano, dunque:
a) la Liturgia della Parola,b) la Anafora o Prece eucaristica,e) i riti della comunione.
I riti di ingresso, della preparazione dei doni, della conclusione sono tardivi, si organizzano a partire dal sec. 4° nelle grandi cattedrali, sono più o meno complessi, e strettamente parlando non sono essenziali; tut-tavia vanno tenuti, eseguiti e spiegati dovutamente.
Le strutture qui accennate si trovano anche, puntualmente, in tutti i Riti orientali, facilmente individuabili in 6 successioni:
a) riti della preparazione dei doni,b) riti di ingresso,e) LITURGIA DELLA PAROLA,d)riti pre-anaforici,e)ANAFORA EUCARISTICA,f) RITI DI COMUNIONE; Congedo.
Del materiale che spesso è imponente, sempre comunque vasto e ricco di significato, di seguito si vuole offrire il commento, nell'ordine che i testi ricevono dalla celebrazione:
1) le Antifone,2) YEisodikón,3) i Tropari del giorno,4) YApóstolos con il suo Prokéimenon e il suo Stichos,5) l'EVANGELO con il suo Alleluia, e il suo Stichos,6) il Megalinario,7) il Koinònikón.
Altro materiale per le maggiori Feste sarà illustrato a suo luogo.
107

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
È utile qui intanto offrire qualche spiegazione sulle Letture che sono l'Èvangelo e VApóstolos, oltre quelle precedenti ed altre che possono seguire.
A) UEvangelo
È la diretta autentica insostituibile Parola del Risorto, il Verbo incar-nato. Per questo la Chiesa e le Chiese lo hanno sempre circondato di onore del tutto speciale.
Perché è la Parola della sua Resurrezione, come sarà spiegato da di-versi angoli visuali. Per questo, secondo il simbolismo dei Padri, esso è preso dalla tomba vuota del Signore, la Mensa santa da cui di continuo balza Risorto per donare la sua Vita con le Offerte divine, ed è portato all'altra tomba vuota del Signore, l'ambone, da cui balza Risorto quale Verbo della Vita, ed è annunciato di continuo dall'"Angelo della Resur-rezione", il diacono (S. Germano di Costantinopoli, sec. 8°). NélYÓrth-ros è proclamato dal Vescovo se presente, dal presbitero, e dall'abate, non dal diacono. Così nella grande Veglia della Resurrezione, che ne da l'esempio. È dunque l'unico Libro biblico che debba essere trattato so-lo da uno che abbia ricevuto l'imposizione delle mani del Vescovo.
Anche per questo, mentre tutto il resto delle Sante Scritture dell'A.T. e del N.T. "si leggono", l'Evangelo si "proclama" e si "annuncia". È leg-ge antica, universale, perenne tra le Chiese della Tradizione apostolica.
Il "libro" che racchiude i 4 Evangeli, dalla più alta antichità è una teca per quanto possibile preziosa esternamente, deve essere solo di metallo (né pelle, né legno, né altro materiale), trapunto di gemme, che indicano la gioia delle feste liturgiche. Sulle 2 copertine porta l'icona della Resurrezione e quella della Stàuròsis, la Crocifissione, accompa-gnata intorno da altre icone, in genere delle grandi Feste del Signore e della Theotókos. Quando il testo era manoscritto, riceveva preziose mi-niature di icone anche degli Angeli e dei Santi.
È una delle forme dell'"icona spaziale e temporale della Resurrezio-ne", secondo il detto dei Padri, ripreso dalla Sinodo di Nicea II, che quanto la Parola rivela, l'icona manifesta.
Questo singolare libro liturgico, da non paragonare a nessun altro, è l'oggetto di specifica venerazione, come e più delle sante icone. Qual-che dato si è accennato. Ma intanto, è l'unico Libro della Chiesa che sia di continuo "liturgizzato", poiché deve riposare perennemente sulla santa Mensa, con i divini Misteri. Dalla Mensa il celebrante lo assume con cura per consegnarlo pregando al diacono, e con altrettanta cura ve lo ripone. L'Evangeliario è incensato. È portato in processione solenne, con le lampade accese, verso l'ambone. È mostrato all'assemblea te-nendolo in alto nella processione verso l'ambone e poi dall'ambone,
108

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
dalla Mensa alla Mensa. È ascoltato devotamente da tutti, in piedi ed a capo scoperto, poiché già nel momento solenne della "Piccola Éisodos" è il "segno" della Venuta del Signore nell'Economia della carne salvifi-ca. È baciato dal celebrante, che lo può offrire da baciare ai presenti — come nelV aspasmós che conclude il Canone pasquale —, in specie ai bambini. Con esso il celebrante benedice il popolo.
L'Evangeliario che porta "l'Evangelo della grazia" (cf. At 20,24), è la Parola della Resurrezione, adempimento divino totale del Padre per il Figlio con lo Spirito Santo, culmine dunque dell'indicibile Oiko-nomia triadica, e adempimento del Risorto con lo Spirito Santo anche in favore di noi uomini (cf. Rom 8,11). È di fatto la presentazione pre-sente ed attiva del Disegno del Padre ormai adempiuto.
Lo Spirito lo ha ispirato agli Autori apostolici al fine di narrare la Vita del Signore tra gli uomini, a cominciare dalla Resurrezione ed a ri-salire verso le origini: è la "lettura Omega", la sola vera soddisfacente lettura della Chiesa, che del resto esige anche altre forme di lettura.
La Resurrezione pone e spiega la "storia della salvezza". Perciò l'E-vangelo che ne è la pienezza, è coestensivamente:
- la Parola storica: la "storia della divina salvezza" adempiuta tra gliuomini;
- la Parola profetica: la Profezia, insieme adempiuta, e tuttavia sempreda annunciare, ed efficace ogni volta che si proclama, perché annuncia il Regno di Dio già inaugurato dalla Resurrezione nel Convito;
- la Parola sapienziale: perché vi è presente la divina Sapienza personale e triadica, l'Amore incarnato nuziale unitivo trasformante delPadre, Cristo Signore venuto con lo Spirito tra gli uomini per sempre.
È la Parola che propriamente si mangia, come si è detto, affinchè in sé, e per noi, diventi il Corpo e la Coppa preziosi del Signore Risorto che donano lo Spirito Santo divinizzante.
B)L'A.T.
E qui si deve porre una parola sull'A.T., poiché in esso lo Spirito di Dio che l'ispirò ci chiama a trovare la Parola preziosa della Promessa antica: "la Benedizione e la Promessa ad Abramo", ottenuteci dal Cro-cifisso, sono lo Spirito Santo (Gai 3,13-14). VOikonomiadivina infatti è una ed unica, in diverse fasi coerenti e conseguenti tra esse, e comin-cia "in principio" (cf. Gen 1,1) come "in principio" (cf. Gv 1,1) trova il suo Plèróma, la Pienezza (cf. Gv 1,16) nel Verbo incarnato.
E così, rigettando ogni tentazione di squalifica, di sottovalutazione ignara, di rifiuto dell'antico "gnosticismo" eretico (da Marcione ai giorni nostri), si deve accettare il seguente fatto incontrovertibile: solo nell'A.T.
109

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
è dato di contemplare la profondità storica totale, avvolgente, dell'unica Oikonomia della grazia e dell'amore divini, della Bontà divina sempre larga nel donare. È il Progetto divino totalmente svolto ed attuato ormai dal Padre mediante il Figlio con lo Spirito Santo. Così che la sua attua-zione, la Vita del Verbo incarnato, il Signore nostro risorto per la Potenza dello Spirito Santo, implica di conoscere in modo preciso, attuale, conti-nuo, il Progetto stesso. Poiché è stato divinamente attuato solo questo Progetto, non altri. E chi vuole conoscere l'Attuazione deve risalire al Progetto. Come chi vuole conoscere il funzionamento di un motore, per usare un paragone volgare ma efficace, deve conoscere il suo "progetto", la disposizione di ogni suo elemento. E così perdere l'A.T., sia per mali-zia eretica (i "marcioniti" di ogni epoca, vivi ancora oggi nel disprezzo dell'A.T. e nel suo rifiuto, e presenti in tutte le Chiese), sia per satanico antisemitismo, sia per ignoranza crassa, è una catastrofe spirituale. Quale Promessa-Progetto, per sua natura stessa l'A.T. è:
- la Parola storica: enuncia, annuncia e svolge il primo compimento, laprima attuazione di Dio nella storia del suo popolo santo, popolo dell'unica alleanza fedele e perenne;
- la Parola profetica: è il primo Parlare di Dio agli uomini nella storia,ed anche la prima risposta nella storia degli uomini al loro Signore;profezia che in molte sue parti deve avere ancora adempimento (ades. il raduno di tutti i popoli nella pace del Regno di Dio, il Convitouniversale messianico nell'abbondanza della grazia, i "deli nuovi ela terra nuova", etc.). È Parola sempre efficace di quanto contiene;
- la Parola sapienziale: nella consapevolezza, talvolta dolorosa, chel'Amore nuziale si annuncia già, e comincia a venire in mezzo al popolo santificato, negli abbozzi delle prime forme ed esperienze, alcune delle quali sono di profondità sconvolgente, cf. il Cantico (che èpropriamente un'allegoria profetica sapienziale).
C) I Salmi
II Salmo, questo prezioso perenne abbagliante intervento orante del-l'A.T. nella divina Liturgia, preghiera perenne della Chiesa, si pone qui nel suo uso liturgico come il "canto dello Sposo" posto sulla bocca della Sposa. Esso è posto in preciso rapporto funzionale con la Parola letta (Pwkéimenon) e con l'Evangelo proclamato (l'Alleluia), e poi con l'unica santa Mensa della Parola e dei Misteri sacrificali ricolmi della Potenza dello Spirito santo (Koinònikón). Dunque, in vista evidente con la comunione triplice, gioiosa e trasformante al "triplice Corpo" del Signore: la sua Parola-Cibo, i Misteri del suo Corpo e Sangue pre-ziosi, la sua Chiesa corpo.
no

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
II Salmo così canta, acclama, loda, rende grazie, implora, celebra il Signore Risorto prima, durante, dopo la sua Parola. Esso aiuta in modo determinante — se fosse spiegato al popolo, ma forse anche al clero... —la contemplazione profetica e sapienziale del Mistero celebrato "og-gi qui per noi".
D) Z/Apóstolos
Nella Liturgia bizantina si tratta in pratica, sotto il nome antico di Apóstolos (conosciuto anche dai Siri: Slihè', o Slihà', Apostoli, o Apo-stolo), degli Atti, dell'epistolario di Paolo, quelle degli altri personaggi apostolici o "epistole cattoliche". Per vicende storielle oggi da ridiscu-tere, l'Apocalisse, considerata come ispirata, non fa parte delle Letture bibliche bizantine.
Ora, l'Apóstolos sta in stretto nesso funzionale da una parte con l'E-vangelo, e dall'altra con l'A.T. (quando si leggeva). Esso riporta infatti l'unica testimonianza autentica e veridica della fede della Chiesa degli Apostoli, che ha sperimentato Cristo Risorto con lo Spirito, dal Battesimo del Giordano all'Ascensione e alla Pentecoste. È testimonianza storica, mentre noi viviamo tale testimonianza nelle fede ed en Mystèriò, nel Mi-stero, sotto forma di esso. La fede sperimentata degli Apostoli è unica. È la nostra fede. Noi non ne abbiamo un' "altra". Né vogliamo averne. Senza gli Apostoli, nulla sapremmo del Signore Risorto con lo Spirito e della sua Chiesa: del Figlio di Dio nato dalla Madre di Dio ad opera dello Spirito Santo, vissuto, nascosto, e poi mostratosi nella vita pubblica, battezzato, trasfigurato, crocifisso, sepolto, risorto, visto, ascoltato, palpato (cf. qui 1 Gv 1,1-4), l'unico che dona lo Spirito ed invia i discepoli al mondo; e della Chiesa Una Santa, diffusa sulla terra per portare l'Evangelo e lo Spirito, e la sua dottrina di salvezza, e la sua missione al mondo.
Anche VApóstolos quale Parola della fede divina testimoniata, è:
-Parola storica: è esperienza storica, dottrina storica ispirata dallo Spirito Santo per gli uomini;
-Parola profetica: è annuncio sempre nuovo, sempre giovane, sempreefficace al mondo, dottrina del Mistero divino che è Cristo con loSpirito Santo;
-Parola sapienziale: che mostra i momenti ed i modi dell'Amore divino nuziale incarnato unitivo, in corsa verso l'eternità per gli uomini.
E) L'omelia è celebrare Cristo Risorto
L'omelia è liturgia, celebrazione, atto di culto dovuto, annunciato dalla dossologia iniziale e da quella finale. Non è un "di più", un lusso, che si può omettere. È mistagogia del popolo, che lo porta al culto.
in

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
Per la sua eccezionale importanza, si deve riservare all'omelia una considerazione a parte, vedi più sotto.
5. Il Simbolo della fede battesimale
Esso fu introdotto nella divina Liturgia verso la fine del sec. 5°, in circostanze di gravi tensioni tra le Chiese in Oriente. La giustificazione di tale pratica sconosciuta ai Padri, fu che per prendere parte degna-mente ai Misteri divini occorre prima professare la fede ortodossa.
Va rilevato qui, senza spirito di gratuita polemica, che secondo Paolo la fede divina si esprime mangiando il Pane e bevendo la Coppa, an-nunciando così "la Morte del Kyrios" Risorto, "finché venga" (1 Cor 11,26), dunque le realtà ricevute con l'iniziazione battesimale: Passio-ne, Morte, sepoltura, Resurrezione, Ascensione, Intronizzazione, Glori-ficazione, permanente Intercessione per noi, Dono dello Spirito Santo che procede dal Padre, ed infine la Venuta finale. A guardare bene, si ha qui anche lo schema della santa Anafora, in specie della sua anam-nesi storica, sacrificale, offertoriale, ossia una specie di ripetizione (un doppione?).
Inoltre, il Simbolo battesimale è lo schema entro cui i principii della fede sono piano piano insegnati ai catecumeni. La varietà dei Simboli dipende dalle Chiese locali. Le quali su una struttura sensibilmente identica, organizzata su 3 "articoli" relativi al Padre (in breve), al Figlio (per esteso) ed allo Spirito Santo (le opere dell'attuazione), potevano accentuare l'uno o l'altro aspetto. Per sua natura stessa il simbolo di fe-de non è affatto sufficiente per contenere sia pure in schema l'espres-sione per quanto possibile completa della fede, nonostante i tentativi ri-petuti in modo monotono, fino ad oggi, di imporre tale schema, forzan-dolo poi per introdurvi altri aspetti dottrinali, proprio quelli sui quali la Chiesa antica era reticente verso i catecumeni che non avevano ancora sperimentato i Misteri. Insomma, il Simbolo è catecumenale, non è mi-stagogico, ossia completo.
Esso esiste nella Divina Liturgia, perciò deve essere utilizzato nei suoi elementi, utili per accentuare aspetti del Mistero celebrato: Crea-zione, Incarnazione verginale, Evento di Cristo, Regno Eterno, la Ve-nuta all'ultimo dei tempi, l'opera dello Spirito nell'Incarnazione, sui Profeti, nella Chiesa, che per opera costante dello Spirito è Unica Santa Cattolica Apostolica, è portatrice del battesimo (= iniziazione, nel lin-guaggio dei Padri e già del N.T.), della remissione giubilare dei peccati, l'attesa della "resurrezione comune", della Vita eterna.
Il resto, ed è il grande impegno della Chiesa, è oggetto della costan-te mistagogia al popolo santo.
112

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
6. Uaspasmós, il saluto di pace
Uaspasmós, il "saluto" della pace conseguita, vissuta, scambiata, è di origine apostolica. Esso nelle prime Comunità si configurava come il philèma hàgion, il bacio santo, che è il saluto nel Signore di tutti i suoi fedeli, autorità e popolo. Lo raccomandano gli Apostoli, quale "segno" d'ammissione a partecipare ai Misteri. Così fin dall'inizio, Paolo in 1 Tess 5,26: "salutate (aspàsate) tutti i fratelli con il bacio santo"; 1 Cor 16,20: "salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo"; 2 Cor 13,12: idem; Rom 16,16: idem. E Pietro: "salutatevi gli uni gli altri con il bacio della carità, agape" (1 Pt 5,14). Come si vede, l'epistolario apostolico pone questa raccomandazione come conclusione del messaggio inviato dagli uomini che fondano e reggono le sante Chiese di Dio.
In sostanza, i fedeli sono resi unanimi dall'ascolto della Parola divi-na, confermati in questo dall'omelia, poi riaffermano la loro confessione di fede, e quindi in vista della partecipazione ai tremendi Misteri, nella carità totale, Yagape, con Vaspasmós dimostrano di essere pronti a rice-vere ogni abbondanza di grazie, avendo rimosso ogni impedimento.
Anche questo è rispondere alla Resurrezione che aprì finalmente l'effusione della divina Carità dello Spirito Santo. Vedi il Doxastikón che chiude il Canone pasquale.
7. La santa Anafora
Anche quando il tema di una celebrazione sembrerebbe autonomo, il che però non è mai, come ad esempio nelle feste della Madre di Dio, degli Angeli, del Precursore Giovanni il Battista, dei Santi, della Chie-sa, la santa Anafora forma e si pone come il perenne rinvio al Mistero globale del Signore Gesù Cristo, con la Resurrezione al centro. In spe-cie l'Anamnesi svolge questa funzione centrale ed essenziale. Si può scorrere così lo schema del'Anafora di "tipo antiocheno" in uso nella Chiesa bizantina, in cui la successione dei momenti è una sintesi mira-bile, con una logica teologica stringente. È sempre utile avere davanti uno schema corsivo, e discorsivo.
- Dialogo del celebrante con il popolo (cf. Col 3,1-2), esortazione reciproca a stare attenti ed a concentrarsi sulla grande Prece;
- Theologia: celebrazione di Dio Padre, facendo anamnesi, benedizione, lode alla sua Persona, ai suoi titoli, alle sue opere mirabili, dallacreazione attraverso tutta la storia della salvezza, fino alla Redenzione operata nel Figlio con lo Spirito e la fondazione del Regno eterno;
- Introduzione al Trisàgion: Dio è lodato per l'eternità dalle schiere degli Angeli e dei Santi, e si chiede di essere ammessi alla medesimalode eterna;
113

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
- Trisdgion: l'"inno angelico" di Ap 4,8; Is 6,3; Sal 98,3.5.9; integratoda Efes 1,15-23, acclamazione gioiosa ed instancabile alla Trascendenza divina del Dio invisibile, lode che sale alla comunione conLui;
- Christologia: celebrazione di Cristo Signore nella sua Economia tragli uomini del tutto adempiuta: dalla Nascita al Battesimo, alla Trasfigurazione, alla proclamazione dell'Evangelo, alle opere nello Spirito, alla Croce salvifica, alla Resurrezione ed Ascensione gloriose, alDono dello Spirito, alla creazione della Chiesa affidata agli Apostoli,alla santità effusa dallo Spirito Santo. Di essa il Signore ha lasciato aisuoi discepoli "questo Memoriale" nella Cena Prima;
- Narrazione della Cena che istituisce i Misteri. Nel N.T. si hanno for-mule varie, sia sinottica (Marco-Matteo), sia paolino-lucana; esistono anche altre formule, in Gv 6,53-58, in Ebr 10,5-18, non più in uso; discrete allusioni in Gv 17; lo stesso "Padre nostro" dalla Chiesa anti-ca era ritenuto preghiera consacratoria;
- Anamnesi storica, sacrificale offertoriale, strettamente connessa efunzionale con la seguente;
- Epiclesi, supplica al Padre per ottenere lo Spirito suo e del Figlio suifedeli presenti e quindi sulle sante Offerte. È il centro dell'ecclesiolo-gia, quella più vera, misterica eucaristica, che mostra gli effetti ultimi dello Spirito Santo. Egli è il Santificatore e Consacratore nel battesi-mo e nella confermazione, e già nell'acqua e nell'olio; nelle ordina-zioni, nel matrimonio; è YÀphesis, la Remissione dei peccati nel rito dei confessanti; è la dolcissima Unzione nel rito dell'Olio della pre-ghiera. Soprattutto però è Colui che creò dal seno verginale di Maria l'Umanità santa del Figlio di Dio, che battezzò e trasfigurò e pose sotto la sua guida divina lungo la sua Vita storica tra gli uomini, che Lo accompagnò sulla Croce (cf. Ebr 9,14), Lo resuscitò e glorificò e intronizzò alla Destra del Padre e divinizzò, sempre pronto dietro l'e-piclesi del medesimo Figlio al Padre, a scendere tra gli uomini, vero ed unico Hodègós dell' Oikonomia dei Misteri celebrati, che riempie con il Fuoco terribile del suo amore (cf. qui la Nota, dopo la Domeni-ca di Pentecoste). E qui massimamente è dato di vedere la mirabile attuazione del Disegno divino tra gli uomini: nella santa Chiesa che fa epiclesi, ma insieme è fatta dall'epiclesi.
- Grande Supplica ed Intercessione: sulla base dell'offerta sacrificale,dopo lo Spirito la Chiesa prega per la Presenza divina a tutte le necessità degli uomini. Si hanno qui 6 "canoni" in gironi concentricisempre più ampi: anzitutto per i presenti, "questa assemblea", che èla Chiesa locale celebrante tutto il Mistero, offerente tutta l'Offerta alPadre nello Spirito, costitutivamente dunque "tutta la Chiesa qui presente", in comunione con tutte le Chiese sorelle, formando l'Una
114

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
Santa; poi per la sacra Gerarchia, il clero ed il popolo fedele nel mondo; poi per tutti i viventi e per le loro necessità; seguono 3 canoni per i passati alla Vita eterna, ossia per la Chiesa celeste unita alla Chiesa terrena, affinchè "la gloria e la gioia" della prima crescano al-l'infinito; e così si prega "per" la Madre di Dio, gli Apostoli, Giovan-ni Battista ed i Precursori dell'A.T., i Padri nostri, per i gloriosi Mar-tiri, per i Vescovi della Chiesa locale; poi per tutti gli altri Santi; infi-ne per i fedeli battezzati defunti e per tutti i trapassati che il Cuore di Dio Padre conosce;
- Dossologia finale: al Padre, che ricevuta l'offerta dei divini trasfor-manti Misteri mediante il Figlio nello Spirito li ha ricolmati per l'o-perazione santificante dello Spirito nella Presenza indicibile del Fi-glio glorioso, si innalza la proclamazione della lode e della gloria unanime di tutti i presenti, "la Chiesa", per i secoli eterni. L'Amen dei fedeli qui è il potente sigillo di tutti gli animi, "affinchè unanima-mente con unica bocca glorifichiate il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo" (cf. Rom 15,6), tipica dossologia finale. Adesso la Chiesa può procedere alla comunione ai Misteri, come già ha comu-nicato al Mistero della Parola, questo Pane di Vita.
La santa Anafora fu composta dall'origine per essere cantata, la for-ma più solenne della proclamazione. Essa con i Salmi ed il "Padre no-stro" forma il nucleo sostanziale della Liturgia della Chiesa. Per questo, come i Salmi ed il "Padre nostro" è materia obbligatoria di mistagogia al popolo battezzato e confermato, "iniziato a così grandi Misteri". De-ve essere sempre richiamata dall'omelia e deve essere riproposta ai fe-deli anche come eccellente "lettura spirituale".
8.1 riti di comunione
Essi formano un complesso denso di gesti e di formule, tra i quali i più antichi sono la recita comunitaria del "Padre nostro", la "frazione del pane" con la "segnazione della Coppa" e l'immissione di una par-cella di Pane in essa, la "preghiera d'inclinazione", la comunione con il tipico canto salmico che l'accompagna.
a)II "Padrenostro"La preghiera del Signore, con l'invocazione "Padre nostro" richiama
insieme il titolo del battesimo: "'Abbà'ì,Padre!" (Rom 8,15; Gai 4,6), e l'alleanza con il "nostro": "Tu sei il Padre nostro — noi siamo i figli tuoi", l'essere diventati figli nel Figlio, il "Primogenito di molti frtelli" (Rom 8,28-30). Con le 3 + 4 richieste durante "questa" celebrazione, si innalzano 7 epiclesi al Padre affinchè come già avviene nel cielo, av-
115

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
venga e si operi sulla terra: per il Nome, il Regno, la Volontà, nella ri-spettiva santificazione eucaristica, l'inaugurazione e prosecuzione re-gale nel Convito, il farsi della Volontà pregata con il medesimo 'Abbà ' dal Signore al Getsemani (Me 14,36) e sulla Croce (Le 23,46); per il triplice pane "quotidiano", quello che "giorno per giorno" ci porta ver-so il Padre, ed è il pane del corpo, il Pane della Parola ed il Pane della Mensa dei Misteri; per il dono del Giubileo divino dello Spirito Santo, quello de\Y àphesis, la "remissione", l'abbuono totale generale di ogni peccato, promesso (cf. Le 4,18-19) e realizzato con la Resurrezione (cf. Gv 20,19-23) per tutte le nazioni, Giubileo accettato realmente solo se scambiato con i fratelli "debitori"; affinchè il Signore non permetta mai che entriamo nella tentazione in modo da non poterne più uscire; per la liberazione dal Male, personificato nel Maligno ed in ogni forma di male personale. E di tutto questo i Misteri celebrati donano l'attuazione dello Spirito Santo.
b) Lafrazione del Pane e la sua commistione nella Coppa"Spezzare il pane", gesto sovrano del padre di famiglia per tutti, ri-
sale, come tipicamente ebraico e biblico, al Signore stesso, sia nelle moltiplicazioni dei pani e dei pesci (Mt 14,19, e par.; 15,36, e par.), sia, come realizzazione plenaria della Cena del Regno, nella notte della sua consegna alla morte (Mt 26,26, e par.). Così la Chiesa degli Apostoli proseguì questo gesto altamente simbolico (At2,46; 20,7.11; 27,35, an-che come semplice mangiare; 1 Cor 10,16; 11,24, della Cena del Si-gnore da proseguire fedelmente), ed anzi la klàsis toù drtou, spezzatura del Pane, indicò, tra i tanti denominativi, la celebrazione eucaristica (At 2,42). Infatti il Signore "si fece conoscere ad essi nello spezzare il Pa-ne" ad Emmaus (Le 24,35). E "raccogliere i frammenti del pane", dopo le moltiplicazioni, significa che la Chiesa deve seguitare a moltiplicare il Pane per sempre, in fondo unico miracolo che sotto forma di Parola, di soccorso ai poveri e di divini Misteri sa sempre ancora operare (cf. Mt 14,20; e par.; 15,37, e par.). La Chiesa ancora seguita il gesto del Signore, per cui il celebrante proclama: "È smembrato e distribuito l'Agnello di Dio, lo smembrato ma non diviso, il sempre mangiato e mai esaurito, bensì santifica chi ne partecipa".
Una parcella del Pane santo è introdotta nella Coppa venerabile, quale segno dell'unità dei "santi Segni". Spezzare il Pane biblica-mente non significa tanto il sacrificio — questa è la funzione della Coppa e del Sangue —, quanto l'Uno del Corpo di Cristo che si frammenta per tutti, affinchè i tutti, dispersi, nel sacrificio siano re-datti in "unico Pane": 1 Cor 10,16-17, testo che non ammette altre interpretazioni. Il Cibo divino rende tutti Uno in Cristo con lo Spirito (1 Cor 12,13).
116

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
II seguente rito dello zéon, di cui si parlerà in seguito, viene a "signi-ficare" con il simbolismo del Fuoco dello Spirito, che l'epiclesi nella sua totale efficacia consacratona si rende adesso evidente nel comuni-care la trasformazione che "l'ardore (zésis) di fede, ripiena di Spirito Santo" è realtà perenne. Sul rapporto Fuoco-Misteri divini, vedi la Nota dopo la Domenica di Pentecoste.
e) L'invito supremoII celebrante invita il diacono a comunicare, con l'imperativo pró-
selthe. Ma già prima nell'omelia deve invitare tutti i presenti a parteci-pare ai Doni della santa Mensa. È una delle parti irrinunciabili dell'o-melia mistagogica celebrativa.
Adesso il diacono, ostendendo la santa Coppa, sulla Porta santa chiama il popolo: "Con timore di Dio, fede e carità, prosélthete, venite avanti". La famiglia è radunata tutta intorno al Cibo divino comune.
d) Comunicare cantando di gioiaI Salmi hanno anche la funzione di accogliere con gioia sia la pro-
clamazione della divina Parola, sia la partecipazione alla santa Mensa. Se il Koinónikón, "canto della comunione", oggi nelle rubriche è indi-cato come un versetto di un Salmo, in genere riservato alla comunione dei celebranti, mentre per il popolo si può reduplicare o si può cantare un altro testo, si deve pensare all'origine. Nelle grandi cattedrali, in funzione delle quali si era organizzata la celebrazione, la comunione di molti concelebranti e della massa di popolo doveva essere accompa-gnata da un canto protratto, ossia un intero Salmo con Antifona e ver-setto. Il Koinónikón in genere rappresenta l'Antifona, e si ripete even-tualmente senza i versetti necessari.
9. La conclusione ed il rinvio
L'assemblea santa prega ancora dopo la comunione. Il celebrante con l'epiclesi celebre "Salva, Dio, il popolo tuo, e benedici l'eredità tua", che è Sal 27,9a, una "Supplica individuale". Il diacono con la pic-cola litania, a cui il popolo risponde "Kyrie, eléèson ". Poi il celebrante, o uno dei concelebranti con la "Preghiera opisthàmbonos" davanti la santa icona del Pantokrdtòr che si mostra sull'iconostasi accanto alla Porta santa. Poi con la benedizione del popolo e la formula "La benedi-zione del Signore e la sua Misericordia vengano su voi".
Infine, YApólysis, o "scioglimento", il congedo del popolo, la cui for-mula è epicletica, e che può contenere l'accenno alla festa del giorno.
I testi qui usati sono tutti centoni e reminiscenze bibliche. Essi fanno parte del Tesoro della Parola che la celebrazione fa discendere sui fedeli.
117

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
10. La "selezione per accentuazione"
I contenuti del Lezionario dei divini Misteri sono il dono dello Spi-rito Santo. Annunciati a partire dall'Evangelo e celebrati, provocano l'ascolto qualificato, inizio della conversione del cuore, della fede, della speranza, della carità. Essi portano così alle realtà del battesimo e della confermazione, di continuo vissuti e celebrati nel Convito divino, ed alla vita della Chiesa in ogni suo aspetto. E viene dal Lezionario, così, la continua efficace anamnesi del Mistero globale, per la continua mistagogia della Chiesa. In tutto questo lo Spirito svolge di continuo la sua operazione misteriosa ma potente ed efficace di Guida divina.
Lo Spirito rivela Cristo, che rivela il Padre e ci riporta a Lui. Nel ri-velare Cristo Risorto, lo Spirito dona la visione di fede, visione globale e permanente: il Signore Risorto e glorioso nello Spirito, intronizzato alla destra del Padre suo, che di continuo dona lo Spirito del Padre suo, sempre presente ai suoi fedeli radunati nel Nome suo (cf. qui Mt 18,19-20), sempre pronto per la seconda e gloriosa Venuta, il suo Ritorno.
Questa visione tuttavia non sarebbe troppo "globale", se non com-prendesse tutta la Rivelazione divina che lo Spirito ci dona del Signore nostro, perciò anche quella della sua vita storica, e della lunga Prepara-zione dell'A.T. Come si vedrà, lo schema esemplare è quello dell'evan-gelo di Matteo, che guida la struttura del Lezionario e dello stesso An-no liturgico. La lettura, non ci si deve stancare di ripeterlo, deve andare dalla Resurrezione e Pentecoste, l'"Omega", a ritroso verso l'"Alfa": la Croce, la Vita pubblica, la Nascita, l'Annunciazione del Signore, la Preparazione dell'A.T. E sempre tenendo presente la globalità di questo Alfa-Omega, per sua natura non divisibile in parcelle autonome.
E però questa visione e contemplazione globale del Mistero dove es-sere opportunamente accostata con la mente ed il cuore adoranti. Per questo nella celebrazione e fin dai primi tempi, da sempre, si può dire, le Chiese usano la grande legge che convenzionalmente si può chiamare "selezione per accentuazione", grande legge del Lezionario Domenica per Domenica, Festa per Festa, feria per feria. In pratica, in una cele-brazione concreta, e non solo della Divina Liturgia, bensì anche degli altri Mystèria della Chiesa, con sovrana maestria la Chiesa sceglie un solo episodio della vita del Signore Risorto con lo Spirito, dagli Evan-geli; tale testo serve per così dire da "varco", da indice accentuante per entrare nella contemplazione di tutto il Mistero del Signore Risorto con lo Spirito Santo.
In sostanza, dopo la Resurrezione ed a causa della Resurrezione, noi così possiamo vedere il Signore, episodio dopo episodio, "mentre pas-sava Operante-il-bene" (At 10,38, già citato) per la potenza dello Spirito da cui era stato "unto" da parte del Padre (At 10,38-41). E in forza
118

CAP. 4 - RISPONDERE ALLA PAROLA DELLA RESURREZIONE
della celebrazione, come battezzati e confermati siamo chiamati a farci sempre più fedeli discepoli di lui, seguendolo a passo a passo, come gli Apostoli, lungo la sua via sovrana ma umile, quella che porta alla Cro-ce ed alla Resurrezione, vivendo intensamente tutta la vita del Signore.
Propriamente, nell'ordine coerente della Vita storica, il Battesimo al Giordano è l'inizio della vita pubblica del Signore, come l'intronizza-zione alla destra del Padre dopo la Resurrezione con lo Spirito è il compimento, con la presenza continua del Risorto ai discepoli (cf. qui M 3,13-17, e 28,20).
Al Battesimo il Signore riceve dal Padre lo Spirito, con l'investitura messianica totale. Il Signore completa la missione battesimale della quale riceve la "Confermazione" alla Trasfigurazione, con la Croce. Questa è il suo Battesimo, la sua Coppa: cf. qui il lógion di Me 10,38-39. Così che il Giordano indica ed inizia, e la Trasfigurazione "confer-ma" la Croce, e dunque la Resurrezione.
Il Padre al Battesimo ed alla Trasfigurazione a) con lo Spirito inve-ste e riveste l'Umanità del Figlio, sul quale riposa in eterno lo Spirito; b) con titoli; non quelli divini ed eterni, tutti riassunti nel titolo di "Fi-glio mio", e così Sapienza Potenza Icona Verbo, bensì quelli messianici e nella storia, come il Diletto, il Re, il Pastore, il Resto d'Israele, il Maestro, il Profeta, il Medico, il Servo sofferente regale, il Sacerdote, lo Sposo, il Giudice dalla Bontà divina; e) gli affida le "opere del Pa-dre" o "opere del Regno", che consistono principalmente nell'Evangelo e nei "segni" che lo accompagnano, in vista del culto al Padre.
Con la "selezione per accentuazione", nell'episodio evangelico oggi qui proclamato e celebrato, appaiono precisamente in azione la Perso-na, i titoli e le opere del Signore con lo Spirito, con più o meno ampia rappresentazione secondo la pericope, e sempre nell'interpretazione che parte invariabilmente dalla Resurrezione e dal dono dello Spirito. Ecco la stretta necessità di tornare costantemente alla vita storica del Signore Risorto con lo Spirito, a cui del resto, come si vedrà, egli ri-manda sempre, quale rinvio a realtà irrefragabili, vere e vivibili.
Nella santa Anafora, ogni volta e senza mutamento si riassume la sintesi vitale globale del Mistero. Qui la. "selezione per accentuazione" è di nuovo ricomposta in mirabile unità celebrativa.
Così il Lezionario con le sue strutture e con la sua tecnica offre tutti i contenuti della celebrazione della Chiesa, e della sua mistagogia con-tinua, a cui si deve sottoporre tutto il resto.
Occorre perciò una conoscenza corsiva del Lezionario, uno studio accurato, un'esplorazione minuta, a fondo, avanti ed indietro, a prefe-renza di ogni altro approfondimento di aspetti parziali della dottrina della Chiesa, pur necessari e da non trascurare. Occorre amare il Lezio-
119

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
nano quale dono incalcolabile che la Chiesa si da. Ed occorre farlo co-noscere ed amare da tutto il popolo di Dio, in specie però avviare i gio-vani alla sua pratica e consuetudine continua.
E decidersi a farne il "libro della lettura" quotidiana, la "lettura divi-na della Bibbia". Ossia il testo sul quale contemplare, in modo comuni-tario e personale, le meraviglie del Regno a cui siamo destinati, e che in qualche modo, come "pregusto" già celebriamo gioiosamente come Chiesa, la Sposa, la Una Santa unita al suo Signore Risorto. Questo Li-bro fondamentale avrebbe anche l'opportunità di eliminare dalla vita di tutti i fedeli tanta pessima letteratura pseudospirituale che corre tra le mani di troppi di noi.
Il Lezionario da anche la possibilità della revisione di vita proprio delle realtà del Mistero che di continuo celebriamo. Se la celebrazione della Chiesa è il culmine e la fonte alla quale essa tende e dalla quale deriva la sua vita soprannaturale, allora non occorre trovare fuori di essa una "spiritualità" costruita da ideologie religiose.
Invece qui si deve parlare di una "spiritualità della Festa continua".Il 1° Gennaio del 387, da poco consacrato presbitero, dal suo santo
Vescovo Flaviano il giovane straordinario, Giovanni Crisostomo, è au-torizzato a predicare al posto del suo Gerarca. Egli allora tra l'altro dice ai fedeli: "e però sempre tu potrai festeggiare (heórtàzein)", "per tutta l'esistenza, eseguire la festa (heórtè) proposta". Come esorta l'Aposto-lo Paolo, "se dunque possiedi la coscienza pura, tu hai una festa (heorté) sempre nutrita da buone speranze, e facendo gioia per l'attesa dei Beni futuri" (S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Horn, in Kal. II, in PG 48,955-956).
120

CAP.5 LA RESURREZIONE
PERVADE L'ANNO LITURGICO
II N.T. non conosce più il sistema festale ebraico, racchiuso nel sim-bolismo dell'anno, un ciclo naturale che rinvia all'inizio, alla crescita, alla fine. Conosce esclusivamente il Giorno del Signore Risorto, che rovescia ogni dinamismo, cominciando la settimana, e non terminandola come il sabato ebraico. La vita cristiana così è pervasa dalla gioia della Resurrezione, e celebra solo il Signore Risorto, con respiro dome-nicale, e con una forte tensione all'adempimento parusiaco.
Dopo la metà del sec. 2° si ritorna alle "feste", e via via dentro il sec. 4° è praticamente ordinato ed organizzato l'"anno liturgico", com-posto della linea delle Domeniche qua e là interrotta dalle "feste". Non è l'ideale teologico e pastorale, poiché la centralità permanente e costi-tutiva della Resurrezione di continuo è posta sullo sfondo per trarre in evidenza un aspetto del Mistero di Cristo (cf. la "selezione per accen-tuazione"). Comunque, l'Anno liturgico da allora ha la funzione di in-quadrare l'intera vita cristiana, l'intera spiritualità cristiana.
A patto però di considerare la legge suprema della vita cristiana: che si svolge "dopo — a causa — a partire dalla Resurrezione".
1. "Dopo a causa a partire dalla Resurrezione": il quadro generale
I fedeli cristiani vivono dunque, è ovvio, dopo la Resurrezione, che è l'Evento, il momento divino più pieno della vita del Signore nella sua Umanità santa, e se di Lui, anche momento nostro (cf. Rom 8,11). Ma i medesimi fedeli vivono a causa della Resurrezione, alla quale lo Spirito li sta preparando giorno per giorno. Poiché la Resurrezione del Signore con lo Spirito è la causa di tutto.
Qui il grido paolino, assolutamente singolare, si pone ogni giorno come la parola d'ordine:
Se poi Cristo è predicato che fu risvegliato dai morti,come dicono tra voi alcuni che la resurrezione dei morti non esiste?Se la resurrezione dei morti non esiste,neppure Cristo fu risvegliato.Ora, se Cristo non fu risvegliato,vuota è dunque la predicazione (kèrygma) nostra,vuota anche la fede vostra.Noi siamo trovati allora anche come falsi testimoni di Dio,poiché noi testimoniammo contro Dio che Egli risvegliò Cristo,che invece non risvegliò,
121

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
se però i morti non sono risvegliati.Se infatti i morti non sono risvegliati,neppure Cristo fu risvegliato.Se Cristo non fu risvegliato però,vuota è la fede vostra,voi ancora state nei peccati vostri,dunque anche i dormienti in Cristo perirono.Se in questa vita noi siamo speranti solo in Cristo,noi siamo i più da compatire di tutti gli uomini.Ora, però Cristo fu risvegliato dai morti,Primizia dei dormienti! (1 Cor 15,12-17).
Precisamente qui, nella Resurrezione operata dal Padre con lo Spiri-to — e del resto operata da Cristo stesso per la sua divina potenza (Gv 10,17-18) — noi troviamo l'unico fondamento totale, l'unico significato globale della nostra vita cristiana, per intero ed ogni giorno.
In effetti, la Resurrezione del Signore è il 1° grande Giorno della Pentecoste, il cui 50° grande Giorno — 50 giorni considerati un solo "giorno", come totalità di Dio e del suo Dono — è elargito agli uomini. Al 1° Giorno lo Spirito Santo prende in eterno possesso nuovo della Umanità del Signore, resuscitandolo "secondo le Scritture" (cf. qui 1 Cor 15,1-8). Lo Spirito del Padre rende dunque l'Umanità del Signore "Spirito vivificante": testo capitale in 1 Cor 15,45. Questo significa che da adesso lo Spirito del Padre e del Figlio è donato dall'unica Fonte inesauribile, dall'Umanità del Signore Risorto: testo capitale At 2,32-33. È il segno supremo del Disegno divino antico, che Dio non ha la-sciato cadere ma ha finalmente realizzato.
Infatti l'Adamo primo aveva ricevuto l'Amore del Soffio divino: Gen 2,7. Nella narrazione simbolica della Scrittura, è chiaro che avreb-be dovuto mangiare dell'Albero della vita, vivere della Vita divina da-vanti al suo Signore, e trasmettere questa Vita, il Soffio della Vita. Ma per disobbedienza non ne era stato capace, lo Spirito di Dio doveva via via ritrarsi dalla "carne di peccato" (cf. Gen 6,1-3). Come proclama la santa Anafora, il Signore non abbandona gli uomini, li segue, li "rias-sume". Così finalmente l'Adamo Ultimo, il Figlio di Dio incarnato, morto e risorto con lo Spirito Santo, trasfigurato in eterno nella sua Umanità, è capace di donare lo Spirito Santo agli uomini fratelli — il Capo, l'Adamo Ultimo al suo corpo, l'Èva Ultima, la Sposa, la Madre dei viventi, la Chiesa.
È una delle grandi leggi della divina salvezza la formula lapidaria paolina: "se a Lui — dunque anche a noi" (Rom 8,11). Quanto il Padre con lo Spirito Santo opera sull'Umanità del Figlio, che vi acconsente e collabora in pieno (cf. il Getsemani!), il medesimo con il medesimo
122

CAP. 5 - LA RESURREZIONE PERVADE L'ANNO LITURGICO
Spirito opera per la mediazione del Figlio su tutti noi. Il grande capito-lo, e difficile, di Rom 8 traccia la sintesi della "vita in Cristo" che è pre-cisamente la "vita nello Spirito" che ha resuscitato il Figlio di Dio: co-me ha resuscitato lui dai morti, al medesimo modo resusciterà anche noi. È il Disegno del Padre: la "resurrezione comune" (terminologia dei Padri), la "resurrezione della carne" (nel "Credo" simbolo battesimale della fede apostolica) è il necessario ingresso alla Vita divina, alla divi-nizzazione.
La Resurrezione del Signore è il totale nucleo possente, onnipotente, infinito della Pentecoste continua che giunge come l'oceano della Gra-zia dello Spirito su tutti noi, la Chiesa dei santi. In termini biblici, è la Parousia, la Presenza divina triadica per noi: del Padre mediante Cristo Risorto nello Spirito Santo. È specificamente anche la presenza del Si-gnore Risorto nella Chiesa, mediata sempre dallo Spirito, secondo la promessa di Giovanni (cf. i cap. 14-16). Una Presenza che è Manifesta-zione, cioè "teofania" continua di Grazia e di Sapienza nuziale.
Cristo Risorto con lo Spirito, rivelato dallo Spirito, è e resta in eter-no rivolto al Padre Invisibile, di cui è l'Icona perfetta nello Spirito San-to, e rivolto verso noi come questa Icona, ma Icona che mostra e dona la Bontà triadica indivisibile del Padre e sua e dello Spirito Santo. Poi-ché in Dio tutto è unico, salva la Triade delle sante Ipostasi, perciò uni-co è l'Amore ed unica è la Bontà.
"Come egli adesso è — Risorto —, così noi saremo — risorti —": è l'altra formulazione della legge della salvezza. E per pura grazia.
Con la Resurrezione si iniziano i tempi reali della salvezza, i "tempi ultimi", l'escatologia di Dio e nostra.
La necessaria, continua, paziente, amorosa mistagogia da condursi sul Lezionario deve tenere conto di tutto questo, e di quanto segue.
2. Dalla Resurrezione culto e santificazione nello Spirito Santo
Dall'inizio della sua vita pubblica, che è il santo Battesimo dello Spirito Santo, evidentemente senza trascurare "gli anni oscuri di Gesù", l'esistenza stessa del Signore si dispone come un'oblazione continua di amore, al Padre nello Spirito Santo. Essa storicamente avviene come l'offerta sacrificale perenne totale di sé, i cui episodi significanti massi-mamente sono il Getsemani e la Croce. La vita del Signore è tale, che suo "cibo è fare la Volontà del Padre" suo (cf. qui Gv 4,34), e la sua of-ferta immacolata avviene "nello Spirito eterno" (Ebr 9,14). Tutto questo è l'esercizio del Sacerdozio supremo del Signore, a cui è stato abilitato dallo Spirito Santo al Battesimo e confermato nella Trasfigurazione.
Come a qualcuno sembrerà strano, il culmine eterno di questo Sa-cerdozio nello Spirito Santo sta tuttavia nella Resurrezione, Ascensio-
123

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
ne, glorificazione, intronizzazione alla destra del Padre. Poiché solo con la Resurrezione, che è l'accettazione che il Padre opera dell'obla-zione perenne del Figlio nello Spirito Santo, il Sommo ed eterno Sacer-dote "è sempre Vivente per intercedere in favore di noi": Ebr 7,25. Il Padre accetta la continua oblazione "nello Spirito eterno", e solo a tale sacrificio conferisce efficacia eterna. L'ingresso del Signore Risorto al Padre con la sua Umanità, nell'Ascensione, prolunga perciò l'esercizio del Sacerdozio divino quale culto e santificazione eterni, cosmici, esca-tologici, un perenne atto di amore filiale. L'epistola agli Ebrei di tutto questo è il singolare documento dalle visuali straordinarie, che mostra-no una qualità nodale del Signore quale "Sommo Sacerdote misericor-dioso e fedele" al Padre nello Spirito Santo e coestensivamente nello Spirito Santo a noi suoi discepoli {Ebr 2,17).
Al suo culto eterno di lode e di azione di grazie eterne, e di interces-sione (solo per tutto il "tempo della Chiesa"), con il dono dello Spirito Santo il Signore Risorto associa a sé la Sposa sua, diletta e redenta. E nei modi storicamente necessari, già visti: nel "tempo della Chiesa", nello "stile dell'uomo", nel "regime dei segni". È la divina Condiscen-denza che si china con amore e con premura sugli uomini, adattandosi ad essi, offrendo ad essi la Grazia dello Spirito Santo, da vivere restan-do uomini, ma perfetti.
La Resurrezione e la Pentecoste precisamente per questo inaugurano "il Regno di Dio" con potenza. Dopo l'evento della Pentecoste narrato in At 2,1-12, Pietro a nome degli Apostoli che hanno ricevuto il Fuoco divino parla ed annuncia la Resurrezione del Signore: At 2,14-36. Alla domanda dei presenti, compunti dallo Spirito Santo nel cuore: "Fratelli, che dobbiamo fare?" (v. 37), la risposta di Pietro è ovvia: la conversio-ne, il battesimo "nel Nome di Gesù Cristo" per la remissione dei pecca-ti, in sostanza "il Dono dello Spirito", e rispondere alla vocazione ge-nerale del Padre (vv. 38-39). La prima conseguenza, è la Comunità nuova, che ascolta la Parola degli Apostoli, partecipa al medesimo "spezzare il Pane", pratica la carità di gruppo e personale — e il Signore aumentava questa Comunità (vv. 41-47). È il Regno di Dio inaugurato finalmente nella pienezza dello Spirito Santo. Quello che chiediamo con il "Padre nostro".
La spiegazione misteriosa e reale di questo sta nel lógion difficile di Le 22,15-20. Il Signore nella Cena manifesta ai suoi il suo desiderio in-tenso ("di desiderio desiderai") di "mangiare questa Pasqua" con i suoi, e di bere con essi "questo succo della vite", e prima della Passione. Ma annuncia che mangerà e berrà quando tutto sarà adempiuto nel Regno di Dio, "quando il Regno di Dio verrà". Il segno dell'inaugurazione del Regno è solo il Convito nuovo del Pane e della Coppa, cominciato con la Pentecoste e che in eterno sarà solo reso perenne, l'anticipo misteri-
124

CAP. 5 - LA RESURREZIONE PERVADE L'ANNO LITURGICO
co terreno ne è come la condizione previa essenziale. Ora questo lógion nei secoli, per la sua difficoltà, è stato oggetto di diverse interpretazio-ni. Perfino gli stessi Padri ne hanno dato più interpretazioni. Su tutte, in una linea continua, patristica e medievale, spicca tuttavia l'interpreta-zione "ecclesiale". L'insistenza del Signore è: "mangiare questa Pa-squa" e "bere questa Coppa con voi", non con altri. Con i presenti, già con essi, non in astratto. Ma dopo l'Ascensione come potrà "mangiare e bere con i suoi"? In senso solo vagamente simbolico? La realtà biblica e semitica del Signore può essere evacuata nel vagamente "spirituale"? La linea ecclesiale dell'interpretazione ha compreso bene questa realtà: la Testa forma con il suo Corpo una persona vivente. La Testa nutre il suo Corpo con il suo stesso Mistero celebrato, e il nutrimento è lo Spirito Santo. Ma la Testa, per sé, nutrendo i suoi non resta denutrita. La spiegazione concreta dunque esige che si comprenda il senso vero: la Testa per così dire nel realismo del Mistero celebrato, si fa prestare la bocca ed il cuore dalle sue stesse membra, dalla Sposa sua, per poter mangiare il suo stesso Corpo e bere la sua stessa Coppa ricolmi dello Spirito Santo. Le membra battezzate per così dire sono, debbono essere sempre disposte a prestare la bocca ed il cuore al loro Signore, per l'unico Cibo divino.
Il Convito terreno e poi eterno è il culmine del culto e dalla santifi-cazione: il culto al Padre mediante Cristo Risorto nello Spirito Santo, la santificazione per la Chiesa a partire dal Padre mediante Cristo Risorto con lo Spirito Santo.
3. H grande mandato alla tomba vuota
La mattina radiosa della Resurrezione il Signore alla tomba ormai vuota per sempre, svuotata dalla potenza terrificante della morte nemica di Dio e dell'uomo (1 Cor 15,20; Ap 20,14), da alle Donne fedeli, le depositarle della rivelazione suprema del Risorto, il mandato perma-nente: "Andate — annunciate — fate memoriale". I testi, da leggere in-sieme, sono Me 16,7; Mt 28,7, cf. Le 24,9; poi Mt 28,7-8 ed ancora Me 16,7, cf. Le 24,9; infine, Le 24,6-8. Le Donne fedeli corrono dai disce-poli, annunciano il Signore Risorto, poi con i discepoli "fanno memo-riale", il cui contenuto è quanto il Signore aveva detto ed operato quan-do stava con essi.
La sera del medesimo "Primo Giorno", che tale resta per sempre, il Signore si fa presente ai suoi, dona ad essi la Pace e alita lo Spirito suo (medesimo verbo di Gen 2,7). Tale è il Giubileo dello Spirito Santo (Le 4,18-19 edIs 61,1-3; 58,1-11; 35,1-3) per tutti gli uomini: con l'invio fedele al mondo, come il Padre aveva inviato il Figlio con lo Spirito Santo. Dalla visuale di Giovanni, la Chiesa è creata, Eva Ultima dal-
125

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
l'Adamo Ultimo: Gv 19,30.34, e la sua vita divina sta in funzione: Gv 20,19-23.
La Domenica di Pentecoste — i Giorni grandi, il 1° e il 50°; ma tutti i 50 unico "Giorno grande" — Luca da resoconto del medesimo episo-dio, il Dono inconsumabile del "Fuoco che procede dal Fuoco", lo Spi-rito: At 2,1-12. E la Chiesa è descritta subito nella sua funzione divina: vv. 38-47 (cf. sopra).
Il mandato della tomba vuota è realizzato.
4. La Domenica, "il Giorno signoriale"
La Scrittura parla, senza mai confondere, del "Giorno del Signore", l'ultimo e terribile, annunciato dai Profeti come l"'ultimo dei giorni" (ad es. Os 3,5; Gioel 1,15, testo greco). Parla anche del "Giorno signo-riale", kyriakè hèméra, dove l'aggettivo kyriakè indica il Kyrios, il Si-gnore Risorto con lo Spirito (1 Cor 16,2; At 20,7;Ap 1,10). Nella Chie-sa apostolica era il giorno divino per celebrare il Signore, spezzare il Pane della Parola e del Convito, raccogliere le offerte per i poveri.
Questo "Giorno del Signore", del Kyrios, Domenica, per sua natura e fin dall'inizio porta dunque e contiene ed offre l'intero divino Miste-ro, quello rivelato in pienezza, consumato nella Croce e Resurrezione, che investe gli uomini per l'operazione onnipotente dello Spirito, e che nello Spirito si deve celebrare totalmente. La Domenica così porta con sé tutto 1'"universo simbolico" cristiano (cf. sopra).
La sua caratteristica è che è il Giorno unico del Signore Risorto, di-stribuito per così dire in tante Domeniche, in una linea continua sottesa dairEvangelo. Per sua natura la Domenica nelle Domeniche forma il "continuo celebrativo" autentico, nel "tempo della Chiesa" dalla Pente-coste al Ritorno del Signore, come una unica immensa azione celebrati-va gioiosa, scandita in ritmo temporale settimanale.
Per converso, ogni altra celebrazione, festiva o feriale, se vuole es-sere autentica celebrazione "del Signore Risorto", può essere solo un adattamento della Domenica, può essere solo comunque di sapore "do-menicale".
È sempre Domenica. In fondo Paolo lo aveva compreso bene, quan-do nella sua comunità di Corinto prescrive:
Infatti, ogni volta che voi mangiate questo Pane e bevete la Coppa, annunciate la Morte del Signore (= il Risorto!) fino a che Egli venga (1 Cor 11,26).
E, come si è detto, la sintesi storica, anamnetica, sacrificale, offerto-riale della santa Anafora non si stanca mai di rimemorare ogni volta la
126

CAP. 5 - LA RESURREZIONE PERVADE L'ANNO LITURGICO
Morte, la Resurrezione, l'Ascensione, l'Intronizzazione, la Parousia fi-nale del Signore.
5. La Domenica ed il resto del tempo
II N.T. non conosce altro che l'unico "Giorno del Signore Risorto", la Domenica, che celebra l'intero Mistero divino, senza frazionismi.
Verso il 170 d.C. in Asia Minore, come sembra probabile, "gruppi" cristiani particolari cominciano la strana pratica di celebrare la Pasqua annuale. Per fare questo, frazionano "la Pasqua" nella commemorazio-ne della Morte del Signore (quello che sarà poi il "Venerdì santo"), e poi della Resurrezione (quello che poi sarà la Notte "pasquale"). Roma e le altre Chiese resistettero inizialmente, poi cedettero, a patto che co-munque la celebrazione della Resurrezione cadesse la Domenica in rapporto alla luna di marzo. La celebrazione pasquale annuale formò il "ciclo pasquale" artificiale, con una preparazione quaresimale altrettanto artificiale — il cristiano è sempre pronto e convcrtito... — ed un "tempo pasquale" fino alla Pentecoste. Però tutte le Chiese operarono per salvare la "linea delle Domeniche", e per fortuna ci riuscirono.
Contrariamente a quanto normalmente pensiamo, la Notte della Re-surrezione non è affatto più importante di una "qualsiasi" Domenica. Viceversa, la Notte santa è "più solenne" per i segni che la arricchisco-no ed ingioiscono, e che sono segni domenicali normali. Ma essa so-stanzialmente è Domenica. Dalla Domenica del N.T. deriva, e come ti-pica "ideologia" tardiva di gruppi, non di tutta la Chiesa, l'idea di cele-brare il Signore morto e risorto una volta l'anno "con più solennità". Dalla Domenica del N.T. deriva dunque la Notte della Resurrezione, e, ancora più secondariamente, ogni altra festa pur grande della Chiesa e delle Chiese nel mondo.
Perciò non esiste nella pratica della Chiesa lungo i millenni una ce-lebrazione più importante della Domenica, checché dicano le rubriche, opera di uomini e soggette a note evoluzioni. Poiché la Domenica fa celebrare il Signore dalla Sposa sua, ed offre a questa come unico con-tenuto celebrabile tutto il Mirabile Mistero dello Sposo suo.
Tuttavia, va detto che la celebrazione della Notte detta santa è cele-brazione tipo. Il motivo non sta nell'annualità e dunque rarità. Il moti-vo vero sta piuttosto nel fatto concreto che la Notte della Resurrezione è una celebrazione domenicale completa:
a) con l'iniziazione dei catecumeni al Mistero;
b) con la proclamazione unica nell'anno — purtroppo! — della perico-pe della Resurrezione del Signore, VEvangelo della Grazia dello Spirito, durante la Divina Liturgia.
127

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
Tale era la celebrazione dei Misteri nei tempi apostolici, e tale si era mantenuta per 150 anni: come una Domenica totale. Poiché è sempre la Domenica.
Realisticamente, noi, che obbediamo in tutto alla Madre Chiesa, par-tiamo dall'attuale Notte della Resurrezione così riletta, e la consideria-mo come il modello: ogni Domenica dovrebbero aversi nella comunità radunata le medesime gioia ed intensità e solennità.
Dalla lettura dell'Evangelo della Resurrzione, "lettura Omega", si inizia infatti la lettura normale del Lezionario; e di fatto nel tempo pa-squale si ha uno degli inizi di tale lettura, e classicamente in tutte le Chiese si cominciano gli Atti.
Dall'iniziazione e dalla celebrazione dei Misteri con FE vangelo della Resurrezione di per sé trae il "tipo" la Domenica come tale. Molto meno importanza va data invece ai ed. "elementi cosmici": equinozi, primavera incipiente, natura rinnovata, e così via, sono solo adorna-menti poetici, in cui i Padri si esercitarono in pagine mirabili per bel-lezza, ma senza validità universale. Si trattava infatti solo dell'emisfero settentrionale, l'unico allora conosciuto. Si pensi solo che in Argentina ad esempio la Quaresima viene stagionalmente all'inizio dell'autunno, il Natale all'inizio dell'estate.
Ma la santa Notte della Resurrezione e le Domeniche implicano ri-gorosamente un tempo lineare ed in crescendo, nella contemplazione, come si è insistito e si insisterà, del Signore Risorto con lo Spirito lun-go la sua Vita storica, dal Giordano al Ritorno glorioso, mentre egli procede verso Gerusalemme dove si compie il Disegno del Padre, ed intanto annuncia l'Evangelo ed opera i "segni" della salvezza.
Il ciclo delle Domeniche perciò in tutti i Riti delle Chiese è "il tem-po" celebrativo per eccellenza, tempo esemplare lungo la "linea degli Evangeli" come furono scritti, senza interruzione. È il tempo della mi-stagogia esemplare, naturale, ininterrotta, in crescendo domenicale. Ogni Evangelo domenicale opera con la "selezione per accentuazione", dove, come si disse, un episodio evangelico introduce a tutto il Mistero della Parola divina, secondo il "continuo celebrativo" da una parte (dia-cronia), e la "linguistica celebrativa" o globalità, dall'altra parte (sin-cronia).
Quando le Chiese, in specie quella di Gerusalemme verso il sec. 4°, hanno ritenuto mistagogicamente di operare di più in "selezione per ac-centuazione" ideologicamente ordinata, si sono formati allora tempi ce-lebrativi particolari.
Ora, deve essere chiaro che Domeniche e tempi e feste sono invaria-bilmente risposte alla Resurrezione: anzitutto risposta ali'Evangelo della Resurrezione, in modo diretto, poiché dalla Resurrezione come si è detto tutto deriva; e poi, data la costruzione secolare dell'anno liturgi-
128

CAP. 5 - LA RESURREZIONE PERVADE L'ANNO LITURGICO
co che come ideologia pone al centro un'unica celebrazione della Re-surrezione, con Veglia solenne apposita, è risposta alla proclamazione annuale, benché purtroppo solitària, isolata, dell'Evangelo della Resur-rezione, dunque alla Notte santa come tale.
Esplorando la struttura dell'anno liturgico, questo risulta chiaro. La sua lettura teologica infatti deve essere disposta idealmente in questa li-nea:
a) Notte santa della Resurrezione;
b)tempo fino alla Pentecoste, che ne vive le conseguenze;
e) Settimana santa e grande, che vi prepara immediatamente, con il Tri-duo sacro;
d)Quaresima, che vi prepara a distanza;
e) Kyriakodrómion, il "Corso delle Domeniche" dalla Pentecoste finoal Triòdion compreso dove si presenta la Vita pubblica del Signore;
f) "selezione per accentuazione" di episodi della vita del Signore: lesue Feste, e le altre Feste, il Hedrtodrómion, "Corso delle Feste";
g)ogni giorno in cui si celebrano i Misteri divini.
Osservando qualche particolare, il tempo più antico è intorno alla Notte santa, e prima e dopo, con densità massima nella Settimana pre-cedente, detta "grande" in Oriente. Dalla metà del sec. 4°, con inizio a Roma, il ciclo natalizio. Un aspetto dunque dell'Unico Mistero del Si-gnore è estrapolato e sottolineato, "accentuato" con particolare venera-zione. In questi "tempi", tuttavia, la linea forte è sempre delle domeni-che.
Ulteriormente la "selezione per accentuazione" si dirige anche verso aspetti singolari, come isolati: le "feste" del Signore, come il Giordano, la Croce, la Presentazione al tempio, più tardivamente la Trasfigurazio-ne. Si tratta di "feste di idee": al Giordano, la "luce"; alla Croce la glo-ria; alla Presentazione 1'"Incontro", Hypapanté di Dio con il suo popo-lo; alla Trasfigurazione la Luce increata e la Gloria divina, Si tratta dunque di episodi fuori degli Evangeli domenicali.
La "selezione per accentuazione" si dirige anche verso eventi della Chiesa, come le feste domenicali delle grandi Sinodi.
Le feste della Madre di Dio, alquanto tardive, sono altra "selezione per accentuazione"; esse indicano l'adempiersi del Disegno di Dio
129

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
nella persona della Semprevergine, che è sempre e comunque adem-pimento "cristologico": Dormizione, Nascita, Ingresso al tempio, altri titoli.
Così, altra "selezione per accentuazione" si opera per il culto dei Santi. La Chiesa antica era molto severa, e si limitava agli Apostoli, ai santi e gloriosi Martiri di Dio, ai Vescovi della Chiesa locale. Dopo si sono aggiunte altre figure, come Giovanni il Battista, i Confessori, gli Angeli.
Infine, per dare una idea complessiva benché non esauriente, una "selezione per accentuazione" è la memoria dei nostri cari defunti, an-nuale o giornaliera, quale importante aspetto della vita del Corpo di Cri-sto. Si tratta comunque della "cristificazione", che è perciò, in stretta analogia, "pneumatizzazione" progressiva delle membra preziose di questo corpo, battezzate e confermate dallo Spirito: i santi ed i defunti, portatori in vita dello Spirito Santo, "pneumatofori", e nella Gloria del Padre ormai "potenti intercessori", secondo la profonda teologia biblica:
Perciò anche noi,tanto grande tenendo imposta su noi la nube dei Testimoni...nella pazienza corriamo all'agone propostoci,contemplando verso il Condottiero della fedeed il Consumatore di essa, Gesù,il quale invece della gioia a Lui propostasopportò la Croce, disprezzando la vergogna,e si intronizzò alla destra del trono di Dio {Ebr 12,1-2).
Ecco lo svolgersi del magnifico "tempo di tempi" che trae sostanza ed origine dall'unica festa, la Domenica.
6. Gli altri Misteri rispondono alla Resurrezione
Gli altri Misteri, oltre quelli divini della Mensa santa, sono risposte dirette alla Resurrezione del Signore, e ne applicano i diversi effetti.
Intanto va notato che infaticabilmente, e quasi senza accorgersene, la Chiesa inizia diverse volte la lettura celebrativa della Parola divina, che porta il Mistero di Cristo:
1) nella solenne Veglia del Sabato santo e grande che si prolunga per lanotte, e culmina con i divini Misteri, quando si comincia a proclamareGiovanni ed a leggere gli Atti;
2) nelle Domeniche che seguono la Pentecoste, fino dentro il periododel Triòdìon;
3) con la Quaresima.
130
L

Si tratta sempre di segni simbolici, che indicano la ricchezza e la va-rietà di tempi che provoca la Resurrezione e la sua celebrazione.
Il Mistero unico e globale del Signore durante l'anno si celebra in forme diverse e convergenti, delle quali la prima e primordiale, vera fonte delle altre, è la Mensa della Parola, del Corpo e della Coppa del Signore, e le altre sono i Misteri detti anche "sacramenti" (terminologia occidentale, derivata dal paganesimo romano).
Ai fini di quanto si sta qui trattando, va detto anzitutto che i Misteri sacramentali si celebrano comunque: a) in riferimento diretto e specifi-co ai divini Misteri; b) nel quadro globale e sintetico dell'Anno liturgi-co; e) almeno nell'intenzione, il loro momento migliore resta sempre la Domenica. Fuori di queste direttive, sarebbe solo una dispersione. Essi si collocano nel "tempo della Chiesa" che corre verso il suo compimen-to simbolico, e che appunto per questo si configura come una unica continua immensa celebrazione del Signore nello Spirito Santo per la Gloria del Padre e per la divinizzazione degli uomini fedeli in comu-nità.
Di questo si può visualizzare una specie di quadro:
a) l'iniziazione ai Misteri: per sé è normale nella Veglia del Sabato santo e grande, che è la collocazione originaria. Per trasposizione, si dovrebbe celebrare solo la Domenica. E si dovrebbe oggi stare attenti alnuovo fenomeno ormai esteso, per cui molti giovani e adulti chiedonola fede e il suo sigillo iniziatico, ed è sana norma dove possibile concentrare questi battesimi nella Veglia della Resurrezione. Inoltre, si deve osservare che strettamente parlando, quando si celebra l'iniziazioneai Misteri, anche di giorno feriale, si conferiscono ai battezzandi leRealtà divine proprie della Domenica con la sua anamnesi del Misterodi Cristo: Morte, Resurrezione, Ascensione, Dono dello Spirito, seconda Venuta. Iphótisthéntes, gli "illuminati" sono poi ammessi per la prima volta al Kyriakón Déipnon, alla Cena signoriale, del Signore Risorto (cf. Ì Cor 11,17-34);
b) le cheirotonie sacre sono normali alla Domenica, ed in cattedrale, secondo le norme. Il Vescovo e il presbitero hanno la principale funzionedi radunare il popolo per annunciare la Parola e convitare alla Mensanel Giorno del Signore;
e) la coronazione, celebrazione eminentemente ecclesiale, mai "priva-ta" (salvo i casi rigorosi contemplati dalle norme), è normale alla Do-menica, in cattedrale o parrocchia, quando tutta la comunità è radunata nel Nome del Signore;
d) la riconciliazione è normalmente funzionale alla celebrazione dei Misteri domenicali (anche festivi e feriali), ed è sempre memoriale ed
131

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
epiclesi della Bontà del Padre che dona ai figli suoi convertiti la grazia dello Spirito nella gioia di Cristo Signore Risorto;
e) l'unzione dei malati con l'Olio della santificazione sarebbe normale, se fosse celebrata adeguatamente e non in estremo, alla Domenica, du-rante i divini Misteri, in rapporto costante con la comunità radunata dal Signore, in funzione della Mensa comune a cui tutti partecipano.
Altri riti, si dovrebbero svolgere in modo analogo, almeno nell'in-tenzione, salve sempre le condizioni concrete che sorgono: così la dedi-cazione della chiesa, le consacrazioni monastiche.
Il quadro è e resta l'Anno liturgico, l'occasione il Giorno domenicale.
7. Le Ore sante
II discorso adesso va completato parlando della celebrazione delle Ore sante della Chiesa, la "liturgia laudativa". Infatti già si è accennato alla tecnica di lettura ideale della celebrazione nella sua interezza, che va operata "da Vespro a Vespro con i Misteri al centro". Anche le Ore, che con i Misteri ed i sacramenti, e poi l'Anno liturgico formano il complesso detto "Liturgia della Chiesa", è la classica, quotidiana ed inarrestabile risposta alla Resurrezione, in specie i suoi due "poli prin-cipali", il Vespro e le Lodi, non a caso dalla Chiesa dei Padri disposti come "ufficio cattedrale", da celebrarsi dunque con vescovo, clero e popolo (le altre Ore sono aggiunte monastiche e tardive, non origina-rie). In specie Vespro e Lodi celebrano dunque i grandi temi della sal-vezza, cantando Salmi e Tropari, leggendo la Parola, pregando e medi-tando; ed i grandi temi della salvezza hanno come centro naturale la Resurrezione e la Luce del Signore, il Dono dello Spirito, ossia la Re-denzione divina e il procedere dell'esodo verso la Patria celeste, nella supplica, l'azione di grazie e la lode adorante.
Il Vespro e le Lodi sono perciò raccomandati come "la preghiera della Chiesa". Il clero in cura di anime dovrebbe celebrarli ogni giorno con il loro popolo, e i Vescovi farsene severi promotori dandone l'e-sempio.
In conclusione, l'Anno liturgico, con la Domenica come momento sempre emergente, è lo svolgimento della "linguistica celebrativa" bi-blica e cristiana. Esso esprime tutto 1'"universo simbolico" cristiano portato dalla Parola divina che salva e che trasforma, immenso signifi-cato ed efficacia delle Realtà sante donate dalla divina Bontà agli uo-mini. La Parola, il Mistero celebrato, la Comunità di fede qui radunata oggi, i sacerdoti, i gesti, le parole, gli elementi naturali, gli oggetti sa-cri, gli edifici sacri, i tempi ed i luoghi sacri formano nella celebrazione
132

CAP. 5 - LA RESURREZIONE PERVADE L'ANNO LITURGICO
l'immenso linguaggio della fede cristiana, della speranza delle genera-zioni cristiane, dell'amore dei battezzati e crismati verso il loro Signo-re, nella lode, nell'azione di grazie, nella supplica, nell'intercessione: fiduciose, aperte, con la potente "coscienza storica" che la salvezza è in atto.
L'Anno liturgico per sua natura congloba, esprime, significa e rilan-cia di continuo, anno per anno, in crescendo, tutto questo.
Il suo simbolismo efficace è l'intera ed irreversibile "storia della di-vina salvezza" per tutti gli uomini. Esso ha il principio, lo svolgimento progressivo, la fine, che corrono in linea crescente di celebrazione in celebrazione, inarrestabilmente, salvo l'incuria nel prendervi parte.
All'inizio, al centro, alla fine sta la Grazia divina dello Spirito. Ed il Mistero celebrato dona questa Grazia divinizzante.
8. Dal "Lezionario" tutta la mistagogia
E quando si dice mistagogia, si comprende anche l'azione pastorale, la cura delle anime, la spiritualità.
Tutto questo dovrebbe derivare anzitutto e soprattutto dal Leziona-rio dei Divini Misteri.
Esso programmaticamente vuole leggere la Parola divina, sia pure con la "selezione per accentuazione", dunque non materialmente, ma sostanzialmente tutta la Parola divina. Esso in specie proclama l'intera Vita del Signore, sempre dopo, a causa ed a partire dalla sua Resurre-zione, con il resto della divina Rivelazione che illustra l'Evangelo. La sua lettura di fede è perciò plenaria. Ed avviene nel momento più alto, intenso e decisivo della vita stessa della Chiesa: quando questa celebra il suo Signore e Sposo risorto con lo Spirito Santo, per giungere così ad adorare la Triade santa, consustanziale, indivisa e vivificante.
Dalla globalità del Lezionario emerge tutta la spiritualità della Chiesa Una Santa, la Cattolica, la Sposa affidata agli Apostoli ed ai loro successori legittimi. Emerge la vita cristiana integrale. Non una spiri-tualità di scuola, parcellare, riduttiva, moderna, devozionale, ideologi-ca, e neppure artificiosa e inconsistente come quella di tutti i "movi-menti" moderni. Ed emerge la grande teologia vivibile, non quella di dottori privati, ma teologia di contenuti, pronti per la mistagogia e la pastorale di tutto il popolo santo del Dio Vivente.
Il Lezionario presenta il Mistero divino integrale nella sua indicibile Economia della grazia che affluisce dentro la Chiesa dal Padre me-diante il Figlio nello Spirito Santo. Esso tende a concretizzare tutte queste Realtà nei "santi Segni" della Mensa del Signore. Allora nel continuo celebrativo, nella linguistica celebrativa si debbono rivedere e tenere sempre presenti le Realtà effettive che ne discendono. In una
133

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
parola semplice, i fedeli possono celebrare e vivere unicamente le Realtà di Cristo stesso nello Spirito Santo, quelle stesse che essi hanno ricevuto irreversibilmente per sempre nella loro iniziazione battesima-le al Mistero:
- la Parola divina, il dono del suo ascolto e la conversione del cuoreche ne scaturisce, e la fede compendiata (benché non per intero) nelSimbolo battesimale, fede da vivere con la speranza e la carità battesimali;
- la medesima Grazia dello Spirito Santo che assimila a Cristo Signoreed alla sua Vita, Grazia che proviene dal Signore incarnato e nato,vissuto, battezzato e trasfigurato, ossia "confermato" dallo Spirito,operante, morto, risorto, asceso al cielo e glorificato dallo Spirito,che dona il medesimo Spirito, che è presente ai suoi con lo Spirito,che con lo Spirito tornerà nella gloria;
- la filiazione divina, nel segno battesimale dell'invocazione 'Abbà'l,Padre! (cf. per Cristo, Me 14,36; per noi, Gai 4,6; Rom 8,15 e 26-27),che incessantemente ripetiamo nel "Padre nostro", "preghiera del Signore", preghiera battesimale ed eucaristica;
- l'abilitazione sacerdotale operata dallo Spirito già in Cristo, adesso neifedeli di Lui, a vari titoli e gradi e funzioni, che le Chiese sante della"Tradizione cattolica", dunque Roma, l'Ortodossia, l'Oriente, conservano gelosamente dai Vescovi ai presbiteri ai diaconi ai fedeli tutti;
- la concorporazione con il "Corpo di Cristo" che è la Chiesa Sposa,dove ogni fedele è membro vivo e prezioso nell'operazione nuzialedello Spirito Santo;
- la vocazione del Padre alla "Cena delle Nozze dell'Agnello" (Ap19,9), vero inizio del Regno;
- la via verso la divinizzazione, a partire dall'inserzione e "partecipazione alla sorte dei santi nella Luce" (Col 1,12), che è lo statuto effettivo, reale, ultimo per gli uomini che Dio ama (cf. qui Rom 8,28-30).
In ogni celebrazione di Cristo Signore Risorto con lo Spirito, i fedeli vivono solo questo, ma tutto questo. E tutto questo, e solo questo, è por-tato frontalmente e gloriosamente dalla Parola divina del Lezionario.
Già l'A.T. aveva ben compreso che l'evento dell'esodo aveva abili-tato il popolo di Dio alla "mistagogia", l'insistenza continua per gli "iniziati" da quell'evento a ricevere sempre più a fondo le realtà del medesimo ed inesauribile evento. Un testo esemplare qui è Dt 29,2-4. Il Deuteronomio in fondo è una "mistagogia", e Mosè nei suoi grandi discorsi al popolo è il primo, esemplare mistagogo.
Nel N.T. la realtà resta la medesima. L'Evento qui è la Resurrezio-ne, che diventa "evento" nei catecumeni al momento dell'iniziazione.
134

CAP. 5 - LA RESURREZIONE PERVADE L'ANNO LITURGICO
Qui esattamente comincia la mistagogia, che se per i battezzati da poco aveva la singolare durata della Settimana del rinnovamento, per essi e per gli altri fedeli durava lungo l'intera loro esistenza. Il battesimo e la crismazione li aveva "abilitati" per sempre al Mistero. I Padri lo com-presero con grande acutezza. Si può qui riportare un testo:
Forse la Scrittura vuole dichiararci che, quanto alla verità, ossia al senso misterico, non conviene parlarne a tutti, bensì solo agli intimi, né di consegnarlo agli ultimi venuti, bensì a quanti comunicano al Mistero (S. BASILIO IL GRANDE, Horn, inPs. 14, in Pg 29,256 C).
Sicché l'esistenza cristiana come suo genere si può definire una con-tinua mistagogia, ricevuta e donata lungo le generazioni.
Qui sta la spiritualità cristiana. Di qui si deve trarre la teologia di contenuti storici e vivibili. Di qui si deve operare la santa mistagogia permanente della Chiesa per tutti i fedeli. Verso qui devono procedere, e senza paura dei criticoni e dei praticoni, la teologia e la pastorale se-rie, preoccupate della santità e del bene vero del popolo di Dio.
Il Lezionario, nel suo vissuto, da perciò la possibilità di ampie revi-sioni della nostra povera teologia corrente. Se solo indichiamo qualche punto principale, dalla celebrazione emerge il quadro vivente della no-stra fede cristiana: la Triade indivisibile, consustanziale e beata del Dio Vivente, l'Unico Dio nostro nelle Ipostasi del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, che adoriamo con un atto unico e non divisibile; l'Eco-nomia del Padre mediante Cristo con lo Spirito Santo, nella Parola di-vina del Mistero rivelato, nella storia degli uomini; Cristo Sposo e Sa-cerdote nello Spirito Santo, il sacerdozio della Chiesa Sposa, degli Apostoli e dei loro successori legittimi, del clero, dei diaconi, del popo-lo intero; la Chiesa Una Santa, la Eva ultima, la Sposa, la Madre fecon-da di figli; la teologia biblica della celebrazione, con tutte le sue folgo-ranti ricchezze di Grazia divina; l'uomo, 1'"immagine e somiglianzà di Dio", l'uomo nuovo che prende vita e sostanza dall'ascolto della Parola che salva, e Parola celebrata, l'uomo reso icona sempre più perfetta dal battesimo e confermazione, sacrificio vivente che prende vita dai divini Misteri, perennemente convcrtito dalla grazia sacramentale, restaurato dal sigillo sacramentale della penitenza, inserito nella diakonia sacer-dotale della Chiesa, chiamato eventualmente alla vocazione nuziale per riproporre il "Mistero grande di Cristo con la Chiesa" (cf. Efes 5,32), nella unzione sacrificale con Cristo, detta "dell'Olio della preghiera", ad opera dello Spirito Santo, inserito come figlio vero nella Famiglia di Dio, divinizzato dai divini Misteri celebrati quale "caparra dello Spirito Santo"; la vita morale degli uomini battezzti confermati che celebrano
135

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
come fedeli il loro Signore, ma vita morale delle icone redente santifi-cate dal Signore morto e risorto con il dono dello Spirito del Padre, in via verso la loro divinizzazione; la "vita sociale " dei medesimi fedeli, resi dalla Grazia divina teofóri (cf. qui 1 Cor 6,20), cristofóri, pneuma-tofóri, nel mondo, per i fratelli; le loro opere che sono sempre "sociali" e battesimali-crismali, vere "opere del Regno; la vita vocazionale, nella vocazione al Convito nuziale della Grazia; la loro spiritualità cristiana — e senza nessun altro aggettivo falsificante —, dunque diocesana e parrocchiale, di Comunità apostolica che celebra "nello Spirito e nella Verità" i Divini Misteri trasformanti; l'ecumenismo, che, al di là di in-contri variopinti e pittoreschi di gruppi ufficiali e di volenterosi e pa-sticcioni, è invece far giungere le basi sconnesse, alienate, estraniate dell'unico popolo santo del Dio Vivente, alla Mensa unica della Parola e dei Misteri, dopo aver ritrovato l'unione nella carità e nella verità e nella conversione perenne; la vita missionaria, alla quale tutti sono abi-litati dallo Spirito Santo per il titolo dell'iniziazione battesimale, cri-smale ed eucaristica, per portare le nazioni, i peccatori all'unico Convito della gioia e della salvezza; // cosmo e l'escatologia, che debbono essere permeati dagli effetti della Redenzione divina celebrata dalla Comunità (cf. qui Rom 8,16-27).
Insomma, il Lezionario mostra come adesso, come ieri e forse come domani, qui sulla terra celebriamo, quale preparazione al fatto che in eterno celebreremo. Vedi qui Ebrei (e Apocalisse).
Accostandoci con spirito puro alla Parola, impariamo a prepararci bene, con la Grazia dello Spirito Santo, fin da adesso, nella Comunità redenta, alla celebrazione del Padre, presieduta dal Figlio ed operata nello Spirito Santo.
136

CAP. 6 L'OMELIA
CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
1. L'omelia è Leitourgia
Se la predicazione apostolica è annuncio dell'Evangelo come Lei-tourgia, "opera in favore del popolo" di Dio, come chiaramente dichia-ra l'Apostolo Paolo (Rom 15,16), e come si è visto lungamente all'ini-zio di questa trattazione, l'omelia fa parte di questa predicazione essen-ziale, fondante, come tale essa stessa è Leitourgia, ed in più è compo-nente essenziale di quell'aspetto terzo della Leitourgia divina, che è il culto della Chiesa in atto. Anzi, si può dire che l'omelia come tale è un condensato impressionante della predicazione apostolica. Non sarà inu-tile ripresentarne i principali elementi, a cominciare dall'annuncio pri-mordiale dell'Evangelo della Resurrezione, fino a quello abituale, nor-male, della Chiesa orante.
2. Le dinamiche della predicazione nel N.T.
Il termine diventato tecnico, homilia, dal greco attraverso il latino homilia (ma anche tractatus, sermo) passa nelle principali lingue mo-derne. Esso è poco usato nel N.T., ma il suo dinamismo si ritrova pun-tualmente in un denso vocabolario che mostra le numerose e confluenti semantiche della predicazione apostolica, alle nazioni e dentro la Co-munità.
Come si vedrà, il primo atto del Signore battezzato, tentato e vittorioso su satana, è "predicare l'Evangelo del Regno". Il primo atto degli Apostoli riempiti di Spirito Santo a Pentecoste, è predicare Cristo Risor-to, contenuto dell'Evangelo del Regno. Il primo atto di Saul, abbattuto dal Signore sulla via di Damasco, ma recuperato e ricostituito dal batte-simo dello Spirito Santo, è predicare Cristo Risorto. Nell'azione Apo-stolica della Chiesa di Dio, l'atto primordiale è questa predicazione.
La predicazione fonda la Chiesa di Dio nella Grazia dello Spirito Santo, ed in un certo senso la conferma continuamente nella sua stabile fondazione. Le crisi che la Chiesa dovette sostenere nei secoli, a guar-dare bene, furono anche, anzitutto, crisi della predicazione.
Infatti la fede divina e salvifica nasce e vive dalla predicazione. Tra gli altri, un testo realmente principe lo afferma in modo quasi dramma-tico.
E però, che dice (la Profezia, l'A.T)? "Vicino a te la Parola sta,
137

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
nella bocca tua e nel cuore tuo" (Dt 30,14):questa è la Parola della fede, che predichiamo:se confesserai con la bocca tua: "Signore è Gesù!",e crederai con il cuore tuo che Dio Lo risvegliò dai morti,sarai salvato.Con il cuore si crede per la giustizia,con la bocca poi si confessa per la salvezza.Dice infatti la Scrittura:"Chiunque è credente in Lui, non sarà confuso" (Is 28,16).Infatti non esiste differenza tra Ebreo e Greco,in realtà il Medesimo è Signore di tutti,ricco in atto per tutti quelli che Lo invocano:"Chiunque — infatti — invocherà il Nome del Signore,sarà salvato" (Gioel 3,5, LXX).Come dunque crederanno se non ascolteranno?Come però ascolteranno senza il predicatore?Come poi predicheranno se non saranno stati inviati?Come è stato scritto:"Come belli i passi dell 'evangelizzatore dei Beni!" (Is 52,7).Ma non tutti obbedirono ali'Evangelo.Isaia infatti dice:"Signore, chi credette ali'ascolto nostro?" (Is 53,1).Dunque, la fede dall'ascolto,ma Yascolto mediante la Paro la di Cristoì (Rom 10,8b-17).
È qui impressionante il complesso di verbi e sostantivi relativi alla predicazione che porta alla salvezza (qui sottolineati).
A tale testo fa eco la grande dossologia con cui Paolo chiude (come finale del cap. 14, nelle edizioni moderne cap. 16) l'Epistola. Il brano appare alla fine del cap. 14 nell'edizione bizantina dell'Epistola, poiché esso è attestato saldamente, non solo da grandi codici onciali e da molti minuscoli, ma anche dalle antiche versioni latina, siriaca, copta, e tra i Padri da Origene nel sec. 3°:
A Colui che può voi rendere saldi secondo V Evangelo mio e la predicazione di Gesù Cristo,secondo la rivelazione del Mistero nei secoli eterni taciuto, adesso però manifestato mediante le Scritture profetiche secondo il Decreto dell'Eterno Dio
fatto conoscere per l'obbedienza di fede per tutte le nazioni — all'Unico Sapiente Dio mediante Gesù Cristo, a Lui la gloria per i secoli dei secoli. Amen! (Rom 16,25-27/14,24-26).
138

CAP. 6 - NOTA SU "OMELIA" E VOCABOLARIO
Anche qui il cumulo dei termini della predicazione è denso come in-dica la loro sottolineatura.
È opportuno avere presente tale materiale in qualche modo ordinato e riproposto.
NOTA SU "OMELIA" E VOCABOLARIO
A partire dall'A.T., attraverso il N.T. e fino alla Chiesa dei primi se-coli, si può parlare del "mondo dell'omelia", che implica le sue pecu-liarità: il vocabolario, le semantiche, le tematiche, le dinamiche, gli scopi.
Per limitare l'enorme campo al solo N.T. greco, dal quale (salvo al-cune semantiche) derivano pressoché per intero il vocabolario e le realtà portanti, si da di seguito una rassegna indicativa della terminolo-gia che in qualche modo interessa l"'omiletica". Altri termini e temi sa-ranno poi indicati nel commento alle Letture ed ai testi liturgici. Intanto si deve annotare che questo vocabolario investe pressoché per intero la vita di fede della Chiesa.
A) I contenuti, almeno alcuniAnzitutto i termini per la Parola divina: hai Graphài, le Scritture, tó
Euaggélìon, l'Evangelo. Dunque anche "la Legge di Mosè", "Mosè, i Profeti, i Salmi"; ho lògos, "la Parola", hoi lógoi, le Parole, rhèma Chri-stoù, la Parola di Cristo, rhèma tèspisteós, la Parola della fede, rhèma-ta, le Parole (cf. Gv 6,63).
Poi i contenuti convergenti: tó Mystèrion, il Mistero, tó mystèrion tès Basiléias, i Misteri del Regno, del Regno di Dio. La houle toù Theoù, il Consiglio di Dio preeterno, il thélèma toù Theoù, la Volontà di Dio senza mutazioni, Yepitagètoù aiòniou Theoù, il Decreto dell'E-terno Dio (immutabilità anche qui, cf. Rom 16,26), Ventole, pi. entoldi, il Precetto divino, i Precetti divini. Come tessuto letterario, laparabole, leparabolài, la parabola, le parabole (comeparatithèmi tènparabolèn, proporre la parabola, Mt 13,24.31). E naturalmente, di nuovo YEuaggé-lion e i termini per la Parola divina.
B) Verbi e sostantiviLa rassegna è ampia, lasciando per ultimo l'"omelia". -Aggéllò,
annunciare, con i composti anaggélló, apaggélló, epaggélló, kataggello, paraggélló, e loro sostantivi. Indica il messaggio, inviato dal sovrano; qui, in pratica, dal Signore Eterno. Spicca ovviamente il termine Euaggélion, con il verbo euaggelizomai, euaggelizó. Se ne tratterà a fondo ed a più riprese in seguito. Qui basterà partire dal te-
139

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
sto di base che è Is 52,7, in cui il nunzio divino è Y euaggelizómenos che porta i Doni divini: la Pace, il Bene, la Salvezza, concentrati nel-l'annuncio: "Regnerà il Dio tuo!" (LXX). E basterà accennare che Cristo Signore, il Figlio di Dio, si fece autàggelos, Nunzio di perso-na, quale "Angelo del Grande Consiglio" di Dio decretato dall'eter-nità, che viene a portare agli uomini incarnandosi, morendo, risor-gendo, donando lo Spirito Santo, per tornare all'ultimo a riprendersi i suoi (Is 9,6, LXX; teologia giovannea; insistenza di S. Massimo il Confessore). Di fatto, appena battezzato, opera così:
Venne Gesù verso la Galileapredicando l'Evangelo di Dio,e parlando:"E stato adempiuto il tempo e si avvicinò il Regno:convertitevi e credete neh" E vangelo!" (Me 1,14-15),
dove va tenuto conto di Me 1,1: "Inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio", dove Egli stesso è l'Inizio ed è l'Evangelo, ed è il Re-gno con lo Spirito Santo (Mt 12,28);
- kèryssó, kérygma, predicare, predicazione, l'annuncio primordiale,divenuto termine tecnico. Già in Me 1,14: Gesù venne keryssón, predicando l'Evangelo. È di largo uso apostolico;
- predicare con "verbi del parlare": éipo, pàlin éipò, laléó tón logon(Me 2,2), Mèo tà rhèmata (Gv 6,63), légo, dialégó (At 20,7-8);
- predicare implicante l'insegnamento: didàskó, didaskalia (Rom 12,7;15,4), dìdachè (2 Tim 4,2), come operazione del Signore stesso;
- gnórizó, predicazione come "portare a conoscenza" (Gv 15,15; Rom16,26);
-phaneróò, predicazione come rivelazione primordiale: Me 4,22; Rom 16,26, mediante l'A.T.;
- apokalyptò,rivelare, idem (Mt 10,26; Rom 8,18; Efes 3,5);apokàlypsis, Ap 1,1-3, dove si ha Rivelazione-Profezia-Testimonianza;
-prophètéuó, predicare spiegando le Scritture durante la sinassi comu-nitaria (1 Cor 13,9); è dopo Yapostolè, "essere apostoli", il secondo chàrisma, dono dello Spirito Santo (1 Cor 12,28; Efes 4,11), testi drastici;
- diversi verbi e sostantivi dove la predicazione è anche "spiegazione"di quanto annunciato: exègéomai, fare esegesi, di Cristo anzitutto che "spiega il Padre" (Gv 1,18b; Le 24,35); degli Apostoli (At 21,19); diègéomai, diègèsis,narrare, narrazione (Le 1,1); hermènéuò, interpretare (Le 24,27); hermènéia (1 Cor 14,26); diermènéuó (Le 24,27; 1 Cor 14,5); dianóigò tàs Graphàs, "aprire" (il senso del) le Scritture (Le 24,32.45; At 16,14); diasaphéò, spiegano

CAP. 6 - NOTA SU "OMELIA" E VOCABOLARIO
re (Mt 13,36); epilyó, "sciogliere" il senso avviluppato nel contesto (Me 4,34; 2 m,20);
- predicare come invito alla "ricerca", allo "scrutare" la Scrittura ed ilsuo significato: 1 Pt 1,11;
-déiknymi, mostrare (Mt 16,21; At 10,28; 1 Cor 12,31;Ap 1,1);- homologéó, confessare, professare predicando (At 24,10; 1 Tim 6,12-
13, detto di Cristo stesso; Ebr 3,1); di qui, predicazione come homo-logia, confessione, professione di fede vissuta;
- martyréó, testimoniare (1 Cor 15,15; 2 Cor 8,3; 1 Tim 6,13, detto diCristo stesso; 1 Gv 1,2); martyria, testimonianza (1 Tim 3,7); dia-martyréò tó Euaggélion (At 20,24); tón Logon (At 8,25); anche in assoluto (At 2,40; 1 Tess 4,6);
- apologéomai, dimostrare e difendere i contenuti predicati (At 19,33);apologia, dimostrazione-difesa (At 22,1; 1 Pt3,15); "dell'Evangelo"(FU 1,7.16);
- elégchó, confutare (Gv 16,8, opera dello Spirito Santo contro "ilmondo"); degli Apostoli (1 Cor 14,24; Efes 5,13; 2 Tim 4,2);
- katèchéó, "far echeggiare dall'alto verso il basso" le realtà predicate,dunque insistervi (Le 1,4; At 18,25; Gal 6,6). I Padri poi distinseroaccuratamente "catechesi" ai catecumeni, e "catechesi mistagogica"o "mistagogia" ai battezzati;
- nouthetéó, per penetrare nella mente, ammonire, persuadere (At20,31; Rom 15,14; 1 Cor 4,14; Col 3,16); nouthesia (1 Cor 10,11;Efes 6,4, secondo lo Spirito Santo);
-parakaléó, esortare, confortare, consolare (At 2,40; 11,23; 14,22); da cuipardklèsis (At 13,15, come "discorso di esortazione", e tale l'Au-tore chiama l'intera Epistola agli Ebrei: Ebr 13,22); quella che viene "dalle Scritture" (Rom 15,4; inoltre, 1 Cor 14,3);
- paramythéomai, consolare: 1 Tess 2,12, dove sta con parakaléó; 5,14;paramythia (1 Cor 14,3);paramythion (FU 2,1, detto "dellacarità");
- parainéò, esortare (At 27,9.22); da cui paràinesis, predicazione comeesortazione alla fede ed alla santità (non usato nel N.T.).
C) Homiléò, homiliaNel N.T. il verbo è usato solo 4 volte, in Le 24,14.15 per indicare lo
sconsolato colloquio dei due fuggitivi verso Emmaus; in At 24,26 il go-vernatore Felice voleva "colloquiare" con Paolo, anche ripromettendosi di ottenre da lui del denaro. Solo in At 20,11, detto di Paolo, ha il senso successivo che ancora oggi sta nell'uso. Il sostantivo homilia in 1 Cor 15,33 è usato nel proverbio antico: "le homiliai cattive corrompono i buoni costumi", secondo il senso di "frequentazioni".
Destinato a singolare importanza, il termine homilia (più che il ver-bo homiléó) nei suoi molteplici significati è in uso nella Chiesa almeno
141

CAP. 6 - NOTA SU "OMELIA" E VOCABOLARIO
re (Mt 13,36); epilyó, "sciogliere" il senso avviluppato nel contesto (Me 4,34; 2 m ,20);
- predicare come invito alla "ricerca", allo "scrutare" la Scrittura ed ilsuo significato: 1 Pt 1,11;
-déiknymi, mostrare (Mt 16,21;At 10,28; 1 Cor 12,31 ;Ap 1,1);- homologéó, confessare, professare predicando (At 24,10; 1 Tim 6,12-
13, detto di Cristo stesso; Ebr 3,1); di qui, predicazione come homo-logia, confessione, professione di fede vissuta;
-martyred, testimoniare (1 Cor 15,15; 2 Cor 8,3; 1 Tim 6,13, detto di Cristo stesso; 1 Gv 1,2); martyria, testimonianza (1 Tim 3,7); dia-martyréò tóEuaggélion (At 20,24); tón Logon (At 8,25); anche in as-soluto (At 2,40; 1 Tess 4,6);
- apologéomaì, dimostrare e difendere i contenuti predicati (At 19,33);apologia, dimostrazione-difesa (At 22,1; 1 Pt3,15); "dell'Evangelo"(FU 1,7.16);
- elégchò, confutare (Gv 16,8, opera dello Spirito Santo contro "ilmondo"); degli Apostoli (1 Cor 14,24; Efes 5,13; 2 Tim 4,2);
- katéchéó, "far echeggiare dall'alto verso il basso" le realtà predicate,dunque insistervi (Le 1,4; At 18,25; Gal 6,6). I Padri poi distinseroaccuratamente "catechesi" ai catecumeni, e "catechesi mistagogica"o "mistagogia" ai battezzati;
- nouthetéò, per penetrare nella mente, ammonire, persuadere (At20,31; Rom 15,14; 1 Cor 4,14; Col 3,16); nouthesia (1 Cor 10,11;Efes 6,4, secondo lo Spirito Santo);
-parakaléó, esortare, confortare, consolare (At 2,40; 11,23; 14,22); da cuiparàklèsis (At 13,15, come "discorso di esortazione", e tale l'Au-tore chiama l'intera Epistola agli Ebrei: Ebr 13,22); quella che viene "dalle Scritture" (Rom 15,4; inoltre, 1 Cor 14,3);
-paramythéomai, consolare: 1 Tess 2,12, dove sta con parakaléó; 5,14; paramythia (1 Cor 14,3);paramythion (FU 2,1, detto "dellacarità");
-parainéó,esortare (At 27,9.22); da cui paràinesis, predicazione come esortazione alla fede ed alla santità (non usato nel N.T.).
C) Homiléó, homiliaNel N.T. il verbo è usato solo 4 volte, in Le 24,14.15 per indicare lo
sconsolato colloquio dei due fuggitivi verso Emmaus; in At 24,26 il go-vernatore Felice voleva "colloquiare" con Paolo, anche ripromettendosi di ottenre da lui del denaro. Solo in At 20,11, detto di Paolo, ha il senso successivo che ancora oggi sta nell'uso. Il sostantivo homilia in 1 Cor 15,33 è usato nel proverbio antico: "le homiliai cattive corrompono i buoni costumi", secondo il senso di "frequentazioni".
Destinato a singolare importanza, il termine homilia (più che il ver-bo homiléó) nei suoi molteplici significati è in uso nella Chiesa almeno
141

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
da S. Giustino Martire (e. + 155). Esso, anche nel senso di predicazione liturgica, deve essere esaminato globalmente, poiché i vari significati sono abbastanza convergenti.
Hómilos, folla, schiera di persone, mischia nella battaglia; è il termi-ne di partenza.
Homiléò significa: conversare, trattenersi, familiarizzare, usare, di-scorrere con familiarità; frequentare; radunarsi, scontrarsi, confrontarsi; soggiornare, dimorare; applicarsi.
Homilia dice: compagnia, società consorzio; commercio, relazione (anche nuziale); conversazione, colloquio; istruzione, lezione; riunione, assemblea; incontro, visita.
Ora, F"omelia" ha qualche cosa di tutto questo: diciamo così, un col-loquio familiare, che è anche istruzione, che è incontro di persone che nella fede comune si frequentano per lo scopo celebrativo, e si applica-no dalle due parti, chi parla e chi ascolta, alle realtà in atto celebrate.
È un aspetto essenziale della Chiesa. Soprattutto tenendo conto che:
a) Dio stesso fa homilia con gli uomini, con i quali stabilisce la dimoracomune, la familiarità, la comunione e comunanza di vita;
b) in questo preciso senso, la massima Homilia di Dio con gli uomini èanzitutto quella del Verbo che si unisce ipostaticamente la "sua carne",e quindi è la venuta e la dimora del Figlio di Dio con lo Spirito Santotra gli uomini;
e) perciò la Chiesa ne ha l'ufficio peculiare, distintivo fino al Ritorno del suo Signore. Di qui, la centralità deìV homilia nella sua stessa esi-stenza e struttura.
Il materiale visto sopra, come è dato da constatare, fa parte sia della Rivelazione divina, sia della predicazione della Chiesa che la comunica agli uomini.
Nella struttura dell'omelia della celebrazione, in specie dei Divini Misteri, quelle dinamiche si ritrovano tutte, e puntualmente, fino alla dossologia finale.
Perciò va insistito che l'omelia della Chiesa è celebrazione liturgica in tutto il suo genere, e che da essa non esiste esenzione, pena gravissi-me responsabilità per chi ne ha il "diritto e dovere".
3. L'omelia è Liturgia in atto
L'omelia è Liturgia in tutta la sua essenza e funzione. Questo deve essere il punto fisso per l'omileta, che lo deve anche far comprendere al suo popolo battezzato.
142

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
Insieme, l'omelia-celebrazione è il momento più alto e più necessa-rio della mistagogia, questo "condurre" (ago) gli "iniziati" (mystai), il che significa entrare insieme senza più soste nel Mistero ricevuto nel-l'iniziazione e di continuo celebrato dalla Divina Liturgia e dagli altri Misteri e dalle Ore sante e lungo l'Anno liturgico.
Però, la divina Guida dei fedeli è lo Spirito Santo.L'omelia, in quanto parte squisita della celebrazione del Signore Ri-
sorto con lo Spirito, ed in quanto coestensivamente e perennemente mi-stagogia, deve avere come Referente divino lo Spirito Santo che guida la Chiesa, a cui consegnò la Scrittura e la sua interpretazione.
Basteranno qui due splendidi testi della grande Tradizione, riportati da due dei Padri più importanti, uno per l'Oriente, l'altro per l'Oc-cidente.
S. Gregorio il Teologo (+ e. 390): "... poiché (quando si tratta) di Dio, anche l'omelia è divina". Ma l'espressione è inserita in un conte-sto precisamente omiletico, mistagogico e celebrativo, per cui vale la pena riportarlo:
"... ed oggi io sono nutritore per voi, io su questo (il Natale) prepa-rerò per voi, buoni convitati, per quanto si può, un'omelia lautissima e copiosissima e desiderosa di dare onore (philótimós), affinchè voi sappiate come uno straniero possa nutrire i paesani, ed un paesano i cittadini, ed un austero gli agiati buongustai, ed un povero e senza casa (cf. Lazzaro, Le 16,20-21) gli splendentemente ricchi (il ricco Epulone, Le 16,19). Io comincerò di qui: e voi apportate mente ed orecchi ed animo purificati, quanti vi deliziate di queste Realtà, poi-ché quando (si tratta) di Dio, anche l'omelia è divina — affinchè ve ne andiate deliziati realmente da Realtà non rese vuote" (In Theophania, seuNatalitia Salvatoris, in PG 36,317);
S. Agostino (+ 430), che conosceva testi orientali simili, se non pro-prio il testo precedente, mentre commenta con omelie celebrative l'in-tero Giovanni, esclama al solito modo lapidario che gli è consueto:
Suona il Salmo — è la Voce dello Spirito.Suona FEvangelo — è la Voce dello Spirito.Suona l'omelia divina (sermo divinus) — è la Voce dello Spirito (InIoannis tractatum 12,5, in Corpus Christianorum, Series Latina[CCL] 36,123).
Anche qui però, come sempre, la spiegazione è biblica: poiché solo il Signore dona la Parola, e solo Lui ne da la spiegazione. Chi ha un po-
143

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
co di pazienza, potrà qui rileggersi i testi riportati sopra (Cap. 2, n. 2) nella consapevolezza biblica del canto famoso:
poiché presso Te sta la Fonte della Vita,nella Luce tua noi vediamo la Luce (Sai 35,10).
In corrispondenza, del resto, il medesimo Signore "è il Dio ope-rante in voi sia il volere, sia l'operare per il Compiacimento (suo)"
E tuttavia, come si è spiegato sopra, nel Cap. 3, non vanno contrap-poste, come bene sostenevano i grandi Pastori d'Oriente e d'Occidente, la Parola divina e la povera parola umana. In un certo senso, mentre Dio già ha espresso la sua Parola totalmente divina — procedente come lo Spirito dalla sua Bocca: Sai 32,6.9! — in parole di Profeti totalmente umane, così ha ancora "bisogno" dell'umana collaborazione affinchè questa parola della Santa Scrittura sia proclamata e celebrata ed inse-gnata ancora lungo le generazioni, dalle bocche umane delle persone chiamate di vocazione, formate a questa necessità primordiale e consa-crate ad essa per l'imposizione delle mani che fa discendere "la Grazia dello Spirito Santo" che colma ogni difetto. Tale il pastore omileta. E questo incarico "apostolico" se altri mai, questa consacrazione per la missione di predicare, questo tremendo diritto che è prima stretto e la-cerante dovere, non possono essere pretermessi e abbandonati, e nep-pure ceduti ed altri, perfino se più preparati specificamente (questi, al-lora, debbono insegnare agli omileti, non surrogarli).
Poiché sta qui in gioco la stessa vita spirituale del popolo di Dio, che è promossa dalla Grazia dello Spirito Santo anzitutto dall'annuncio evangelico e dal suo continuo insegnamento. Ma l'annuncio e l'inse-gnamento che avvengono durante la celebrazione della Chiesa sono primari, nodali e fontali rispetto ad ogni altra forma di vita dei fedeli, ed oltre tutto sono anche coestensivi all'intera loro esistenza di fede e di "stare nel mondo" tra gli uomini fratelli.
La Chiesa antica avvertiva questo acutamente. Uno dei più grandi omileti di tutti i tempi infatti si esprime così:
"Secondo quanto avrete concepito nei cuori vostri: vedete se conce-pite, se ritenete le Parole divine, per tema di lasciarle sfuggire dalle mani vostre e di perderle. Io desidero esortarvi con esempi tratti dalle vostre usanze religiose. Voi che assistete abitualmente ai divini Misteri, sapete bene con quale precauzione rispettosa conservate il Corpo del Signore [è l'uso antico di darlo da portare a casa per co-municarsi dentro la settimana] quando vi è consegnato, per paura che ne cada qualche briciola, e che una parte del Tesoro consacrato
144

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
sia perduta. Poiché voi vi riterreste colpevoli. Ed in questo avete ra-gione, se per la negligenza vostra un qualche frammento se ne per-desse. Ma se quando si tratta del suo Corpo voi mettete in opera, a giusto titolo, tanta precauzione, perché allora vorreste che la negli-genza verso la Parola di Dio meriti una punizione minore che quella verso il suo Corpo?" (ORIGENE, Omelia 13 sull'Esodo, qui Es 35,4-5, in Sources Chrétiennes 16, Paris 1947, p. 263).
Così intesa, dunque, l'omelia è realmente la "prima carità" dei Pa-stori verso il loro gregge santo. Essa è il centro della santa mistagogia della Chiesa. È il raccordo celebrativo, in cui i fedeli debbono essere introdotti, tra la Parola di oggi ed il suo diventare Corpo e Coppa del Signore. Con l'omelia in sostanza i fedeli sono portati a ricevere lo Spi-rito Santo, la divina Koinònia o Comunione, che si riceve a sua volta precisamente tramite il "triplice Corpo di Cristo", la Parola che si man-gia (Dt 8,3; Mt 4,4; e vedi Nota sulla Parola Cibo, sopra), il Corpo e la Coppa preziosi del Convito; la Chiesa corpo di Cristo, la Sposa convi-tata convitante.
Che l'omelia sia celebrazione mistagogica è del resto un fatto che si fonda su diverse realtà concrete.
Essa è per intero, ed è solo, celebrare Gesù Risorto con lo Spirito. Sulle esclusioni severe che questo implica, si parlerà tra poco. E cele-bra il Signore per diversi titoli:
a) per il contenuto: i Testi biblici, in specie però l'Evangelo; e solo in viasubordinata, per il "colore" del giorno, i testi liturgici. Dai primi vengonoi contenuti reali; i secondi solo accompagnano ed illustrano i primi;
b)per il luogo-momento: "qui oggi noi" Chiesa locale, tutta la ChiesaSposa presente "adesso" in questo luogo, che come Sposa nello SpiritoSanto celebra lo Sposo suo presente a lei con il suo Spirito Santo;
e) per l'inserzione nella celebrazione concreta: la Parola divina mista-gogizzata al popolo con l'omelia celebrativa, tende infatti al suo fine naturale: farsi Mistero celebrato in tutta la sua efficacia. Di per sé, co-me si sa bene, l'iniziazione battesimale-crismale è inserzione nella vita di grazia, la quale si celebra di continuo solo con r Divini Misteri, e da questi e subordinatamente, a loro modo con tutti gli altri Misteri della Chiesa. L'omelia fa questo anche in altre occasioni celebrative, specia-li, della Chiesa;
d)per la sua struttura: l'omelia mistagogica deve cominciare di norma con la dossologia trinitaria, prosegue con la proposta dei contenuti ce-lebrati, termina sempre con la dossologia trinitaria;
145

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
e) per il suo scopo specifico: portare soavemente ma fortemente tutti ibattezzati presenti — clero e popolo! — a celebrare dovutamente nellagrazia il Signore Risorto con lo Spirito Santo. È il solo modo offertociper salire al momento supremo dell'adorazione che si deve innalzare mediante Cristo nello Spirito alla Triade santa — culto di amore, santificazione di grazia, comunione offertaci ed accettata, Vita divina conseguita;
f) per il risultato da raggiungere immediatamente: l'ascolto di conversione e di fede, la confermazione della speranza, l'irradicamento nellacarità, e la comunione al Mistero nel triplice corpo di Cristo, come giàspiegato.
Un altro aspetto mai affrontato è che l'omelia celebrativa mistagogi-ca è l'esercizio del sacerdozio eterno del Signore Risorto con lo Spirito Santo, che adesso parla nell'omileta.
Il Signore nostro, divino Annunciatore del Regno (cf. Me 1,14-15, e par.), associa alla sua predicazione terrena, nel "tempo della Chiesa", la Sposa sua. Di per sé, infatti, tutta la Chiesa, tutti i discepoli del Signore annunciano per la forza dello Spirito Santo in essi inabitante. Tuttavia in seno alla Chiesa Sposa in modo speciale la predicazione è demandata agli Apostoli ed ai loro legittimi Successori, i Vescovi, ed ai Profeti e loro successori che sono i presbiteri, ed ai diaconi. I testi del N.T. la-sciano pochi dubbi: si veda ad es. 1 Cor 12,28; Efes 4,11 ; 1 Cor 14; Me 16,15-20; Mt 28,16-20; At 9,15-16. Nel N.T., come già ricordato, il do-no di "profezia" è spiegare le Scritture (in pratica, l'A.T.) nell'assem-blea eucaristica; dopo 1'"apostolato", è il secondo "carisma". Ora, l'u-nica predicazione della Chiesa in senso tecnico è per mandato divino affidata all'unico "Collegio sacerdotale", formato dal Vescovo con i presbiteri ed i diaconi, ordinati in "gradi", partecipanti alla grazia sa-cerdotale.
Il sacerdozio che si esplica nella predicazione è la fonte primaria ed indispensabile della santificazione di tutto il popolo santo del Dio Vi-vente, il cui arrivo ultimo è sempre la divinizzazione. La Parola per sua natura è divinizzante, se accettata nello Spirito Santo, come si è visto.
H sacerdozio predicante porta di necessità ad essere sacerdozio sacri-ficante, unico sacerdozio del Signore nelle forme diverse da Lui volute. H primo in ordine di tempo tende al secondo. Questo esige e suppone il primo. Ma mentre, benché in situazione limite, il primo può esistere da solo — si pensi ad esempio alla predicazione demandata ai laici nelle missioni in cui il sacerdote passa di tempo in tempo —, il secondo non deve esistere senza il primo. Quando in effetti non si fa l'autentica "omelia", si ha questo ultimo caso, che è deformazione grave della vita della Chiesa: il "sacramento" senza la Parola divina della grazia.
146
L

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
4. Distruggere l'omelia?
Forse occorre lucidità e coraggio, conoscenza della storia e preoccu-pazione per il bene spirituale di tutti i fedeli, se si vuole finalmente rico-noscere che per buona parte la crisi di molti battezzati, dello stesso clero, è il frutto della non buona, o addirittura della mancata predicazione della Chiesa e delle Chiese. Di una predicazione che sempre più si poneva co-me alla periferia e non al centro. Che non sapeva gestire i contenuti vivi-ficanti. Che non comunicava la gioia della fede. Che vagamente poneva come meta la vita eterna, senza prepararvi immediatamente le anime.
Con coraggio netto, a costo di andare contro corrente, occorre seve-ramente escludere dall'omelia, intesa nel suo senso autentico voluto dalla Chiesa, alcune realtà che la vanificano, la banalizzano, la cosifi-cano, la deviano dalla sua essenza celebrativa e mistagogica.
Meditiamo, anzitutto: siamo purtroppo abituati non all'omelia, ma a "discorsi con contorno di Divina Liturgia", o di altre celebrazioni, pre-se a pretesti per dire tutto di tutto, meno quello che è essenziale.
L'"omelia" della Chiesa orante non è, non può essere, non deve es-sere, perciò anzitutto e soprattutto, esclusivamente o anche solo preva-lentemente:
a) esegesi biblica: che pure rientra in parte nella preparazione immediata sui Testi sacri;
b) spiegazione puramente dottrinale, per quanto ricca e necessaria, chealmeno in parte deve entrare nell'omelia;
e) catechesi o catechismo: a parte che si deve parlare di catechesi mi-stagogica ai battezzati, questa deve essere impartita prima e dopo la ce-lebrazione; la celebrazione è solo celebrazione;
d) istruzione di qualsiasi tipo, che è eterna tentazione illuministica eculturale; la celebrazione non è esercitazione culturale;
e) pedagogia, altra tentazione illuministica;
f) esposizione puramente della morale cristiana, o, peggio, del moralismo; anche se l'omelia è riccamente tessuta di elementi dottrinali emorali;
g) spiegazione dei riti stessi, che deve trovare altri luoghi e momenti;
h) illustrazione della storia o delle storie della Chiesa;
147

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
i) oratoria altisonante: homilia in greco significa "trattenersi familiar-mente" sulle realtà primarie e dense;
1) panegirico dei santi, poiché qui si tratta sempre e comunque — vedi l'Anamnesi della santa Anafora! — di "celebrare Gesù Cristo con lo Spirito Santo", niente altro; ed il Santo del giorno rientra poi nell'appli-cazione, al posto suo;
m) commemorazione e rievocazione di fatti, eventi, imprese di uomini viventi e presenti, e neppure sola commemorazione di persone defunte, e loro panegirico;
n) schemi ideologici della predicazione, la quale deve seguire i Testi nell'occasione celebrativa;
o) "dialogo", benché vi sia stato un uggioso dibattito di gente che non ha mai fatto una vera "omelia" in vita sua, e discetta di psicologia di massa, di teoria della comunicazione sociale e simili. Poiché nella cele-brazione, 1'"omelia" fonda il Dialogo divino tra lo Sposo e la Sposa, operato dalla grazia dello Spirito Santo; il dialogo si faccia in tempi e luoghi deputati;
p) polemica extraecclesiale o intraecclesiale;
q) politica, o realtà simili, che pure debbono trovare il posto di dibattito in seno alla Comunità cristiana, ma non quando si celebra il Signore;
r) comunicazione sociale, e teorie connesse;
s) occasionalità ("Domenica, o Giornata del... della..."), di cui l'omelia deve dare appena un avviso, rimandando alla meditazione seria di quel-l'occasione a suo tempo e luogo;
t) lettura di "documenti", delle autorità, siano pure pressanti.
Tutto questo precisamente fa sì che si abbia il "discorso con contor-no di Liturgia"! E che non si celebri il Signore con lo Spirito Santo.
Né si dica, sprovvedutamente: "ma la Domenica abbiamo solo quella benedetta ora, e lì dobbiamo fare tutto: catechesi, dottrina, istruzione, nozioni morali, dottrina sociale cristiana...". Precisamente questo è tutto, meno che "celebrare Cristo Risorto con lo Spirito San-to". L'unica realtà che serve ai fedeli nella fede, è celebrare nel Gratui-to divino. Inserire le realtà appena elencate, come del resto si fa comu-
148
L

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
nemente contro le norme della Chiesa, come "quantità" preminente nell'omelia, o trasformare l'omelia solo in tali realtà, è disattendere la Domenica o festa o celebrazione. È non tenere 1'"omelia celebrativa mistagogica". È non radunare mai il popolo come Chiesa orante intorno alla Parola divina. È non seguire il continuo celebrativo portato dal Lezionario. È insomma non "fare mistagogia", cioè non portare il po-polo al suo Signore e Dio. Ed a lungo andare, come è stato finora, an-notazione di lancinante dolore, la predicazione non omiletica ha avuto, sia pure del tutto involontariamente, effetti diluenti sulla fede, a lungo andare effetti ateizzanti. Basterà qui analizzare sul serio la consistenza della fede cristiana profonda nelle nostre Comunità, soggetto passivo di predicazioni inconsistenti. O peggio, nei secoli passati, che oggi noi scontiamo.
Tuttavia, sia detto per tranquillizzare chi deve esserlo, qualche ele-mento dell'elenco tracciato qui sopra per operare esclusioni se quelle realtà prendono il sopravvento, può ed anche deve essere introdotto nella vera omelia, ma nella parte attuativa, come si dirà. In specie poi se si tratta di elementi positivi: esegesi, dottrina, morale, rito. Purché, come prescrive severamente l'Apostolo alle sue Comunità nel grande capitolo della "profezia celebrativa" che è 1 Cor 14, "tutto avvenga se-condo ordine, katd tàxin" (v. 40).
Inoltre, gran parte degli elementi positivi dell'elenco famigerato, poiché hanno trovato luogo e modo di essere amministrati prima e dopo la celebrazione, sono anche operati dalla celebrazione stessa. La quale, e qui non occorre sorprendersi, celebra il Gratuito divino, que-sto meraviglioso "Gioco" ("liturgia come gioco": Romano Guardi-ni!). Come tale, il Gioco divino non è finalizzarle a nessuno scopo che non sia la celebrazione in sé e per sé — ed opera tutto il resto per la sovrana divina sovrabbondanza. Nel senso che dalla celeberazione bene eseguita, katd tdxin, si deve uscire, ad esempio: conoscendo me-glio la Scrittura (effetto esegetico: quante scoperte, quante perle lo scrivente, esegeta di professione, ha raccolto ascoltando la spiegazio-ne delle Scritture!), ed il rito stesso celebrato (effetto rituale), e la dottrina cristiana (effetto dottrinale), e la "catechesi mistagogica" (ef-fetto "catechetico"), e la pedagogia cristiana (effetto sempre mistago-gico), e gli atti che il cristiano compirà o non compirà (effetto mora-le), e la direzione della vita (effetto santificante), e l'amore ai Santi (effetto della "comunione alle Realtà Sante" che sono i divini Miste-ri), e l'amore struggente ai nostri cari defunti (idem), e il dialogo ne-cessario (effetto dialogico tra lo Sposo e la Sposa, e dei fedeli tra lo-ro). Il resto, a che serve?
Quando si dice che l'omelia celebrativa mistagogica non deve esse-re, e per sua natura vera non può essere, finalizzata a nessuno scopo
149

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
che non sia puramente celebrativo, lasciando operare il Gratuito divino per sovrabbondanza, si vuole dire una realtà dura ma necessaria. Se si fa il contrario, si tradisce coestensivamente: il Signore che ci dona la sua Parola con lo Spirito Santo, e non idee astratte e banali; la Parola stessa, che esige la mistagogia continua, e poi l'applicazione alla nostra vita; e l'intelligenza e la bontà del povero popolo santo del Dio Viven-te, che ha diritto ai Tesori della Sapienza e della Scienza. Le responsa-bilità qui sono spaventose, come si è detto.
Non è altro che realtà, dire che probabilmente uomini di Chiesa, pur buoni, pii e devoti, in vita loro non hanno mai tenuto una vera "omelia celebrativa mistagogica". Altro che "omelia divina" di S. Agostino.
5. Le strutture mistagogiche e celebrative dell'"omelia divina"
Quanto segue è insieme dottrina, riflessa dalla Santa Scrittura, dai Padri, dalla Liturgia, dagli spirituali, dalla Tradizione della Chiesa uni-ta. Ed è pratica, che obbedisce anche a criteri del buon senso cristiano.
Si tenga sempre conto di una situazione ideale, che, se non esiste, va procurata. Dopo un certo tempo, al medesimo popolo, in sostanza alla medesima comunità, molti degli elementi che adesso saranno ordinati in piccolo ma necessario elenco, si riducono per forza a samplici so-stanziali cenni ed allusioni: come si è cercato di spiegare nel Cap. 3, la comunità "già sa" molte delle realtà predicabili. E cresciuta. Allora si può affondare di più, "misticamente", nei Testi. Si possono dare diretti-ve necessarie più tese ed operative.
E si tenga sempre conto della grande legge antropologica della "ri-petitività efficace", propria della mistagogia instancabile. Alcune delle realtà che la comunità "già sa", tuttavia vanno richiamate sempre. Si tratta di quella che fu così bene definita "la magnifica monotonia "della celebrazione: sempre il medesimo Signore, la medesima Parola, i me-desimi divini e trasformanti Misteri, il medesimo popolo in assemblea, il medesimo Anno della grazia divina (o "liturgico"), la medesima Do-menica. Proprio quanto è inteso dall'Apostolo, quando al suo discepolo diletto scrive:
... predica la Parola,insisti in modo opportuno e importuno,confuta, riprendi, rimprovera,con tutta pazienza e dottrina (2 Tim 4,2),
testo emblematico.Ma insieme la "magnifica monotonia" della Liturgia nasconde e ri-
150

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
vela la "infinita virtualità" delle Realtà sante, percepibili dalla comu-nità se cresce nella grazia, nella sapienza, nelle opere buone.
Seguono adesso le strutture essenziali dell'omelia celebrativa mista-gogica. In un certo ordine. Che va tenuto fermo per i nn. A e A', a-b, e-g, mentre il resto può essere ordinato secondo il giorno e l'occasione. Però non dovrebbe mai mancare nessun elemento.
A) La dossologia inizialeNon manchi mai. È qualificante, indica la preziosità della celebra-
zione stessa. Può essere più o meno semplice e breve. Gli esempi di ba-se possono essere dedotti da diversi Testi sacri.
Così, dall'A.T. si possono usare molti versetti dossologici del Salte-rio, come ad esempio:
Benedetto il Signore Dio d'Israeledal secolo e fino al secolo. Amen (Sai 40,14)
Benedetto il Signore, Dio dei Padri nostrie laudabile e glorioso il Nome suo nei secoli (Dan 3,26)
Benedetto è Dio,il Mirabile tra i suoi santi (Sai 67,36)
Benedetto il Signore Dio d'Israele,il solo che compia opere mirabilie benedetto il Nome della sua Maestà in eterno (Sai 71,18-19)
Celebrate il Signore, poiché è buono,poiché in eterno è la sua Misericordia (Sai 105,1)
Cantate al Signore il cantico nuovo,la sua lode nell'assemblea dei santi (Sai 149,1).
Ovviamente, il Salterio è una miniera inesauribile.Anche nel N.T. esiste un ricco patrimonio dossologico:
All'Unico Sapiente Dio mediante Gesù Cristo,a Lui l'onore e la glorianei secoli dei secoli. Amen (Rom 16,27/14,26)
Pieghiamo le ginocchia al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale trae nome ogni paternità in cielo ed in terra (Efes 3,14-15)
151

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
Al Padre la gloria nella Chiesa ed in Gesù Cristolungo le generazioni dei secoli dei secoli. Amen (Efes 3,21)Al Padre che solo ha l'immortalitàed abita la Luce inaccessibile,a Lui l'onore e il dominio eterno. Amen (1 Tim 6,16)
Benedetto il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che secondo la sua grande Misericordia ci rigenerò alla speranza vivente con la Resurrezione di Gesù Cristo dai morti (1 Pt 1,3)
All'Unico Dio Salvatore nostromediante Gesù Cristo Salvatore nostro,gloria e magnificenza, dominio e potestàprima di tutti i secoli ed ora,e per tutti i secoli dei secoli. Amen {Giud 25).
Molte formule ricche e varie possono essere desunte da un'attenta lettura dell'Apocalisse, del resto largamente entrate nell'uso liturgico.
Molti testi, quasi sempre desunti dalla Santa Scrittura, possono esse-re qui ripresi dalla celebrazione stessa. Il classico Dóxa Patri, le dosso-logie finali delle Ore sante, e così via.
Da questo materiale è possibile, impratichendosi, formulare molte al-tre dossologie: inniche, gioiose, esaltanti, che diano impulso all'ascolto.
a) Cristo Risorto, lo Spirito Santo donato, il Padre in attesa, la Triade beata
Si tratta delle divine Ipostasi, vero divino Oggetto della celebrazio-ne, di ogni celebrazione. Si debbono enunciare, nominare, esaltare in ogni omelia. L'augusta santa Triade è il Culmine divino ed è la Fonte divina a cui tende e da cui deriva ogni celebrazione, oggetto immedia-to della mistagogia continua della Chiesa. Il Dio Unico che sussiste nelle Ipostasi divine tutto e per intero in ciascuna di esse, è l'unico scopo dell'esistenza cristiana redenta. La Parola divina raduna anzitutto e soprattutto per questo: celebrare Cristo Risorto con lo Spirito Santo per poter adorare la Triade santa consustanziale indivisibile, come già si è detto. Non esiste "altra" celebrazione. Si tenga conto per av-vertimento che in Occidente la predicazione continua della Resurre-zione — "... se Cristo non fosse stato risvegliato...!": 1 Cor 15,14-17.20 — è praticamente cessata dopo il sec. 8°, il secolo della crisi di tutte le Chiese, quando si formano le lingue nuove, il popolo non can-ta, cantano le scholae, si ascolta l'Èvangelo nelle lingue "sacre-incom-prensibili", mutano i temi della predicazione, non si comprende il va-
152 1

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
lore essenziale assoluto della Coppa preziosa, il pane si fa sempre più cartavelina, il popolo non comunica quasi più, le sante icone gli sono negate e rientra in chiesa l'arte pagana e idolatrica delle statue. La pre-dicazione che investe la dottrina dello Spirito Santo non è quasi mai veramente esistita. Quella sulla Trinità santa si cala in formule non bi-bliche. Gli effetti "a lungo andare" sono quelli che ci sono dati da ve-dere oggi: devastanti.
b) Le persone il luogo il tempoII celebrante spezza il Pane della Parola, poi quello dei Misteri con
la Coppa, "a noi — qui — oggi", nel concreto personale spaziale tem-porale. Né ieri o domani, né lì, né ad altri. Perciò ogni volta vanno ri-chiamate, sia pure, come si è detto, per cenni rapidi, queste realtà vitali:
- "noi": la Chiesa Sposa e Madre, corpo di Cristo, popolo di Dio, tempio dello Spirito Santo, la "carne dalla carne" dello Sposo Risortocon lo Spirito, che celebra il suo Signore, accetta da Lui lo SpiritoSanto per il ritorno al Padre. La Famiglia di Dio, la Casa di Dio, tuttabattezzata e confermata: Efes, 4,1-7. Si deve richiamare il battesimoin ogni omelia. Poiché qui oggi sta la Sposa orante e santificata esantificante nello Spirito battesimale e crismale, avviata verso la divinizzazione di tutte le sue membra fedeli, in specie quelle che soffrono, Chiesa Icona fedele della Sposa, Icona di icone fedeli ad operadello Spirito Santo, ciascuna tutta e per intero la "immagine e somiglianzà di Dio", i "figli nel Figlio";
- "qui": in questo "luogo", come Chiesa locale, sta presente tutta laChiesa Una Santa, poiché tale è questa assemblea di oggi qui, cheprega come "la Chiesa", come tutta la Chiesa, la Una Santa, la Sposa— e non una parcella sia pure importante di essa. E la sua celebrazione, la nostra celebrazione è unica e totale, non è una parte della celebrazione complessiva della Chiesa universale, come se la celebrazione fosse parcellare. La Chiesa "qui" è "tutta la Chiesa qui", non èparte isolata. Sta in comunione di fede e di amore con tutte le Chiese,la Una Santa. E il sacrificio che accetta e che offre è "tutto il Sacrificio di Cristo", non una parte. E supplica ed intercede come tutta laChiesa qui presente. Valore infinito, dunque, della celebrazione"qui"; la territorialità della Chiesa è sempre teologica e salvifica;
- "oggi": questo giorno, questa Domenica, questa occasione, l'"Oggi diDio" e della grazia dello Spirito Santo, nel continuo del "tempo dellaChiesa" che dalla Pentecoste si tende all'infinito verso il Ritorno delSignore con lo Spirito Santo. Perciò va richiamato il "continuo", percenni sobri: quanto celebrato "ieri", ad esempio Domenica passata; equanto, se il Signore lo vuole, sarà celebrato "domani", ad esempio
153

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
Domenica prossima, seguendo la linea stupenda degli Evangeli. Così nel "continuo celebrativo" noi facciamo esodo con la Grazia divina ver-so la Casa del Padre che ci attende. Per questo siamo "noi qui oggi".
e) La Parola del Mistero divinoLa comunità deve essere consapevole che Cristo si fa presente con
la Parola sua alla Chiesa sua per l'operazione continua dello Spirito Santo, forma preziosa tra le diverse forme della Parousia (Mt 28,20b) del Signore ai suoi. Si procede quindi adesso ad esporre come il Signore Risorto con lo Spirito Santo si faccia a noi presente oggi qui, a partire da "questa" pericope dell'Evangelo. La conoscenza del Lezionario dice formalmente che l'Evangelo del giorno è come il "varco" a tutto il Mistero di Cristo celebrato sempre per intero, come si vedrà. Interpre-tato sempre a partire dalla Resurrezione con il dono dello Spirito Santo, l'Evangelo riporta un episodio della vita storica del Signore. Il quale, battezzato dallo Spirito Santo e trasfigurato dalla Luce e dallo Spirito Santo, "passa Operante-il-bene" (cf. At 10,38), cioè le "opere del Re-gno". Queste consistono essenzialmente nell'annuncio dell'Evangelo con l'insegnamento relativo, e nella riconquista di questo Regno al Pa-dre per la potenza dello Spirito Santo: in "segni" (guarigioni, resurre-zioni dei morti, espulsioni dei demoni, poteri sulla natura creata, molti-plicazioni di pani e pesci, vocazioni di discepoli). Inquadrato l'Evange-lo dagli altri testi, in breve, si segue fedelmente il testo; se ne da in bre-ve il contesto precedente e seguente; se ne illustra la vera intelligenza, che è anche dal fatto che la Parola è qui celebrata, e dunque offre molte virtualità che la sola esegesi non è in grado di ricavare. Perciò si richia-ma sempre, a conclusione dell'esposizione, il Koinònikón, che attua qui per noi oggi questo Evangelo nei "segni" santi del Mistero. Solo adesso si passa alla Promessa, i testi dell'A.T., se vi sono o vi sono allusi; poi-ché il N.T. attua solo la Promessa, non innova il Disegno divino. Se non si legge l'A.T., si prende spunto dai versetti dei Salmi. Si mostra il Disegno ininterrotto del Signore, la sua assidua Misericordia, nell'e-sperienza orante del popolo di Dio. E si mostra così in più che i Salmi sono canto necessario, a cui il popolo di Dio è strettamente ed imme-diatamente vincolato, come mostra l'intera Tradizione; sono il canto gioioso che accoglie, anche con la dovuta compunzione, il Disegno vi-vificante che il Signore rivela nella sua Parola a noi donata con tanta larghezza.
Infine si passa ad illustrare YApóstolos. Questo riporta l'esperienza di fede degli Apostoli, alcuni dei quali vissero con il Signore prima e dopo la Resurrezione (cf. At 1,4.21-22; 10,41), oppure furono investiti dalla sua Luce irresistibile (Paolo); tutti Lo testimoniano come Risorto
154

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
con lo Spirito Santo, nella fedeltà dell'esistenza e nella veridicità che giunge fino al dono della vita, dando alle generazioni future il tipo e la norma della loro fede divina vissuta, che va vissuta anche come la no-stra fede, che non è altro che la loro fede.
Se si prepara bene tutto, è possibile tenere l'omelia in 15-20 minuti, parlando tutto quello che serve, e parlandolo bene. In fondo si trovano in maggioranza due psicologie di predicatori — non "omileti", ma dici-tori —, quelli che non si sono mai accorti che annoiano per la lunghez-za del loro parlare, e del vuoto teologico del loro parlare. Non conosco-no la norma biblica di Prov 10,19: "Ekpolylogias ouk ekphéuxè ha-martian, pheidómenos de cheiléón noèmón ésè, Dal multiloquio non si sfugge al mancamento, risparmiando le labbra si sarà intelligente"; poi vi sono quelli che hanno paura di annoiare, ed allora presumono "in 5-6 minuti di dire l'essenziale".
Il valido omileta evita i due eccessi, preparandosi sempre con uno schema, raccogliendo l'essenziale per gli ascoltatori, e dovrà sempre fissarlo su schedine da tenere nella pagina della Scrittura che riporta l'Èvangelo del giorno; tali schede vanno conservate, e rielaborate anno per anno in meglio.
È uso salutare, che dovrebbe essere sentito come obbligo, che l'o-mileta regga sempre nelle mani il libro dell'intera Scrittura, metten-do i segnacoli alle pagine che riportano i testi biblici del giorno, e questo per due scopi, anzitutto avere sempre il Testo sacro davanti agli occhi, in modo che nulla ne sfugga; e poi per dare agli ascoltatori la plastica certezza che il contenuto mistagogico dell'omelia pro-venga direttamente dalla Scrittura. Uso salutare che dobbiamo risco-prire nei Padri della Chiesa che lo praticavano sempre, in Oriente co-me in Occidente. Gli specialisti dell'omiletica patristica qui citano in specie S. Basilio il Grande, Horn, in Ps. 61, in PG 29,469 B, che dice di avere il Salmo "tón en chersi, sulla mano"; S. Giovanni Crisosto-mo, quando ad esempio afferma: "Per non lavorare invano, vi rileg-go la Parola dal suo inizio" (è la pericope del giorno; Horn. I in La-zarum ili. pauperem, in PG 48,970); "Anzitutto vi leggerò la legge (sul matrimonio, 1 Cor 7,1 ss), e poi cercherò di spiegare l'altra norma che sembra contraddirla" {Horn, in 1 Cor 7,39a, in PG 51,218); "Veramente l'ultima frase (della pericope liturgica letta) sembra con-tenere straordinaria oscurità, però se guardiamo attentamente, avre-mo bisognò di una soluzione semplice. Allora sarà bene che prima di tutto ascoltiamo il tenore delle sue parole" {Comment, in Mt., Horn. 41,3, in PG 53,450); quando afferma di toccare con le mani (hapsà-menos) il testo biblico letto (Comment, in Gen., Horn. 21,1, in PG 53,166). Questi e molti altri testi riporta lo specialista Alexandre
155

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
Olivar, La predicación cristiana antigua, Barcelona 1991, nell'Ap-pendice "Sull'uso di reggere nelle mani un codice (scritturistico) du-rante la predicazione" (pp. 634-640); l'autore è monaco del Mona-stero di Montserrat.
d) II Mistero totalmente celebratoIn termini moderni, si parla di "linguistica celebrativa", cioè della
globalità degli elementi che formano la celebrazione: l'assemblea ge-rarchica, la Parola, i "segni" dei Misteri divini, i canti, i gesti, il luogo, il momento, gli altri "segni" concreti, come le icone, l'altare, l'ambone, il battistero, le luci, l'incenso, gli altri elementi naturali, la Croce, la coppa, e così via. Tutto questo forma una "linguistica", un modo di esprimersi, il modo di esprimersi celebrando, il meraviglioso Gioco gratuito che è la Liturgia della Chiesa. Il Mistero celebrato in realtà può essere celebrato solo e sempre come globalità e totalità, mai in modo parcellare: l'anamnesi storica, sacrificale, offertoriale che congloba l'e-piclesi allo Spirito Santo, è "monotona", poiché fa memoria, ossia ac-cetta sempre ed invariabilmente il Signore nostro nell'intero suo even-to: la Croce, il Sepolcro, la Resurrezione al terzo giorno, l'Ascensione ai cieli, l'intronizzazione alla Destra, la seconda e gloriosa nuova Pa-rousia. È l'indizio prezioso che tutto va riportato al Mistero celebrato per intero davanti al Padre mediante Cristo Risorto nello Spirito Santo. Va ricordata qui l'occasione della celebrazione in atto: soprattutto la Domenica, "la Festa delle Feste", la principale tra tutte le celebrazioni per importanza e per frequenza; e poi una Festa, una feria; va spiegato in breve il suo significato specifico, da riconnettere sempre alla globa-lità "linguistica". Va poi accennato precisamente che tra poco la santa Anafora tramuterà tutto questo in sublime preghiera di "sacrificio soa-ve" al Padre: con essa noi lodiamo, benediciamo, ringraziamo, adoria-mo, supplichiamo, intercediamo al fine supremo di ottenere lo Spirito Santo divinizzatore su noi e sui Doni, e affinchè Egli riversi la sua Gra-zia infinita su noi, su tutta la Chiesa, su tutti i viventi per le loro neces-sità nel Disegno divino, affinchè aumenti la gioia e la gloria dei Santi a causa della nostra conversione e fede e carità e grazia (la gioia nel cie-lo: Le 15,7 e 10!), e per la pace divina su tutti i defunti.
e) La comunione al Corpo e Sangue del SignoreNon deve mancare mai l'invito esplicito e pressante affinchè l'as-
semblea partecipi compatta alla comunione del Convito nuziale che si celebra, Convito del Corpo del Signore, comunione al triplice Corpo del Signore, come si è detto: la Parola, la Mensa, la Chiesa Sposa. Qui sta il culmine operativo dell'omelia mistagogica: qui il Padre mediante
156

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
il bravo e buono omileta chiama tutti i figli suoi nel Figlio, affinchè di-ventino e siano per sempre la Famiglia sua, la Sposa del Figlio suo, per la potenza dello Spirito Santo ricevuto adesso dalla Parola, dai divini Misteri e dalla Chiesa Sposa e Madre feconda di figli. Non è male de-nunciare anche i pretesti più o meno consapevoli, sempre ambigui, che fanno sottrarre i fedeli alla comunione, la koinònia dello Spirito Santo, e la rimozione di tali pretesti (ad es., la crisi della confessione).
f) La situazione dì questa ComunitàEcco finalmente il tanto invocato "concreto" quotidiano. "Questa
Comunità": è formata come vera Comunità? Che cosa lo favorisce, co-me porlo in operazione; che cosa lo impedisce, come rimuoverlo. Que-sta Comunità qui, oggi, nel mondo; accenni sobri e sottolineature e fatti conosciuti, favorevoli e non favorevoli, anche denunce di fatti inconve-nienti — anziché scagliarsi sempre contro assenti o lontani... —; anche accenni a problemi e necessità di gruppi e di singoli; gli aspetti aposto-lici, di conversione del cuore; gli aspetti sociali ed organizzativi; aspetti ecumenici; la mancanza eventuale di scambio vitale tra i fedeli, tra i gruppi ecclesiali. Di tutto ciò, evidentemente, i dibattiti seri si saranno tenuti prima, e si terranno anche dopo, mai durante la celebrazione. La celebrazione evidenzierà solo alcune linee e spunti di soluzioni in co-mune e personali, propositi seri, impegni totali. Ricordare sempre che occorre la "conversione del cuore" permanente, condizione da vivere di continuo, in modo personale ed in comunità. Poiché "questo celebrare qui di oggi e di noi" è il "culmine": vi si giunge dopo avere operato nella grazia le opere del Regno; ed è la "fonte": se ne riparte con la "confermazione" per seguitare ad operare nella grazia accresciuta le opere del Regno. Con l'Evangelo da portare al mondo e con la celebra-zione dei Misteri, il "sociale" è un preciso fatto "liturgico" per i cristia-ni, non è aconfessionale né anonimo né a titolo personale. Poiché il medesimo Signore ha dato l'imperativo "Fate (tutto) questo per fare memoriale di Me!", intendendo tutto ciò di cui nella Cena prima (non "ultima") ha reso grazie nello Spirito Santo al Padre, dunque la sua Vita e le sue opere mirabili e la Preparazione antica, come concentrate nel suo Corpo e nella sua Coppa: e Vita ed opere da. fare adesso noi. E sia-mo battezzati e confermati per celebrare e poi fare, e non vi siamo spinti da ideologie di moda e da sociologismi nefasti e transeunti.
g) II fine: la Gloria divina e la divinizzazione degli uominiL'unico fine dell'esistenza umana redenta dal Signore morto e risor-
to per ottenere lo Spirito Santo, è la Gloria divina e la grazia della divi-nizzazione per gli uomini. Sono anche le due uniche realtà finali, quelle
157

CELEBRARE CRISTO NELLA SUA PAROLA
eterne. Sono lo scopo finale di "questa" celebrazione. Esse vanno por-tate al mondo, con ansia apostolica, e disinteressatamente. Di esse va di continuo fatto richiamo, affinchè tutti i fedeli ne prendano coscienza storica cristiana, coscienza di fede e di grazia infinita. Il resto va siste-mato in relazione; quando non sia fumo, sogno, inganno.
A') La dossologia conclusivaRivedere il par. A), sopra, naturalmente con una formula diversa da
quella iniziale. La vita cristiana in effetti è Grazia gratuita, ed è dosso-logia di risposta accettante. Ora, la pastorale deve essere dossologica. La mistagogia al più alto livello è dossologica. La dossologia finale dell'omelia, come quella della Prece eucaristica, e le altre dossologie che di continuo trapuntano e costellano la nostra celebrazione, sono co-me il sigillo di amore riconoscente e laudante che poniamo alla Grazia sovrana che ci viene dall'Alto, a tutto il Bene divino messianico che ci investe con la presenza del Risorto mediata sempre dallo Spirito nella Chiesa, in infinita effusione. E questo amore deve innalzarsi alla lode pura: "a Dio perché è Lui!". Se ne tratterà anche dopo.
Qualche nota conclusiva, ma lasciando sempre tutto il discorso aper-to perché è inesauribile, sembra necessaria per alcune accentuazioni necessarie.
Tutto questo, ed in secondo luogo, è sana norma, e ne deve venire finalmente la sana coscienza, la coscienza dell'"esercizio sacerdotale omiletico", il medesimo esercitato dal Signore e dagli Apostoli, che l'omileta, accuratamente, dovutamente preparato, avendo anche molto pregato in sé lo Spirito della Sapienza divina, e poi sui testi del giorno stesso, si tenga rigorosamente fedele a questa sua missione ecclesiale sacerdotale consacrata dalla Grazia dello Spirito Santo, missione pasto-rale mistagogica dell'Annuncio continuo, celebrativo, il più solenne. Questo è dunque tenersi rigorosamente fedeli alla Parola divina che salva, ed allo Spirito Santo che l'ha ispirata una volta per sempre, do-nando anche l'intelligenza delle sue realtà ultime. Non si deve temere perciò, né ci si deve vergognare di usare il linguaggio cristiano, tutto e francamente, non il linguaggio di moda. E di annunciare così tutto il contenuto della Parola di oggi.
Questo è anche tenersi rigorosamente fedeli al popolo santo del Dio Vivente, alle sue necessità ultime di santità, alla sua intelligenza dona-tagli dallo Spirito Santo. Nell'omelia celebrativa la mistagogia, se si vuole innalzare il popolo, si dovrà alzare di tono, sempre. Non abbas-sare il tono alla banalità ed ali'ovvieta, mai. Trattare il popolo battez-zato e crismato da popolo santo, maturo, adulto, consapevole. Non tra-
158

CAP. 6 - L'OMELIA CELEBRAZIONE PRIVILEGIATA
dirlo con pedagogie puerili, sotto il livello della sua intelligenza. Se per assurdo fosse ancora un popolo "bambino", operare affinchè cre-sca e non resti assurdamente bambino. Occorre donare altro ed altro alla sua intelligenza di fede, al suo "intelletto di amore", poiché nella comunità cristiana deve abitare lo Spirito Santo, la Sapienza divina sussistente "che ama dimorare in mezzo al popolo santificato" (Eccli 24,12, cf.vv. 10-11).
159