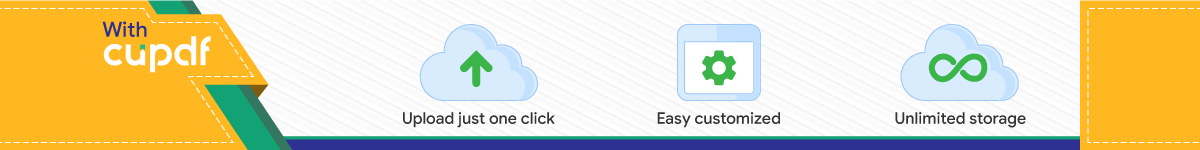

ANNALI 2007 92
Adriana ha confermato quanto affermato da chisosteneva l’inconsistenza dell’identificazionedell’area con il sepolcro di Antinoo (chiamatodall’autore dello scavo Antinoeion), che pure eradata per certa dagli autori dello scavo.
Nessuna traccia è stata infatti rinvenuta del-la camera funeraria dove sarebbe stato depostoil corpo del favorito di Adriano, morto annega-to nel Nilo durante il soggiorno egiziano del-l’imperatore.
Si è, invece, con ogni probabilità di frontead un ninfeo monumentale, simile al Canopo,seppure meno imponente, con due tempietti(poco più che edicole) forse dedicati ad Iside eSerapide, se davvero gli elementi egittizzantirinvenuti nell’area fossero collocati in originepresso la Grande Esedra e non, come non è daescludere, provenienti dalla spoliazione di altrezone e qui abbandonati in epoca post antica.
Ne emerge un quadro del tutto differenteda quello che, con eccessivo ottimismo, era sta-
da noi addotti in precedenti studi, anche per gli ele-menti nuovi emersi dalle ricerche sul monolite e dicui si tratterà preliminarmente in questa sede.
Come altrove ipotizzato, l’obelisco doveva appar-tenere probabilmente ad una coppia: nuovi elementisembrano confermare questa teoria.
Ovviamente si tratta di ipotesi che andranno ap-profondite e che qui vengono anticipate sia pure contutte le cautele del caso.
Se, infatti, le fasi conclusive degli scavi del ninfeodella Grande Esedra hanno mostrato la totale assenzadella supposta camera funeraria e della base dell’obe-lisco, l’analisi di un frammento di obelisco in granitorosso di Assuan ora ai Musei Capitolini ed il riesamediretto dei testi dell’obelisco del Pincio ci permettonodi addurre nuovi elementi.
Nella collezione egizia del Campidoglio è conser-vato un frammento di obelisco in granito rosso (cat.3) misurante m 0,33x0,22x0,231.
to prospettato come certonegli scritti degli autori del-lo scavo, e che porta adescludere definitivamenteuna sepoltura di Antinoood anche la presenza di unsuo luogo di culto nell’areadella Grande Esedra.
Nel corso di tutte lecampagne di scavo condot-te a partire dal 2001 non èmai emerso un singolo ele-mento riconducibile, ancheindirettamente, al giovanebitino, e tantomeno alla suasepoltura in loco.
Ciò coincide con quan-to sostenuto dalle fonti an-tiche (compreso il medesi-mo obelisco variano) circauna spoltura egiziana diAntinoo: ancora nel IV se-colo Epifanio di Costanzane menziona la tomba adAntinoe.
Dagli ultimi scavi nep-pure sono emersi elementinuovi riguardo alla pretesacollocazione tra i due tem-
Il pezzo presenta parte didue lati di un obelisco coniscrizioni geroglifiche, inqua-drate da linee parallele verti-cali come tipico degli obeli-schi d’età romana; due latinon sono conservati.
Il frammento riporta suuna faccia l’iscrizione:...Wsir a[...]...,ovvero:...Osiride A[...] ...;
si tratta dell’unica parte leggi-bile.
I segni sull’altra facciatasono troppo frammentari peressere letti. Appare pertantopiuttosto ragionevole ritenereche l’iscrizione vada integratacome Wsir a[ntynw], OsirideA[ntinoo].
Nel frammento il nomeWsir appare seguito dal gero-glifico b (a), l’inizio del no-me Antinoo.
In nessun obelisco di Ro-ma attualmente noto, trannequello del Pincio, esiste unaassociazione tra Wsir e termi-ni inizianti con a, né del restogli appellativi che usualmen-
ANCORA SULL’OBELISCO ADRIANEO DEL PINCIOPIERLUIGI ROMEO
OBELISCO DI ADRIANO AL PINCIO (ROMA)
L a conclusione degli scavi condotti a partire dal2001 nell’area della Grande Esedra di Villa
pietti dell’obelisco oggi al Pincio, una collocazione che anostro parere è da escludere, oltre che per gli argomenti

ANNALI 200793
te seguono il nome del dio iniziano con a; si tratta sicura-mente dell’inizio di un nome proprio: ciò è assolutamen-te inusuale su un obelisco, essendo documentato per il so-lo Antinoo.
La stessa presenza del nome Osiride è inconsueta neitesti di un obelisco, in quanto il dio aveva una valenza fu-neraria piuttosto che solare; del resto nel frammento ca-pitolino si tratta chiaramente del nome di un defunto pre-ceduto da Wsir.
Si deve escludere il nome di un imperatore o di un’ im-peratrice, in quanto non scritto in un cartiglio, come sa-rebbe stato ovvio; e anche va escluso possa trattarsi di unprivato, vista la provenienza egiziana del granito rosso, ec-cessivamente dispendiosa da procurarsi, per di più da cavedi proprietà imperiale.
Oltre al materiale, anche lo stile e la grafia dei caratte-ri geroglifici ed il fatto che l’iscrizione sia delimitata da duelinee parallele incise datano il pezzo alla media età impe-riale, e presentano una corrispondenza perfetta con l’obe-lisco del Pincio.
Il pezzo venne rinvenuto inglobatonelle mura Aureliane2, nella zona traPorta Maggiore e l’anfiteatro Castrense,non lontano dunque dall’area del Circodi Elagabalo, luogo dove agli inizi delXV secolo era stato dissotterrato l’obe-lisco attualmente visibile al Pincio3.
Particolarmente importante apparela menzione di Osiride, come accenna-to piuttosto inusuale negli obelischi (eche, in quelli romani compare solo neitesti di quello del Pincio) in quanto le-gata all’ambito funerario.
Nel caso dell’obelisco aureliano in-fatti il nome del dio compare a causadell’identificazione tra Osiride ed ildefunto, ciò che costituisce un unicumnei testi dei monoliti d’età imperiale.
Va sottolineato come il blocco ca-pitolino non sia un frammento pro-veniente dal monolite del Pincio, ilquale non presenta fratture nelle co-lonne di testo in corrispondenza delnome di Antinoo, ma costituiva sicu-ramente parte di un secondo obeli-sco.
La posizione del nome di A[nti-noo] (se l’integrazione proposta quiè corretta) porta ad ipotizzare che sipossa trattare forse di un frammen-to proveniente dalla parte superioredel tronco dell’obelisco, speculare altesto del lato del monolite oggi alPincio, convenzionalmente indicatocome I4, in cui si parla della dedicadi un tempio al favorito dell’impe-ratore dopo la morte per annega-mento nel Nilo.
Ciò per la posizione del nome,
tenendo però conto che non è assolutamente possibile ten-tare alcuna ipotesi sul contenuto del testo. Sull’ipotesi del-l’appartenenza dell’obelisco pinciano ad una coppia chiscrive aveva già avanzato tali ipotesi5 ricordando come tut-to ciò che era noto degli obelischi la rendesse estrema-mente plausibile; la probabile identificazione del fram-mento capitolino con il gemello conferma ulteriormentel’infondatezza delle tesi avanzate da chi pretendeva unaprovenienza dell’obelisco aureliano dal preteso Antinoeiondi Villa Adriana, dove non esiste lo spazio per una coppiadi obelischi.
È interessante ricordare come Serena Ensoli Vittozziabbia collegato all’obelisco del Pincio la rappresentazionesul grande cratere a campana in granito nero anch’esso nel-la collezione capitolina6 sul quale sono scolpite varie fi-gure in stile egittizzante, alcune delle quali sicuramentesono statue, e due obelischi, uno posto di fronte ad unadivinità con la corona doppia (Atum) e ad un airone – ilbecco dritto esclude che sia un ibis – ossia l’uccello Bnnw,
sacro al dio (dai greci identificato con la fe-nice), l’altro davanti al falco sacro a RaHorakhty e ad Iside Sothis.
Si tratta delle due forme del sole, altramonto ed al mattino e quindi all’occi-dente ed all’oriente.
Se si trattasse della raffigurazionedell’obelisco del Pincio sarebbe la con-ferma che questo fosse, come sempre,parte di una coppia7.
Ensoli Vittozzi interpretò la coppiadi obelischi come eretti presso la tom-ba od il cenotafio di Antinoo8; se cosìfosse, l’ipotesi della Grande Esedra co-me luogo di sepoltura o di culto delgiovane bitino sarebbe anche in que-sto caso da rigettare, perché mancaassolutamente lo spazio per due obe-lischi.
La presenza di pini marittimi nel-la decorazione del cratere confermache la scena è ambientata in Italia,forse nella stessa Villa Adriana; vaperò detto che sul cratere Antinoonon appare rappresentato.
Potrebbe dunque essere la rap-presentazione di un Serapeo, comesembra indicare la rappresentazio-ne di una statua di Serapide assiso,barbato, e con la doppia corona9,davanti al quale un personaggio in-ginocchiato reca offerte. Specular-mente a Serapide, sul lato opposto,è rappresentata Iside - Sothis, iden-tificata da una piccola figura cani-na posta sopra la testa (Sirio era lastella del cane)10. Mancano poi di-vinità funerarie quali Osiride o
Anubi.Tuttavia il testo dell’obelisco del
LATO I. MENZIONE DELLA DEDICA DELTEMPIO AD ANTINOO. SI NOTI LA FRATTURADEL TESTO IN CORRISPONDENZA DEL NOMEROMA E LA MENZIONE DI dSrt

ANNALI 2007 94
Pincio e numerosi documenti11, ultimo dei quali la testi-monianza di Epifanio nel IV secolo d.C. sono concordinell’indicare come Antinoo sia stato sepolto in Egitto: intal caso se realmente i due obelischi rappresentati sul cra-tere sono quelli dedicati al giovane bitino è allora da ve-dere nei rilievi la rappresentazione di un tempio romanoda cui i due monoliti provengono; e il fatto che sia ilframmento capitolino che l’obelisco del Pincio siano sta-ti rinvenuti in luoghi vicini tra loro porta a ritenere chedovessero sorgere presso la zona di Porta Maggiore, un’a-rea dove erano diffusi culti orientali, come prova il mi-treo di Piazza Dante, forse da ricondurre alla presenzadegli Equites Singulares Augusti, ai quali Antinoo apparelegato dalla nota raffigurazione della caccia al leone orasull’arco di Costantino12.
Va però detto che il testo dell’obelisco del Pincio fa ri-ferimento esclusivamente all’Egitto, e più precisamentealla zona di Ermopoli, che sorgeva sulla riva occidentaledel Nilo, quasi di fronte ad Antinoe13.
Si deve sottolineare come sino ad oggi, anche da chiscrive, le traduzioni siano state condotte sulla vecchia tra-scrizione effettuata nel XIX secolo da Orazio Marucchi14,e ripresa da autori quali E.A. Wallis Budge. Un esame di-retto del testo, compiuto da chi scrive sulla base di foto-grafie, ha permesso di emendare tali inesattezze.
Nel celebre e discusso passo relativo all’istituzione diun tempio in onore di Antinoo (tempio che alcuni hannopreteso di interpretare come tomba!) uno dei termini piùdiscussi era quello variamente tradotto come campo, villa,o persino giardino: ciò sulla base della trascrizione s�t di
tre infiorescenze di palma; in realtà non si tratta del trilit-tero s�t (4) ma di iy (111), una ben nota variante di iw, es-sere15: esaminando il testo, sotto le tre infiorescenze dicanna non compare la barretta (il terreno), ma il segno d(f), che forse per problemi di prospettiva venne confu-so con la base dei tre segni sovrastanti, alterando la letturadi questa parte dell’iscrizione. Le fotografie allegate per-mettono al contrario una lettura esatta.
Ciò dimostra come l’esame diretto rimanga fondamen-tale per una corretta interpretazione del testo antico16.
La trascrizione del passo è la seguente:(...) antyniw nty m htp m iAt tn nty m- Xnw nty iy dSr[t] n nb
wAs[...] [manca la parte inferiore per la frattura delfusto]... [...]h rwma (...)
(...) Antinoo che si rallegra in questo santuario posto al-l’interno di dSr[t]17 del signore di wAs[t?] [...]h ...diRoma (...)
Oltre questa riga il testo presenta un’interruzione do-vuta alla frattura.
Che non si tratti di una tomba è piuttosto chiaro: iAt (o)indica un tempio: così nei testi si incontrano iAt Sbk (il tem-pio di Sobek) nel Delta, iAt PtH (il tempio di Ptah) nelFayyum, iAt �rwy, iAt MaAt (il tempio di Ma’at ad Edfu), ildistretto di iAt Nkhbt (lett. Il Santuario di Nekhebt) nel no-mo diospolitano, solo per citare qualche nome tra le deci-ne possibili18. Fondamentale per la comprensione del testoè poi la presenza dell’indicazione geografica
fQxO Q
dSr[t], seguita dal determinativo di località (e non da quel-
ROMA, VIA OZIERI. ISCRIZIONE COMMEMORATIVA DEL RITROVAMENTO DELL’OBELISCO DEL PINCIO

ANNALI 200795
lo di edificio come sarebbe stato se ci si fosse riferiti allavilla tiburtina19).
La menzione di dSr[t] fa parte di un esplicito riferi-mento all’identificazione tra il defunto Antinoo ed Osiri-de, che nel capitolo CXLIII della redazione saitica del Li-bro dei Morti è chiamato Wsir nb dSr[t]20, Osiride signoredi dSr[t].
Piuttosto che come una città il toponimo dSr[t] è tut-tavia da intendere come il deserto orientale, quello ai cuimargini venne fondata Antinoe21, ossia, traducendo let-teralmente, la terra rossa, contrapposta alla terra nera, ov-vero la parte fertile.
È ben noto come i templi funerari ed i sepolcri sorges-sero nel deserto, così come oltre la terra fertile era statacostruita la maggior parte di Antinoe, che si ergeva in unluogo ove la fascia coltivabile è limitata a pochi metri.
La lettura dSr[t] è assolutamente certa, e ci pare possacontribuire a risolvere il dubbio sulla collocazione del san-tuario di Antinoo in Egitto, nella città a lui dedicata22.
Le argomentazioni favorevoli alla sepoltura tiburtina diAntinoo sono da ritenersi del tutto infondate, almeno sullabase dei testi dell’obelisco superstite, anche perché appareassai improbabile che in età romana qualcuno abbia pen-sato di associare il deserto alla villa imperiale di Tivoli.
Quanto alla menzione di Roma (...h23 rwma) è segui-ta da ben due determinativi: quello di città (Q) e quello disantuario (o) lo stesso segno che, come trilittero iAt, èusato per indicare il santuario di Antinoo24.
Più che alla città di Roma, il testo sembra quindi far ri-
ferimento ad un tempio, con ogni probabilità l’Αδριανειονdi Antinoe, nel cui nome era presente il nome Roma: i ter-mini nb wAs potrebbero far riferimento all’imperatore: perAdriano divinizzato è attestato l’epiteto corrispondente diευεργετικωτατος κυριος 25.
Una seconda possibilità è che si faccia riferimento adAmon Ra, titolare del tempio di età ramesside che sorge-va nel sito di Nefrusy, dove sorse poi Antinoe: in tal casobisognerebbe integrare con nb wAs[t] Signore di Tebe26: iltempio di Ramesse II eretto presso quella che divenne An-tinoe era dedicato al culto delle divinità di Eliopoli ed Her-mopolis Magna, gli stessi dei rappresentati sull’obelisco27;è legittimo ritenere che si trattasse delle divinità poliadi diNefrusy, e che tali siano rimaste anche dopo la fondazio-ne di Antinoe il che spiega la loro presenza sull’obeliscoora al Pincio. Tuttavia resterebbe oscura, anche per la la-cuna e la possibile perdita di caratteri geroglifici, la men-zione di Roma.
La traduzione proposta da Iversen di un tempio dellaTykhe Romana28, per quanto dubbia, ci sembra un’ipote-si possibile, anche se, alla luce della menzione di dSr[t] cisembra che tale tempio non sia eventualmente da collo-care a Roma, come pensava lo studioso danese, ma ad An-tinoe29.
Ancora un’osservazione può essere utile: nella rappre-sentazione della cuspide rimane la figura di Onhuris nel-l’atto di offrire all’imperatore (non ad Antinoo!) il segno· sd, tradotto convenzionalmente con giubileo.
Con questa cerimonia, risalente almeno all’Antico Re-
ROMA. MUSEI CAPITOLINI - CRATERE A CAMPANA, RILIEVI B E A

gno, nel corso di taluni riti compiuti presso le Case delNord e del Sud, due templi raffiguranti il Basso e l’AltoEgitto (rappresentati nel geroglifico), il vigore e la forzagiovanili. Hornung sottolinea come la scena della cuspidevada ricollegata con l’emissione di monete in cui Adrianoviene definito Hadrianus ren[atus]30 la cui coniazione de-ve essere posta in relazione con il viaggio in Egitto e la par-tecipazione alle cerimonie della festa sed31.
Grimm, sulla base di Marucchi e delle vecchie inter-pretazioni delle statue adrianee di faraone come “AntinooOsiride”, non riesce a spiegarsi perché il favorito bitino-contrariamente a tutte le tradizioni egiziane - venga rap-presentato sull’obelisco al posto dell’imperatore, o comefaraone nella statuaria, e collega ciò alle cerimonie giubilaried all’appellativo di renatus, legato al compimento di taliriti di ringiovanimento: tuttavia ancora una volta, la festased è esclusivamente regale (e si compie per il sovrano vi-vente!) e l’appellativo renatus è attestato dalla documen-tazione antica esclusivamente per Adriano32.
Ciò ci conferma nella nostra proposta di vedere in ta-lune statue (se non in tutte) Adriano sbarbato secondo latradizione egiziana33, ed identificato con �. r wr, Horus ilGrande: va detto come talune statue raffigurino certamen-te Antinoo, ma senza ureo sul nemes: ciò ha riscontro inuna statua di Antonio, oggi al museo del Cairo34.
Si tratta però di statue che, contrariamente a quantospesso affermato, non presentano alcun riferimento ad Osi-ride, come notò anche Grimm, ma sono rappresentazionidi Antinoo (se di lui davvero si tratta) vivo, eseguite primadella morte del favorito dell’imperatore.
Per tornare alla festa sed può esser degno di nota comesul pilastro dorsale della statua assisa frammentaria di Ra-messe II rinvenuta nell’area della cd. Grande Esedra com-paia l’epiteto Signore delle feste Sed come suo padre [Ptah]Ta[tenen]35, che forse può aver contribuito alla scelta del-la statua per la collocazione (probabile ma non certa) inun’area dove incidentalmente sorgevano due tempietti af-frontati, in un ambito sicuramente legato all’Egitto e cherichiama fortemente l’esedra-ninfeo campense36.
Appendice
Traduzione dell’obelisco del Pincio.
Nota.Forniamo qui la traduzione completa dei tre lati del-
l’obelisco che fanno riferimento ad Antinoo.Malgrado la frammentarietà del passo qui emendato,
la menzione del deserto orientale dSr[t] si inserisce – benpiù coerentemente delle vecchie traduzioni basate sullatrascrizione errata – nel quadro esclusivamente egizio deitesti dell’obelisco, che collocano tutta la vicenda della mor-te, della sepoltura e del culto di Antinoo nell’area di Er-mopoli. La sequenza di lettura dei testi è la seguente: la-to II, con l’iscrizione dedicatoria di Adriano e di SabinaAugusta, lato III (speculare alla dedica dei sovrani sul la-
ANNALI 2007 96
to II 37), come dimostra l’incipit sulla morte di Antinoo,lato I e lato IV.
Il lato III inizia con Antinoo che riceve l’ordine divinodi andare nell’aldilà38, e viene imbalsamato dai sacerdoti,entrando nella Sala Ma’aty al seguito di Osiride.
Antinoo viene adorato nel nomo di Ermopoli, e Toth,Signore delle parole del dio (nb nTr mdwt) ringiovanisce ilsuo ka, e gli vengono dedicati altari ed un lago sacro; egli,come ax ikr può entrare ed uscire a propria volontà dall’al-dilà, e gli dei guardiani delle Porte gli aprono i chiavistelli.
Il testo prosegue sul lato I con la descrizione del suosantuario nel deserto orientale, forse presso il tempio diAmon (il signore di Tebe [?], nb w3s[t?]) con sacerdo-ti sia egizi che greco-alessandrini; gli viene poi intitola-ta una città abitata da greci (seguendo il modello delleπολιτευµατα tolemaiche).
Il tempio è decorato in stile egiziano e greco.Infine, sul IV lato, è ricordata l’istituzione dei giochi in
onore del giovane (noti dai testi come Μεγαλα Αντινοεια )che hanno luogo nel nomo ermopolitano nell’anniversa-rio della morte di Antinoo.
In tale occasione coloro che lavorano sul Nilo, dove ilgiovane è morto, dopo aver gareggiato, offrono ad Antinoocorone di fiori (le corone di giustificazione, ben note in etàgreco-romane, eco delle Antisterie ateniesi) Antinoo ga-rantisce ai suoi fedeli la guarigione dalle malattie, compa-rendo in sogno a chi dorme nel suo santuario (incubatio).
Si è qui omessa la traduzione del lato II, ovvero l’iscri-zione dedicatoria in onore di Adriano e di Vibia Sabina,che non ha rapporti con il culto di Antinoo.
Lato III.L’Hsy Antinoo, giusto di voce. Era un bel fanciullo, festoso
nel volto (sbh Hr), forte di animo, valoroso come un leone.Avendo ricevuto il comando del dio di andare, gli sono
stati praticati tutti i riti dei sacerdoti hm di Osiride e tutte leoperazioni misteriose del suo libro, tutto il paese ne venne aconoscenza e tutti ne parlarono con ardore39 come mai eraavvenuto sino ad oggi.
I suoi altari, il suo lago sacro, le preghiere per lui gli dan-no il soffio di vita. Nel cuore di tutta la gente di Hermopolis vifu adorazione per lui.
Il Signore delle parole del dio40 ringiovanisce il suo k3.La gente lo ama, lo adora e lo loda, il suo posto è nella
Sala Ma’aty con gli aHw ikr che sono al seguito di Osiride; ilsuo ka è libero di entrare e di uscire secondo la sua volontà, ei Custodi delle Porte della terra del Silenzio41 aprono i lorochiavistelli e spalancano le loro porte per milioni di anni.
Lato I.L’�sy giusto di voce, Antinoo, che si rallegra in questo san-
tuario posto all’interno del deserto orientale (...) del signoredi Tebe[?](wAs[t?]) [...]h di Roma.
Gli è stato eretto un tempio e gli viene tributato culto comead un dio da parte dei sacerdoti hm e dei sacerdoti w3b del-l’Alto e del Basso Egitto e di quelli che sono ad Alessandria.
Gli è stata intitolata una città, abitata dai greci; gli dei e

1) S. BOSTICCO, Cataloghi dei Musei Ca-pitolini, III, Monumenti egizi ed egittizzanti,Roma 1952, 3. - Frammento di obelisco, p. 25.I numeri di catalogo qui utilizzati sono quellidati dal Bosticco.
2) BOSTICCO 1952, p. 25.
3) Il Mari, a sostegno della sua ipotesi sullacollocazione del monolito a Villa Adriana, so-stiene che l’obelisco – che a suo dire non sa-rebbe monolitico, ma composto da lastre (sic!)– sarebbe stato rinvenuto nell’area della Gran-de Esedra da ignoti e quindi portato a Romaagli inizi del 1500. In realtà è noto come l’o-belisco venne ritrovato negli anni venti delXVI secolo nella vigna appartenente a Giro-lamo Milanese fuori Porta Maggiore, la cuiproprietà passò in seguito ai fratelli Marcelloe Curzio Saccocci che lo riportarono alla lucenel 1570. Ci si potrebbe chiedere chi agli ini-zi del 1500 fosse in grado di trasportare unobelisco da Tivoli a Roma salvo abbandonar-lo fuori porta Maggiore, dopo aver vagabon-dato nella campagna romana, e dopo averloseppellito (poiché come ricorda la lapide com-memorativa posta dai fratelli Saccocci, oggi vi-sibile in via Ozieri, venne ritrovato sottoter-ra), senza che di ciò rimanessero tracce nellecronache in documenti d’archivio.
4) Il lato principale dell’obelisco era quel-lo oggi indicato come IV, sul quale comparel’iscrizione dedicatoria ad Adriano ed a Sabi-na, che riveste qui un importanza notevole,tanto da essere l’unica sovrana ad avere nunprenome racchiuso in un cartiglio, e non soloil nome (uniche eccezioni furono regine qua-li Nitocris della VI dinastia ed Hatshepsut del-la XVIII, che però utilizzarono un protocolloreale maschile). Si veda P. ROMEO, L’obeli-sco di Adriano al Pincio ed il presunto Anti-noeion di Villa Adriana, AANSA 6 (2005) pp.6 segg.
5) ROMEO 2005.
6) Cat. 6: BOSTICCO 1952, pp. 25- 26;S. ENSOLI VITTOZZI, Musei Capitolini. Lacollezione egizia, Milano 1992, pp. 47- 50.
7) Anche chi scrive ha avanzato questaipotesi, sulla base della rappresentazione diRa Horakhty sul pyramidion in corrisponden-za del lato con l’iscrizione dedicatoria, pro-
ponendo la possibile esistenza in origine di unsecondo obelisco con la rappresentazione diAtum sulla cuspide (ROMEO 2005, p. 6).L’obelisco del Pincio era collocato sicura-mente sul lato orientale di un tempio, il ge-mello su quello occidentale, se l’edificio fos-se stato orientato su un asse nord-sud, o, piùprobabilmente sui lati meridionale e setten-trionale rispettivamente se il tempio avessepresentato il tradizionale orientamento su unasse est-ovest. Sull’orientamento degli obeli-schi, riconoscibile dalla direzione delle iscri-zioni e dalle divinità raffigurate sul pyrami-dion, R. ENGELBACH, The Direction of theInscription on Obelisks, ASAE 29 (1929), pp.25-30, L. HABACHI, The Obelisks of Egypt.Skyskrapers of the Past, New York 1977 (tr. it.a cura di S. BOSTICCO, Roma 1978), pp.18-19; ROMEO 2005 loc. cit. Nel caso del-l’obelisco di Adriano la sequenza di lettura è:lato II, lato III, lato I, lato IV.
8) ENSOLI VITTOZZI, 1992, pp. 47- 50;per Bosticco invece le figurazioni non hanno unsignificato particolare ma riproducono semplice-mente scene di ‘genere’ egittizzante come altre dietà romana nelle quali i simboli e gli atteggia-menti dei modelli egizi sono spesso deformati(Bosticco 1952, p. 26).
9) Erik Hornung sottlinea come Serapidedi tanto in tanto sia mostrato anche con una te-sta di Zeus con corona egizia il che indica cheegli riunisce in sé entrambi gli dei, Zeus ed Osi-ride (E. HORNUNG, Des esoterische Ägypten.Das geheime Wissen des Ägypter und sein Ein-fluß auf das Abendmal, München 1999 [tr.it.Torino 2006, p. 100]).
10) Ancora Hornung: [Iside] come IsideSothis porta l’inondazione del Nilo a cavallo diun cane e quindi la fertilità per l’Egitto e per tut-to il mondo romano (HORNUNG 1999, loc.cit.). Sull’importanza di Iside-Sothis in etàadrianea, si veda S. ENSOLI, L’Iseo e Serapeodel Campo Marzio con Domiziano, Adriano e iSeveri, in N. BONACASA, M.C. NARO,E.C. PORTALE, A. TULLIO (curr.), L’Egit-to in Italia dall’Antichità al Medioevo. Atti delIII Congresso Internazionale Italo-Egiziano, Ro-ma 1988, pp. 407- 438. Se Adriano appare le-gato alla figura di Serapide (con cui è identi-ficato in un’iscrizione datata al 126 dal Sera-
peion di Luxor: Α∆ΡΙΑΝΟΣ ΖΕΥΣ ΕΛΙΟΣΜΕΓΑΣ ΣΑΡΑΠΙΣ : JEA XL (1954), p. 126,1) Iside può venire collegata con Sabina, co-me in una moneta coniata nel 134-138 dallazecca di Roma per l’arrivo ad Alessandria del-la coppia imperiale: sul verso (iscr. ADVAVG ALEXANDRIAE) la coppia Serapide-Iside accoglie Adriano e Sabina. Serapidestringe la mano all’imperatore, mentre Isideagita il sistro e Sabina stringe un oggetto, pro-babilmente una situla, elemento costante delculto isiaco ed attributo di molte divinità fem-minili egizie. Le due coppie sono chiaramentespeculari e poste sullo stesso piano di impor-tanza (S. BAKHOUM, Les thèmes égyptisantsde l’atelier de Rome d’Auguste à Caracalla, inL’Egitto e l’Italia, cit., pp. 208-209 (fig. e num.5), 214. Da notare come sul recto Adriano siarappresentato senza barba. Si veda su Sabinae Iside: PIERLUIGI ROMEO, Signora delleDue Terre. Sabina e l’Egitto, in B. ADEMBRI,M. NICOLAI (curr.), Vibia Sabina da Augu-sta a Diva, Milano 2007.
11) P. Oxy. XVII 2131,5 (207 d.C. ca):..εκ τευκους συνκολλεσιµον Βιβλειδον επι−δοτεντον Σουβαστιανο Ακυλα το λαµπο(τα−το) εγεµονι προτετεντον εν Αντινοον πολ(ει)εν το Αντινοειω .
12) Sulla raffigurazione di Antinoo comehastiliarius, cfr. ROMEO 2005, pp. 11- 12.Sui culti praticati dagli Equites Singulares,M.P. SPIEDEL, Riding for Caesar. The RomanEmperors’ Horse Guards. London 1994, pp.139- 151.
13) Si veda il testo in appendice al presen-te articolo.
14) Non è forse inutile, visto quanto segue,inquadrare un istante la figura del Marucchi,poiché sul suo lavoro sugli obelischi romanidel 1896, e sulle sue trascrizioni, si basanomolti studi successivi, sino ad oggi. Marucchiera di formazione un archeologo cristiano, al-lievo di G.B. de Rossi; così lo descrive P. Per-gola: tanto prolisso e longevo quanto scientifica-mente poco attendibile... L’enorme quantità deisuoi scritti merita una qualche considerazionesolo quando riprende idee e teorie – edite ed ine-dite – del de Rossi (P. PERGOLA, Le Cata-combe romane. Storia e topografia, Roma 2002,pp. 42- 43). Ci si immagini quando pretese di
ANNALI 200797
le dee dei santuari d’Egitto sono andati lì e sono stati donatiloro campi e terreno fertile.
C’è un tempio di questo dio, l’�sy Osiride Antinoo, giu-sto di voce, costruito con pietra bianca decorato con sfingi sta-tue ed ornamenti senza numero nello stile antico e nello stiledei greci. Tutti gli dei gli concedono il soffio di vita, e la salu-te, per l’eternità.
Lato IV.L’�sy Antinoo, giusto di voce; si celebra una festa in que-
sto giorno42 nel suo tempio, che porta il suo nome; i forti che
sono in questo luogo, i giovani rematori, i più forti di tutto ilnomo, tutta la gente che conosce la devozione a Thot43, por-tano in dono corone e offerte di ogni cosa dolce e pura sui suoialtari, e gli bruciano incenso, i seguaci di Thot lo lodano (An-tinoo) per la sua potenza perche tutti quelli che si recano alsuo tempio da ogni parte di tutta la terra, sono ascoltati nel-le loro preghiere, ha guarito i malati apparendo nel sogno(snb-f mrw m whm ii-n-f m rswt) e le cose (da lui compiute)hanno avuto successo tra gli uomini con il suo volere, perchéè di origine divina ed è un dio dalla nascita (Hr nti mt nTr pwwdn-f Hr msxnt).

occuparsi di un campo estraneo ai suoi studicome l’egittologia.
15) E.A. WALLIS BUDGE, An EgyptianHieroglyphic Dictionary, London 1920, I, p. 30col a; A.H. GARDINER, Egyptian Grammar,Oxford 1956, § 468, 6.
16) Va precisato che tranne l’erronea in-terpretazione di iy il rimanente testo è sostan-zialmente corretto.
17. Lett. Il quale (nty) è nell’interno, che sitrova in dSr[t]. Nel testo è usata una forma ab-breviata per m- Xnw, nty iy rafforza il signifi-cato della frase precedente.
18) “Tomba” in egiziano è is, maha, mraha,mr (piramide, tomba monumentale): GAR-DINER 1956, p. 627 col. a.
19) Stranamente, chi ha avanzato taluneipotesi sulla sepoltura di Antinoo basandosisull’obelisco, non sembra prestare attenzioneai determinativi usati dal lapicida, essenzialiper una corretta interpretazione: si pensi cheil nome di Antinoo non è seguito dal deter-minativo di divinità (A 40) ma da quello in-dicante una revered person (A 52), a confermadel fatto che Antinoo non fosse consideratoun vero dio (nTr) ma un defunto eroicizzato(Hsy) come del resto afferma il testo dell’obe-lisco: cfr. ROMEO 2005 p. 14 n. 30, e id.,L’Egitto al tempo dei Romani, in B. ADEMBRI(cur.), Suggestioni egizie a Villa Adriana, Mila-no 2006, pp. 28 segg. La presunta menzionedella villa Adriana non è seguita dal determi-nativo di casa o palazzo (O 1, O 11) come sa-rebbe stato logico se l’interpretazione data fos-se stata corretta, ma da quello di città (O 4)(i numeri e le lettere fanno riferimento alla Si-gn List in appendice alla grammatica di A.H.GARDINER, Egyptian Grammar, Oxford1956).
20) Cap. CXLII, sez. III, 6.
21) BUDGE 1920, II, p. 1062 col. b tra-duce dSrt come the eastern desert and Arabia.Si ricordi come Erodoto sostenesse che il Niloseparava l’Asia dalla Libia: la riva orientale delfiume apparteneva all’Arabia, mentre quellaoccidentale era parte della Libia (Her. His. II,15-17).
22) L’Antinoeion è da riconoscere proba-bilmente nell’edificio monumentale in ordinecorinzio che gli studiosi francesi al seguito del-la spedizione del gen. Desaix del 1798-9 de-nominarono erroneamente bains per la pre-senza di un grande bacino lustrale e di quelloche era probabilmente il lago sacro del tem-pio, di cui fa menzione l’obelisco del Pincio: Isuoi altari, il suo lago sacro, le preghiere per luigli danno il soffio di vita (lato III). Dell’edificioattualmente non rimane più nulla, poiché ilsito di Sheik Iba’da- Antinoe fu utilizzato co-me cava durante il XIX secolo; come docu-mentazione restano alcune tavole della De-scription de l’Egypte, publié par les ordres de SaMajesté l’Empereur Napoleon le Grand, Paris,dal 1809, vol. IV, pll 53-54. Le sole tavoledella Description sono state ripubblicate involume unico nel 1994: Description de l’Egyp-te, Köln 1994.
23) Il segno (un uccello privo di testa) si
presenta tagliato nella parte superiore a causadella frattura seguita all’abbattimento dell’o-belisco; venne copiato ed integrato come A(G1,! avvoltoio capovaccaio) da Marucchi eda allora sempre accettato; è invece da legge-re come G37 (E, passer domesticus aegyptia-cus) come si evince dall’esame diretto: le zam-pe non presentano le “calze” di penne del Neo-fron pernocterus, ma sono quelle di un passe-raceo. Anche la coda è completamente diver-sa. Pertanto è da considerarsi errata la letturahA, nei pressi. Va anche emendata la lettura h3rwma che del resto poneva la questione delprefisso hA davanti al nome di Roma, assentedalle altre menzioni della città nei testi egizi,e senza alcun significato in egiziano. Dall’esa-me diretto del testo, h è l’ultima lettera di unaparola seguita dal determinativo, il cui inizioè andato perso a causa dalla frattura del mo-nolite, e che non è possibile identificare consicurezza. Va notato come nella trascrizionedel Marucchi non venga segnalata la fratturae le lacune dei segni siano state integrate nonsempre esattamente, ciò che ancora una voltaha condizionato le successive interpretazionidel testo geroglifico.
24) La presenza del determinativo N 30conferma che il testo parli, a proposito di An-tinoo, di un edificio sacro e non di semplicetomba.
25) Per un repertorio di fonti e testi relati-vi al culto di Adriano ed all’Αδριανειον si ve-da G. RONCHI, Lexicon Theonymon rerum-que sacrarum et divinarum ab Aegytum perti-nentium quae in papiris ostracis titulis graecislatinisque in Aegypto repertis laudantur, I, Mi-lano 1974, pp. 61 segg., sub voces.
26) A Nefrusy sorgeva un grande tempioprobabilmente eretto da Ramesse II (1290-1224 a.C.) dedicato ad Amon Ra, Thot Si-gnore di Khemenw (Hermopolis), Onhuris eRa Horakhty. Si tratta delle quattro divinitàraffigurate sul pyramidion dell’obelisco di An-tinoo. Il tempio è forse opera di Ramesse II,ma potrebbe anche essere precedente ed es-ser stato ampliato da tale faraone, che vi ap-pose i propri cartigli. Gli scavi condotti in ma-niera discutibile da Albert J. Gayet non han-no fornito dati certi in merito, anche perchéRamesse II era solito attribuirsi la fondazionedi un edificio anche se lo aveva solo ampliatoo restaurato; del resto Gayet non era un egit-tologo ed i suoi interessi erano indirizzati ver-so i ritratti funerari (F. CIMMINO, RamesseII il Grande, Milano 1984, p.199, sugli scavifrancesi ad Antinoe, cfr. M.H.R. [M.H. Rut-schowskaya], Antinoe, Un siécle des fouillesfrançaises en Egypte 1880-1980, Paris - Le Cai-re 1980, pp. 302-303). Il tempio ramesside ri-vestì ad Antinoe un importanza tale che lapianta ippodamea venne modificata per per-mettere un accesso monumentale al tempio:P. PENSABENE, Le vie colonnate nell’impian-to delle città egiziane di età imperiale, in L’E-gitto in Italia, cit., 1995, p. 352; ROMEO2006, p. 26.
27) Sulle divinità adorate nel tempio di Ra-messe II a Sheik el Iba’da - Antinoe, cfr. J.BAINES, J. MALEK, Atlas of Ancient Egypt,Oxford 1980 (tr. it. a cura di A. ROCCATI,Novara 1985, p. 128).
28) HABACHI 1977 (trad. it. Roma 1978,p. 115).
29) Sul culto di Sors-Fortuna in Egitto inetà imperiale, v. P. ROMEO, Documenti rela-tivi ai culti castrensi in Egitto (I-III secolo) AAN-SA 4 (2003), pp. 64- 65.
30) HORNUNG 1999, p. 108. Si con-fronti con il demo di Αδριανιος Ζηνειος adAntinoe, documentato in un contratto d’affit-to risalente al 232 d.C. (P. Flor. III 383, 37):cfr. RONCHI 1974 s.v.
31) HORNUNG 1999, p. 108. Lo studio-so svizzero identifica erroneamente Onhuriscon Antinoo, sulla base dello studio di G.GRIMM Antinous renatus et felix? In J. MI-NAS, J. ZEIDLER (curr.) Aspekte spätägypti-sche Kultur, Festschrift Erich Winter, Mainz1994, pp. 103-112. Di Adriano e la festa sd,e in particolare del ruolo rivestito nelle ceri-monie da Sabina, mi sono occupato nel miostudio su Sabina e l’Egitto, pubblicato nel ca-talogo della mostra tiburtina dedicata all’im-peratrice nell’estate 2007 (Adembri 2007).
32) HORNUNG, loc. cit.; anche l’egittolo-go svizzero annota perplesso che le statue rap-presenterebbero Antinoo – che non era impe-ratore – come un faraone (ibid) senza riuscirea spiegarsi questa incongruenza.
33) P. ROMEO, Considerazioni sui repertiegizi ed egittizzanti recentemente rinvenuti a Vil-la Adriana, AANSA 5 (2004), pp. 126-127 en. 16. Va ricordato come già Mario Attilio Le-vi ammoniva che non bisogna vedere un Anti-noo in ogni figura maschile giovane e piuttostotriste (M.A. LEVI, Adriano, Milano 1994, p.126).
34) A.K. BOWMAN, Egypt after the Pha-raos, London 1986 (tr. it. Milano 1988, p.39).
35) ROMEO 2004, p. 124.
36) ENSOLI 1998, passim.
37) Si ricordi come la disposizione dei te-sti sulle facciate degli obelischi segua schemiben precisi: ENGELBACH 1929, pp. 25-30.
38) Si tratta di un concetto tipicamente er-mopolitano, come del resto a tale ambiente facostante riferimento tutto il testo dell’obeli-sco: Toth dà ad Antinoo un ordine, od un de-creto divino, di partenza per l’Aldilà, con ilquale il defunto veniva raccomandato agli deidell’oltretomba perché venisse accolto favo-revolmente: J. QUAEGEBEUR, Lettres deThot et décrets divins, in Essays Herma vanVoss, Kampen 1988, pp. 105-126.
39) Seguo qui l’interpretazione di EDDABRESCIANI, Letteratura e poesia dell’AnticoEgitto, 2a ed, Torino 1997, p. 661, n. 82.
40) Toth.
41) Gli dei che custodiscono l’accesso al-l’Aldilà, ed il cui nome il defunto deve cono-scere per poter entrare nella Duat.
42) Evidentemente l’anniversario della suamorte.
43) Lett. Coloro che conoscono la superioritàdi Toth: nty rH hry- rd �hwty.
ANNALI 2007 98