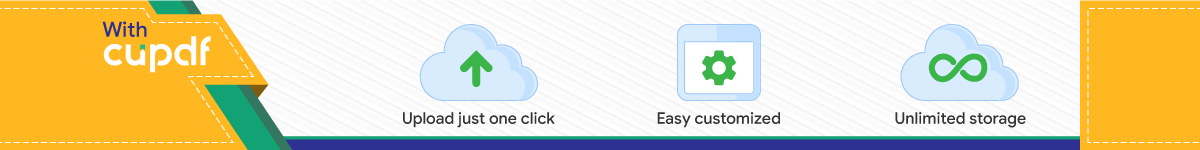
1
ESAME DI STATO 2017
Documento del consiglio della classe Ai sensi L. 425/97 - DPR 323/98, art. 5.2
Consiglio della classe V C Redatto dal Consiglio di classe nella seduta del 05/05/17, sentito il parere di genitori ed alunni. n. prot. 2115/05-02 del 15/5/17.
2
Sommario 1. Presentazione della classe .............................................................................................................. 3 Elenco dei candidati con la classe di provenienza ........................................................................... 3 2. Composizione e continuità dei consigli di classe ......................................................................... 4 3. Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo: .......................................... 5 a) trasversali ....................................................................................................................................... 5
CONTENUTI ................................................................................................................................... 5 METODI, MEZZI, STRUMENTI, SPAZI ...................................................................................... 5 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (cfr. PTOF 2016-2019) ................................................ 7
4. Obiettivi raggiunti: ........................................................................................................................ 8 b) disciplinari ...................................................................................................................................... 8 4. Criteri e strumenti di valutazione adottati ................................................................................ 22 a) trasversali ..................................................................................................................................... 22
Premessa ........................................................................................................................................ 22 CRITERI GENERALI DI VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE SOMMATIVA ....... 23 VALUTAZIONE FINALE DELLE ASSENZE ............................................................................ 25 deroga alle ore di frequenza ........................................................................................................... 26
b) Criteri e strumenti di misurazione e valutazione disciplinari ................................................. 30 TIPOLOGIA DI PROVE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO ...................................... 30 ▪ Prima prova scritta (Italiano): ................................................................................................. 31 ▪ Seconda prova scritta: ............................................................................................................. 35 ▪ Terza prova scritta: ................................................................................................................. 36
5. Obiettivi raggiunti ...................................................................................................................... 39 a) Obiettivi raggiunti trasversali .................................................................................................... 39
b) Obiettivi raggiunti disciplinari ................................................................................................. 40 a) Obiettivi disciplinari di italiano perseguiti nel corso dell’anno scolastico 2016-17: ................ 40 b) Obiettivi specifici raggiunti in Latino .................................................................................... 41 c) Obiettivi specifici raggiunti in Greco ...................................................................................... 42 d) Obiettivi raggiunti nella disciplina dell’Inglese ....................................................................... 43 e) Obiettivi disciplinari di filosofia perseguiti nel corso dell’anno scolastico 2016-17: ............... 43 f) Obiettivi disciplinari di storia perseguiti nel corso dell’anno scolastico 2016-17: .................... 44 g) Obiettivi disciplinari di FISICA ................................................................................................ 45 h) Obiettivi disciplinari di MATEMATICA .................................................................................. 45 i) Obiettivi raggiunti nella disciplina delle Scienze ................................................................. 46 l) Obiettivi specifici raggiunti nella disciplina della Storia dell’arte ....................................... 47 m) Obiettivi specifici raggiunti nella disciplina dell’Educazione Fisica ................................. 48 n) Obiettivi specifici raggiunti nella disciplina della Religione .............................................. 48
6. Altri elementi utili e significativi ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio ..................................................................................... 49
Attività integrative svolte dalla classe: .......................................................................................... 49 7. Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLiL ........................................................................... 49 8. Allegati .......................................................................................................................................... 51
P. T. O. F 2016/2019 ...................................................................................................................... 51 Testi Terza Prova ............................................................................................................................. 52
3
1. Presentazione della classe
La classe VC è composta da diciannove alunni, tre maschi e sedici femmine. La classe presenta una fisionomia eterogenea sia dal punto di vista comportamentale e relazionale che dal punto di vista cognitivo. Gli alunni hanno avuto nel corso del quinquennio, nel complesso, comportamenti responsabili e hanno stabilito buone relazioni fra di loro e con i docenti. Il percorso educativo, programmato e messo in opera dai docenti, si è fondato sul rispetto della loro personalità; sono sempre state tenute presenti le loro peculiarità, con stimoli adeguati alla loro formazione globale. Tutta l’attività didattica è stata sempre improntata al raggiungimento degli obiettivi generali dell’indirizzo classico. Il ritmo di lavoro in questi tre anni è stato abbastanza sostenuto e i risultati hanno complessivamente soddisfatto le attese dei docenti e delle famiglie. Alle relazioni dei singoli docenti si rimanda per un’analisi più dettagliata della situazione della classe nelle singole disicpline. Il percorso di avvicinamento all’esame si è arricchito nel mese di maggio anche di ore di potenziamento di matematica e di latino. Regolare nel complesso lo svolgimento dei programmi, sebbene l’anno scolastico abbia visto gli allievi impegnati in numerose attività sia di orientamento che di formazione, che ne hanno comunque condizionato sia il ritmo di svolgimento che i tempi di apprendimento. Eventuali variazioni rispetto alla programmazione iniziale saranno meglio evidenziate nei programmi svolti consegnati dai docenti delle singole discipline. Complessivamente regolare, l’insieme delle verifiche svolte.
Elenco dei candidati
1. AMODEO EGLE
2. BRUNO CHIARA
3. CASANOVA ANGELA
4. CASTRONUOVO ROBERTA
5. CAVALIERE GIUSEPPE
6. DE MAIO ROSEMARY
7. FORGIONE MARIANNA
8. GEROSOLIMA CLAUDIA
9. GRANDIOSO ANNA
4
10. LABRUNA FRANCESCO
11. MELE ELENA
12. MEOLA IOLE
13. MERIANO ROSSELLA
14. MONTEFUSCO SARA
15. MUSTO NATALIA
16. PETRACCA ILENIA
17. RINALDI GIAMPIO
18. STORNAIUOLO MARGHERITA
19. TESTA SILVIA
2. Composizione e continuità dei consigli di classe
DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE ANNI CORSO
ITALIANO Matarazzo Antonella III-V
LATINO Limata Berardino III-V
GRECO Limata Berardino III-V
STORIA Alba Luigia III-V
FILOSOFIA Alba Luigia III-V
MATEMATICA Lauria Ettore I-V
FISICA Lauria Ettore III-V
INGLESE Della Sala Marisa V
SCIENZE Guerriero Assunta I-V
STORIA DELL'ARTE Santaniello Patrizia III-V
EDUCAZIONE FISICA Cieri Maria Carla III-V
RELIGIONE Imbimbo Margherita I-V
5
3. Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo: a) trasversali
CONTENUTI
“Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.” Tutto ciò premesso, gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale classico, oltre a conseguire i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
- Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
- Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
- Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
METODI, MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
Metodologie comuni Nel percorso didattico -educativo programmato, le metodologie più frequentemente impiegate sono state:
Lezione frontale Lezione/Applicazione
Lezione dialogata Scoperta guidata
Dibattito in classe Problem Solving
Esercitazioni individuali in classe Brainstorming
6
Esercitazione in coppia in classe Circle Time
Esercitazioni per piccoli gruppi in classe Cooperative Learning
Elaborazione di schemi/mappe concettuali Correzione collettive di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa
Relazioni su ricerche individuali /collettive Analisi di casi
Esercitazioni grafiche e pratiche CLIL
Mezzi, strumenti e spazi comuni Ogni docente, nell’ambito della propria discrezionalità, ha utilizzato le metodologie, i mezzi e gli strumenti più adeguati al linguaggio e ai contenuti specifici della disciplina. Di seguito si fornisce un quadro di riepilogo:
MATERIALI SPAZI STRUMENTI
Libro di testo Laboratorio di informatica Registrazione audio
Altri testi Laboratorio multimediale Aula classe Lavagna luminosa
Dispense Laboratorio linguistico Videoproiettore
Fotografie Laboratorio di fisica Videocamera
Fotocopie Laboratorio di scienze Televisore e lettore DVD
Internet Aula classe e laboratori ALTRO
Software didattici Visite guidate
Uscite didattiche
Incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti
7
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (cfr. PTOF 2016-2019)
Il Liceo “Colletta” ha adottato l’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti così come previsto all’ art. 5 del Regolamento di Riordino dei Licei, che prevede 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 1023 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. Previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Il liceo Colletta, in ottemperanza alla L. 107 che fa dell’orientamento e della personalizzazione del curricolo il centro del sistema d’istruzione, ha ampliato la sua offerta formativa ed integra il curricolo tradizionale con attività ed insegnamenti aggiuntivi coerenti con l’indirizzo di studio del liceo e il profilo educativo e culturale dello studente. Per le classi quinte sono stati svolti:
➢ Percorso formativo di potenziamento in "Discipline giuridico- economiche” ➢ Percorso formativo in "Disegno e Storia dell'arte": “ Da Abellinum ad Avellino” ➢ Corsi extracurriculari di lingua inglese, di preparazione alle certificazioni
informatiche. Nel mese di maggio saranno dedicate alcune ore aggiuntive di lezione ad attività di potenziamento curricolare di latino ed extra-curricolare di matematica.
8
4. Obiettivi raggiunti: b) disciplinari
DOCENTE Prof. ANTONELLA MATARAZZO
DISCIPLINA ITALIANO
SITUAZIONE DI PARTENZA (dal piano di lavoro di inizio anno)
complessivamente buona con punte di eccellenza
PROGRAMMA SVOLTO
· Classicismo e Romanticismo, visioni del mondo nell'età napoleonica in Europa; Il romanzo storico. Alessandro Manzoni; Giacomo Leopardi, il primo dei moderni; Dal realismo al naturalismo; I veristi siciliani :Giovanni Verga; il Neorealismo; La nascita della poesia moderna: Carducci, D’Annunzio, Pascoli; Il romanzo, la crisi delle forme tradizionali: Pirandello e Svevo;
.I I movimenti letterari, le poetiche, le riviste; I crepuscolari e il Futurismo; Ungaretti e la religione della parola ;Umberto Saba e la poesia onesta; Eugenio Montale, il mondo la società e la storia nelle raccolte poetiche di Montale; il romanzo: Cesare Pavese, Primo Levi, Italo Calvino interprete della società italiana dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta; Pier Paolo Pasolini, la vita dell'intellettuale "corsaro".
TESTI DI RIFERIMENTO
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, Palumbo editore ( volumi 4/5/6 e volume monografico Leopardi, il primo dei moderni.)
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, lezione dialogica, lettura ed interpretazione dei testi, commento al testo o all' argomento della lezione, costruzione di una sintesi conclusiva dell’argomento trattato.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, mappe concettuali, appunti forniti dal docente, fonti web, utilizzo della LIM
9
SPAZI Aula
PROBLEMI E EVENTUALI DIFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DOCENTE Prof. BERARDINO LIMATA
DISCIPLINA LATINO
SITUAZIONE DI PARTENZA
COMPLESSIVAMENTE BUONA. QUALCHE DIFFICOLTA’ PIU’ MARCATA NELLA TRADUZIONE.
PROGRAMMA SVOLTO
MACROAREE: A) INTELLETTUALI E POTERE: - L’EPOCA GIULIO-CLAUDIA: GLI INTELLETTUALI E
NERONE: SENECA, LUCANO, PETRONIO - I FLAVI: QUINTILIANO. PLINIO IL VECCHIO - IL II SECOLO: IL CONSENSO. PLINIO IL GIOVANE E
TRAIANO. SVETONIO -
B) SATIRA E NARRATIVA - PERSIO. MARZIALE. GIOVENALE. APULEIO - AGOSTINO E LA FINE DELLA CULTURA PAGANA
D) GLI AUTORI: TESTI DI SENECA, TACITO, PETRONIO, QUINTILIANO.
TESTI DI RIFERIMENTO
Res et fabula. Per le Scuole superiori vol.3 Dall'età di Tiberio alla letteratura cristiana di Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo. Lezioni laboratoriali
10
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo. Presentazioni multimediali
SPAZI Aula
EVENTUALI PROBLEMI E DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
CONCOMITANZA CON LE NUMEROSE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVESITARIO E PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE.
DOCENTE Prof. BERARDINO LIMATA
DISCIPLINA GRECO
SITUAZIONE DI PARTENZA
COMPLESSIVAMENTE BUONA. QUALCHE DIFFICOLTA’ PIU’ MARCATA NELLA TRADUZIONE
PROGRAMMA SVOLTO
MACROAREE L’età ellenistica: “l’evo moderno del mondo antico”: ❖ L’arte per l’arte: Callimaco. Teocrito. L’epigramma ❖ Sperimentalismo e innovazione: la nuova epica di
Apollonio ❖ Realtà e finzione: Menandro e la commedia nuova. Le
origini del romanzo ❖ Impero e imperialismo: Polibio
L’età imperiale: ● Un impero bilingue: Plutarco. L’Anonimo del Sublime. ● La nuova narrativa: Luciano
Il testo filosofico: ❖ Platone
TESTI DI RIFERIMENTO
GIULIO. GUIDORIZZI, Letteratura greca. Ediz. riforma. Per il Liceo classico. Con espansione online vol.3
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo. Lezioni laboratoriali
MEZZI E STRUMENTI DI
Libro di testo. Presentazioni multimediali
11
LAVORO
SPAZI Aula
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
CONCOMITANZA DELLE NUMEROSE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E DEI TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTA’
DOCENTE Prof. Ettore Lauria
DISCIPLINA MATEMATICA
SITUAZIONE DI PARTENZA
Complessivamente discreta
PROGRAMMA SVOLTO
MACROAREE Funzioni reali di una variabile reale: Concetti topologici fondamentali; Il concetto di limite e relative applicazioni di calcolo (in riferimento ad alcune delle forme più ricorrenti dei limiti notevoli) Principali concetti dell’analisi infinitesimale: continuità, e derivabilità e relative applicazioni di calcolo nei casi di base Il grafico di funzioni reali in una variabile reale: elementi essenziali e caratteristici e relativa individuazione, con particolare riferimento alle funzioni razionali fratte (casi di base) Essenziali richiami dell’Analisi Matematica alla Fisica
TESTI DI RIFERIMENTO
Trifone ed altri - Matematica.Blu 2.0 - 5 Vol - LDM - Zanichelli Geometria Operativa (per i Licei) - Cirillo - Vol 2 - Flli. Ferraro
12
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, lezione verbale e scritta, lezione dialogica, lettura ed interpretazione dei testi, commento al testo o all' argomento della lezione, costruzione di una sintesi conclusiva dell’argomento trattato.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, mappe concettuali, appunti forniti dal docente, fonti web, utilizzo della LIM
SPAZI Aula
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
CONCOMITANZA CON LE NUMEROSE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVESITARIO E PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE.
DOCENTE Prof. ETTORE LAURIA
DISCIPLINA FISICA
SITUAZIONE DI PARTENZA
Complessivamente discreta
PROGRAMMA SVOLTO
MACROAREE Fenomeni elettrici e magnetici:
Fenomeni elettrici (statici e dinamici) più rappresentativi e relative leggi ed applicazioni numeriche di base Fenomeni magnetici più significativi e relative caratteristiche, leggi ed applicazioni numeriche di base Interazione tra corrente elettrica e campo magnetico: leggi più rappresentative ed applicazioni numeriche di base
TESTI DI RIFERIMENTO
Traiettorie della FISICA 3 (LMM) Da GALILEO a HEISENBERG. Elettromagnetismo(con PHYSICS In English)- U. Amaldi - Zanichelli Fisica 3 - Quaderno operativo - Gatti - Pirovano - Editore La
13
Spiga
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, lezione verbale e scritta, lezione dialogica, lettura ed interpretazione dei testi, commento al testo o all' argomento della lezione, costruzione di una sintesi conclusiva dell’argomento trattato.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, mappe concettuali, appunti forniti dal docente, fonti web, utilizzo della LIM, strumentazione di laboratorio
SPAZI Aula, laboratorio di Fisica
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
CONCOMITANZA CON LE NUMEROSE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVESITARIO E PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE.
DOCENTE Prof. LUIGIA ALBA
DISCIPLINA FILOSOFIA
SITUAZIONE DI PARTENZA
COMPLESSIVAMENTE BUONA
PROGRAMMA SVOLTO
MACROAREE Il criticismo kantiano. L’idealismo romantico. Contestazioni e sviluppi dell’Idealismo La crisi delle certezze ottocentesche. Aspetti della filosofia del Novecento Cenni sull’esistenzialismo
TESTI DI Abbagnano- Fornero “La ricerca del pensiero” Paravia
14
RIFERIMENTO
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, lavori di gruppo, flipped classroom, cooperative learning, brainstorming
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, mappe concettuali, appunti forniti dal docente, fonti web, LIM, piattaforma Edmodo.
SPAZI Aula
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DOCENTE Prof. LUIGIA ALBA
DISCIPLINA STORIA
SITUAZIONE DI PARTENZA
COMPLESSIVAMENTE BUONA
PROGRAMMA SVOLTO
MACROAREE Il Risorgimento e l’unità d’Italia La politica europea tra il 1850 e il 1900 L’età giolittiana. La grande guerra e le sue conseguenze L’età dei totalitarismi La seconda guerra mondiale La Resistenza in Italia
Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento.·
TESTI DI RIFERIMENTO
De Luna-Meriggi “Il segno della storia” - Paravia Storiografia: Banti- Le questioni dell’età contemporanea- Laterza
15
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, lavori di gruppo, flipped classroom, cooperative learning, brainstorming
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, mappe concettuali, documenti storiografici, appunti forniti dal docente, fonti web, LIM, piattaforma Edmodo.
SPAZI Aula
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DOCENTE GUERRIERO ASSUNTA
DISCIPLINA SCIENZE
SITUAZIONE DI PARTENZA (dal piano di lavoro di inizio anno)
Complessivamente discreta Livello di preparazione: buono/ discreto/ sufficiente /insufficiente
PROGRAMMA SVOLTO CONTENUTI DEI MODULI E TEMPI DI SVOLGIMENTO
1.La chimica organica II Ibridazione del carbonio Isomeria di struttura, geometrica e stereoisomeria. principali reazioni degli idrocarburi
2.Gli idrocarburi: Idrocarburi alifatici Radicali alchilici Idrocarburi aromatici
3. Dai gruppi funzionali alle macromolecole: I gruppi funzionali , nomenclatura IUPAC Classi di composti organici e loro reazioni
4.Biochimica glucidi e lipidi :
I carboidrati: organizzazione e vie metaboliche
16
I lipidi semplici e complessi e il loro ruolo energetico e strutturale
5.Biochimica proteine e acidi nucleici: Struttura e organizzazione delle proteine Metabolismo proteico. Struttura e organizzazione degli acidi nucleici Vitamine e minerali
6.Scienze della terra le dinamiche terrestri: Interno della Terra, dinamiche endogene, risorse rinnovabili e non
·
TESTI DI RIFERIMENTO
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontale, dialogata, partecipata. Lavoro individuale Conversazione e discussione . Esercitazione in classe alla lavagna. Correzione collettiva e interattiva dei compiti. Cooperative learning
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo, laboratorio multimediale, manuali, riviste scientifiche, filmati, video proiezioni da PC, risorse on line/e-book, laboratorio scientifico, LIM.
SPAZI Aula, laboratorio scientifico
PROBLEMI E EVENTUALI DIFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
L’attività didattica ha subito dei rallentamenti a causa di alcune impreviste interruzioni delle lezioni.
DOCENTE Prof. MARISA DELLA SALA
DISCIPLINA INGLESE
SITUAZIONE DI PARTENZA
Complessivamente buona, con alcune eccellenze ma anche con elementi dalla preparazione discreta e piu’ che sufficiente
17
PROGRAMMA SVOLTO
The Romantic Age-Beauty and Sublime-Wordsworth and nature-Coleridge and the Sublime The Gothic Novel-M.Shelley and a new interest in science-Frankenstein-The theme of double The beginning of an American Identity-W.Whitman/Carducci The Victoria Age-The Victorian Compromise-Ch.Dickens/Verga O.Wilde and the theme of Beauty The Great War and the War Poets-R.Brooke and W.Owen- E.Hemingway The Age of Anxiety-Th.S.Eliot and the alienation of modern manl-Freud and the unconscious--The psychological novel-J.Joyce and Svevo-D.H.Lawrence and human relationship-V.Woolf and the “moments of being”-Film vision “The Hours”,Cunningham- The Dystopian novel-G.Orwell
TESTI DI RIFERIMENTO
Spiazzi M .-Performer Culture and Literature voll.2 -3 . Ed Zanichelli
METODI DI INSEGNAMENTO
Uso consapevole e condiviso delle tematiche sviluppate dal libro di testo, mappe concettuali, elaborazione appunti forniti dal docente, ricerca fonti web, utilizzo della LIM Lezione frontale, dialogata, partecipata. Lavoro individuale, conversazione e discussione. Esercitazione in classe alla lavagna. Correzione collettiva e interattiva dei compiti. Cooperative learning. Collegamenti interdisciplinari
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo,mappe concettuali,, filmati, video proiezioni da PC, risorse on line/e-book, LIM.
SPAZI Aula
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
18
DOCENTE Prof. CARLA CIERI
DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA
SITUAZIONE DI PARTENZA
Gli studenti dimostrano capacità di organizzare il loro impegno con una buona autonomia e sistematicità.
PROGRAMMA SVOLTO
• L’apprendimento e il controllo motorio • Le capacità motorie • Le abilità motorie • L’allenamento sportivo • La pallavolo • La pallacanestro • Il tennis tavolo • La ginnastica • La postura • L’alimentazione • Il doping
Traumatologia sportiva, prevenzione ed assistenza, il primo soccorso
TESTI DI RIFERIMENTO
A 360°. Allenarsi. Per le Scuole supe riori. Con DVD. Con espansione online, di Giovanna Giorgetti, Paola Focacci, Uumberto Orazi.
METODI DI INSEGNAMENTO
Conoscenze: • Conoscenza dei contenuti facenti parte del programma
svolto • Conoscenza delle elementari norme di comportamento
all’interno del gruppo scolasti Competenze:
• Possesso delle competenze di base inerenti i vari settori dell’indirizzo
Capacità: • Capacità di esporre in modo chiaro i contenuti facenti parte
del programma scolastico • Capacità di elaborare osservazioni durante le lezioni
Rispetto del regolamento scolastico e delle consegne stabilite inerenti la disciplina
19
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo,mappe concettuali,, filmati, video proiezioni da PC, risorse on line/e-book, LIM.
SPAZI Aula e palestra
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DOCENTE Prof. MARGHERITA IMBIMBO
DISCIPLINA RELIGIONE
SITUAZIONE DI PARTENZA
Complessivamente buona
PROGRAMMA SVOLTO
La vita e il suo significato: itinerario del senso religioso. Avvento e Natale: la categoria dell’attesa – la sorpresa di un Dio Bambino. La Giornata della Memoria: “l’armadio della vergogna” e le stragi nazi-fasciste impunite. La questione etica: l’atto morale, libertà, responsabilità, coscienza. Origini della bioetica e campo di applicazione: il fine vita e l’eutanasia. La Pasqua di resurrezione: la categoria della donatività e il comandamento dell’amore. Il dialogo interreligioso: fondamento epistemologico e scenari possibili.
TESTI DI RIFERIMENTO
“Uomini e profeti” A. Famà Marietti Scuola
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni di gruppo.
20
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo., mappe concettuali, documenti storiografici, letterari, iconografici, biblici, del magistero della chiesa, LIM, fonti web.
SPAZI Aula.
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
DOCENTE Prof. PATRIZIA SANTANIELLO
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE
SITUAZIONE DI PARTENZA
SITUAZIONE DI PARTENZA (dal piano di lavoro di inizio anno) La classe V C risulta composta da alunni per la maggior parte motivati e ben scolarizzati. Il percorso dello studio della storia dell’arte è iniziato già da due anni, anni di intenso lavoro in cui oltre allo svolgimento del programma curriculare, si è cercato di stimolare gli alunni verso una partecipazione attiva alla lezione, accogliendo e proponendo approfondimenti desunti anche dall’attualità e da spunti interdisciplinari. Un ulteriore elemento che ha reso gli alunni un vero gruppo classe coeso e attivo è stato fornito dalla partecipazione dell’intera classe negli anni precedenti ad una attività extracurriculare inerente ad approfondimenti sulla storia dell’arte: il progetto denominato Viaggi nel Classico. Gli studenti hanno inoltre condotto ricerche e prodotto documentazione grazie alla visita autoptica dei singoli siti. Pertanto la buona pratica acquisita in questi anni rende attualmente particolarmente agevole e anche stimolante affrontare percorsi più complessi del consueto
PROGRAMMA SVOLTO
Si è affrontato lo studio dei principali artisti del 500(Michelangelo, Raffaello,Leonardo,Bramante, Tiziano,Giorgione),del 600 (Caravaggio, Bernini, Borromini, Carracci), dell’800 (Pelizza da Volpedo) e del 900 (Burri, Jodice
21
), privilegiando l’arte italiana ma anche osservando da vicino artisti europei (Rembrandt, Velazquez, Rubens, Vermeer, Brueghel, Delacroix, Gericault,Turner, Gaudì, Bacon, Le Courbusier, Meier,…). Oltre ad un vasto numero di opere trattate in maniera dettagliata, si è indirizzato lo studio verso confronti tra artisti di diverse epoche e su tematiche trasversali. (Committenza; iconografia; città; musei; classico/classicismo/movimento moderno/ arte contemporanea; costruzione/ricostruzione /recupero; pubblicità/arte). Particolare rilievo hanno avuto le opere e le città di cui gli alunni hanno potuto fare una esperienza diretta, attraverso visite- lezioni. La città di Roma dalla Centrale Montemartini – significativo esempio di archeologia industriale e in cui sono esposte stupende opere dell’arte greco-romana, al centro storico con visita alle principali opere del 600 – Caravaggio, Bernini e Borromini, Rubens; la città di Napoli - Museo di Capodimonte, centro storico, Palazzo Zevallos, le Poste centrali, come esempio di architettura del 900..
·
TESTI DI RIFERIMENTO
TESTI DI RIFERIMENTO Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, Versione azzurra, Zanichelli Volumi 2 e 3
METODI DI INSEGNAMENTO
METODI DI INSEGNAMENTO lezioni frontali ed interattive, con l’ausilio del libro di testo, integrato con documenti forniti dal docente. Discussioni e lavori individuali e di gruppo . Lezioni da parte di esperti archeologi, storici dell’arte e dell’architettura con approfondimenti di tematiche specifiche. Visite didattiche/ lezioni in città e luoghi significativi per la comprensione della complessità del fenomeno artistico e del senso di bellezza oggi. Produzione di elaborati da parte di ciascun alunno relativi alle esperienze fatte e redazione di schede su opere d’arte studiate e viste a l Museo di Capodimonte e a Palazzo Zevallos a Napoli.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Libri di testo, materiali reperito in rete , testi presenti nella biblioteca di istituto, testi della docente .- Computer/videoproiettore e LIM con presentazioni in powerpoint.
SPAZI Aula e durante le uscite didattiche gli spazi dei musei , della città, delle chiese …per lezioni sul luogo
22
PROBLEMI E EVENTUALI DIFFICOLTÁ EMERSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
La riduzione delle ore di lezione curriculari, causata da varie eventi (neve, festività) hanno rallentato lo svolgimento del programma.
4. Criteri e strumenti di valutazione adottati a) trasversali
Premessa
La valutazione periodica e finale si è attenuta al dettato del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 ed è stata effettuata dal Consiglio di classe, costituito ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Ai sensi del DPR 122/2009:
Ø la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni; ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;
Ø la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo;
Ø le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa;
Ø la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Nella programmazione di classe, in base ai livelli di partenza degli allievi e agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere, sono indicati criteri, percorsi e strumenti di verifica e valutazione. I voti delle singole prove scritte e orali sono attribuiti con criteri trasparenti e il più possibile oggettivi, in rapporto alle griglie predisposte nei dipartimenti e adottate nei consigli di classe. Essi devono essere comunicati tempestivamente agli studenti per consentire loro di correggere errori, lacune e metodo di studio e fare sì che diventino uno strumento di responsabilizzazione e motivazione allo studio.
23
I voti di profitto assegnati negli scrutini non sono solo il risultato della “misurazione” aritmetica delle verifiche, ma anche della considerazione di altri elementi come l’impegno, la partecipazione al lavoro scolastico, l’interesse allo studio, la regolarità della frequenza. Essi sono attribuiti collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe nella seduta di scrutinio, su proposta motivata del docente di ogni disciplina. “Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, sia nella sua dimensione individuale che collegiale (articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009), in sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe. In quella stessa sede, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e dell’articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”
CRITERI GENERALI DI VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE SOMMATIVA
Le Verifiche e le Valutazioni del processo didattico-educativo sono attuate dai docenti secondo vari momenti, per come specificato di seguito:
Ø valutazione diagnostica attraverso prove d’ingresso per rilevare i livelli di partenza degli allievi;
Ø verifiche formative per guidare e correggere l’itinerario didattico Ø verifiche sommative per rilevare l’apprendimento e le competenze acquisite;
Esse prevedono prove scritte strutturate, non strutturate, semi-strutturate e prove orali. Le prove orali, scritte, grafiche e pratiche devono corrispondere:
Ø agli obiettivi dichiarati e ai contenuti dell’apprendimento, alle possibilità concrete della classe e allo svolgimento reale dell’insegnamento;
Ø devono essere il frutto di un’azione didattica programmata e non casuale; rispecchiare le tipologie previste dall’Esame di Stato.
Il giudizio di positività della prova si baserà prevalentemente sull’impostazione e comprensione generale; singole mancanze circoscritte e non significative non pregiudicano la sostanza positiva delle prove. La valutazione deve essere in grado di verificare l’apporto e il lavoro singolo anche nell'eventuale lavoro di gruppo. La valutazione va espressa sulla base di un congruo numero di prove (scritte, orali, pratiche/grafiche, compiti a casa debitamente corretti e altri elementi utili) in tutte le discipline, quantificate in almeno 2 verifiche scritte e 1 interrogazione nel trimestre, almeno 2 verifiche scritte e 2 interrogazioni nel pentamestre (delibera n. 6 C.d.D. 13-09-2016) Il voto di profitto è unico.
25
VALUTAZIONE FINALE DELLE ASSENZE
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. L' istituzione scolastica può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consigli di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. L’orario annuale personalizzato è da riferirsi al monte ore annuale. Il numero massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è calcolato in numero di ore di assenze, diverso per i vari settori. Nel REGOLAMENTO DELLE ASSENZE è indicato il numero massimo di ore di assenze consentito per ogni settore e le relative deroghe.
Superando il limite di assenze indicato nella colonna MASSIMO si è esclusi dallo scrutinio finale e non ammessi alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
BIENNIO TRIENNIO 1 2 3 4 5 ORE
SET
TIM
AN
NU
AL
I MIN
IMO
SET
TIM
AN
NU
AL
I MIN
IMO
SET
TIM
AN
NU
AL
I MIN
IMO
SET
TIM
AN
NU
AL
I MIN
IMO
SET
TIM
AN
NU
AL
I MIN
IMO
LICEO CLASSICO 27 891 668 27 891 668 31 1023 767 31 1023 767 31 1023 767
MONTE ORE ANNUALE E LIMITE MASSIMO DI ASSENZE
BIENNIO TRIENNIO 1 2 3 4 5 ORE
SET
TIM
AN
NU
AL
I
MA
SSIM
SET
TIM
AN
NU
AL
I
MA
SSIM
SET
TIM
AN
NU
AL
I
MA
SSIM
SET
TIM
AN
NU
AL
I
MA
SSIM
SET
TIM
AN
NU
AL
I
MA
SSIM
LICEO CLASSICO 27 891 222 27 891 222 31 1023 256 31 1023 256 31 1023 256
26
deroga alle ore di frequenza
Ai sensi del DPR n.122/2009 art.14 comma 7 r: “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Pertanto, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati il Collegio delibera nella seduta del 12/5/17 la possibilità di deroga al limite minimo di frequenza scolastica, comunque non superiore al 20% del monte ore personalizzato, nei seguenti casi: a) per gli alunni diversamente abili che a causa della loro disabilità/infermità certificata (L 104/92) non possono raggiungere il limite minimo di frequenza scolastica; b) per gli alunni temporaneamente infermi o impossibilitati alla frequenza per malattia o a causa di svantaggio sociale, economico, culturale. c) per gli alunni affetti da patologie croniche anche di natura invalidante. d) per gli alunni che partecipano ad attività sportive riconosciute dal CONI/ FIGC, limitatamente alle assenze per gare e non per gli allenamenti e purché forniscano un calendario dettagliato delle manifestazioni con autorizzazione della FIGC regionale che attesti le assenze. In ogni caso dovrà essere il Consiglio di classe a valutare l’opportunità o meno dell’applicazione della deroga in sede di scrutinio finale in presenza o meno di elementi di valutazione.
CREDITO SCOLASTICO
Nel secondo biennio e nell’anno conclusivo della scuola secondaria superiore i Consigli di classe attribuiscono in sede di scrutinio finale a ciascuno studente un punteggio che, sommato a conclusione del percorso di studi, forma il credito scolastico di ammissione all'Esame di Stato. Tale punteggio viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (tranne Religione), secondo la seguente tabella (DM 99/09) che sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007:
CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI VOTI Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA
M = 6 3 -4 3 -4 4 -5
6 < M ≤ 7 4 -5 4 -5 5 -6
27
7 < M ≤ 8 5 -6 5 -6 6 -7
8 < M ≤ 9 6 -7 6 -7 7 -8
9 < M ≤ 10 7 -8 7 -8 8 -9 Normativa di riferimento:
• D.M. 42 del 22 maggio 2007, che a decorrere dall'anno scolastico 2006/07, ha sostituito, iniziando dalle classi terze, la tabella di valutazione del DPR 23 LUGLIO 1998 e nota n° 5664 del 31 maggio 2007;
• Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, che sostituisce le tabelle A, B,C, allegate al DM 42 22 MAGGIO 2007 (per le classi terze)
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione: - nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; - il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
CREDITO FORMATIVO
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche i seguenti elementi:
Ø assiduità della presenza scolastica, Ø interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo Ø attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). Art. 4 comma 3 D.P.R. n. 122/2009: “Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.” Condizioni per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia Il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione viene attribuito all'alunno tenendo conto dei seguenti elementi: a) assiduità della frequenza: fino ad un massimo di punti 0.20
28
b) giudizio del docente di religione o dell'attività alternativa-formativa: fino ad un massimo di punti 0.20 c) attività complementari integrative e/o credito formativo: fino ad un massimo di punti 0.30 d) interesse e partecipazione: fino ad un massimo di punti 0.30 Il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione viene attribuito all'alunno qualora la somma dei diversi crediti sia maggiore o uguale allo 0.50. Il punteggio (1 punto) viene attribuito secondo la seguente tabella:
- Parametro: Assiduità della frequenza
Punti Note
Ø Punti0.20(50h)
Ø Punti0.10(51<h <_ 75)
Leassenze sottratte al monte orario in base ai criteri di deroga stabiliti dal collegio dei docenti devono essere eliminate dal computo complessivo.
- Parametro: Giudizio del docente di religione o attività sostitutiva IRC
Punti Note
Punti0.20 Si attribuisce il punteggio di 0.20 solo se lo studente ha conseguito il giudizio di ottimo nell'insegnamento della religione cattolica o nell'insegnamento alternativo.
Punti0.10 Si attribuisce il punteggio di 0.10 se lo studente ha conseguito nell'insegnamento della religione cattolica o nell'insegnamento alternativo un giudizio positivo (ma diverso da sufficiente)
Parametro: Attività complementarie/ointegrative -Creditoformativo
Sarà valutato un numero massimo di tre certificazioni e un punteggio complessivo massimo di 0.30
Tipologia attività:
Ambito dell’esperienza
Requisiti per l’attribuzione
Punti
Attività scolastiche
Corsi di lingua Livello superiore a quello previsto dal grado del curricolo
0.10
Concorsi interni
Attestato di partecipazione alla gara Conseguimento premio
0.10 0.20
Corsi di informatica
Conseguimento di certificazione finale che attesti le competenze acquisite
0.10
29
Attività laboratoriali (teatro, cinema, giornalismo, disegno)
Attestato di partecipazione
0.10
PON o POR Attestato di partecipazione
0.10
Alternanza scuola lavoro
Per un giudizio complessivo di livello avanzato Per un giudizio complessivo di livello intermedio Per un giudizio complessivo di livello base
0.30 0.20 0.10
Attività sportive
Attestato di partecipazione gruppo sportivo
0.10
Attività di orientamento e promozione dell’istituto
Attestato di partecipazione
0.20
Tipologia attività:
Ambito dell’esperienza
Requisiti per l’attribuzione
Punti
Attività extra- scolastiche
Corsi di lingua Attestati di corsi di almeno 30 ore, rilasciati da enti accreditati MIUR (per la lingua inglese livello minimo B1)
0.10
Concorsi, olimpiadi e certamina
Attestato di partecipazione alla gara Classificazione nei primi tre posti
0.10 0.20
Corsi di informatica
Conseguimento di certificazione finale che attesti le competenze acquisite ECDL
0.10 0.20
Attività artistiche (teatro, cinema, musica)
Attestato di partecipazione Attestato superamento esame Conservatorio
0.10 0.20
Attività di volontariato
Attestato di partecipazione rilasciato da enti iscritti all’albo regionale del volontariato che certifichino la durata dell’attività Attestato di partecipazione ad attività di tutela dell’ambiente o
0.10
30
socialmente utili rilasciati da enti riconosciuti
Attività sportive
Attestato di partecipazione ad attività di Enti, Società o Federazioni riconosciute dal Coni
0.10
Parametro: Interesse e partecipazione
Il punteggio sarà attribuito in considerazione della media voto come di seguito precisato:
Punti Note
Punti0.10 Si attribuisce il punteggio di 0.10 solo se lo studente ha conseguito una media voto compresa tra 0.50 e 0.70 (es. 6,55)
Punti0.30 Si attribuisce il punteggio di 0.30 solo se lo studente ha conseguito una media voto compresa tra 0.71 e 0.99 (es. 7.85)
b) Criteri e strumenti di misurazione e valutazione disciplinari
TIPOLOGIA DI PROVE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO
Discipline Analisi
e comme
nto di un testo
Saggio
breve
Articolo di giorn
ale
Tema
Trattazione
sintetica di un
argomento
Quesiti a
risposta
singola
Quesiti a
risposta multipla
Problem solving
Verifiche orali
ITALIANO * * * * *
LATINO * * *
GRECO * * *
31
STORIA * * *
FILOSOFIA * * *
MATEMATI
CA * * * *
FISICA * * * *
INGLESE * * * *
SCIENZE * * *
STORIA
DELL'ARTE *
EDUCAZIO
NE FISICA verifiche
pratiche
RELIGIONE * * * *
Particolare attenzione è stata riservata alla preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato, per cui si è proceduto come di seguito:
▪ Prima prova scritta (Italiano):
Le prove somministrate agli alunni hanno riguardato le tipologie previste dall’Esame di Stato: analisi di testi letterari (tipologia A), articolo di giornale o saggio breve su diversi ambiti [artistico-letterario, socio-economico, storico, ecc.] (tipologia B), tema di carattere storico (tipologia C) e tema di ordine generale (tipologia D). Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, ci si è attenuti alle seguenti griglie:
32
PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A
(ANALISI DEL TESTO) COGNOME______________________ NOME _______________ DATA DI SVOLGIMENTO / /201
INDICATORI 1. Comprensione analitica e interpretazione d’insieme del testo 2. Capacità di approfondimento e contestualizzazione del testo 3. Individuazione della natura del testo anche nelle sue strutture
formali 4. Capacità di elaborazione di una propria tesi interpretativa 5. Correttezza e proprietà linguistica
Giudizio sintetico Banda oscillazione
1 2 3 4 5
Nullo 0 – 2 Gravemente insufficiente
3-4
Insufficiente 4 Mediocre 5
Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-10
RISULTATO DELLA PROVA
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
NOTE……………………………………………………………………………………………………………………………………………
33
TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE O ARTICOLO)
COGNOME______________________ NOME __________________________________ DATA DI SVOLGIMENTO: / /201
INDICATORI 1. CONFORMITÀ E COERENZA DEL REGISTRO LINGUISTICO ADOTTATO CON LA TIPOLOGIA DI
SCRITTURA PRESCELTA (ARTICOLO O SAGGIO) E/O CON LA TIPOLOGIA DELLA DESTINAZIONE EDITORIALE EVENTUALMENTE INDIVIDUATA
2. TRATTAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO E COERENZA NELLA LORO UTILIZZAZIONE
3. CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA E INCISIVITÀ COMUNICATIVA 4. CAPACITÀ DI ELABORAZIONE PERSONALE
Giudizio sintetico Banda oscillazione
1 2 3 4
Nullo 0 – 2 Gravemente insufficiente
3-4
Insufficiente 4 Mediocre 5
Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-10
RISULTATO DELLA PROVA
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
NOTE…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
34
TIPOLOGIA C - D (SVILUPPO DI UN ARGOMENTO STORICO) (TRATTAZIONE DI UN TEMA GENERALE)
COGNOME______________________ NOME __________________________________
DATA DI ESECUZIONE / /201
INDICATORI 1. CORRETTEZZA DELL’ARGOMENTAZIONE 2. STRUTTURA DELLE ARGOMENTAZIONE 3. CAPACITÀ DI ELABORAZIONE PERSONALE E SVILUPPO CRITICO
DELL’ARGOMENTAZIONE. 4. CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA E INCISIVITÀ COMUNICATIVA
GIUDIZIO SINTETICO BANDA OSCILLAZIONE
1 2 3 4
Nullo 0 – 2 Gravemente insufficiente
3-4
Insufficiente 4 Mediocre 5
Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-10
RISULTATO DELLA PROVA
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
NOTE……………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
▪ Seconda prova scritta:
Prove di tipo interpretativo di testi latini, di difficoltà gradualmente crescente, somministrate sia come esercitazioni da effettuare a casa che come compiti in classe. Per la correzione della seconda prova è stata utilizzata la seguente griglia:
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
CONOSCENZE
CONOSCENZE MORFO-
SINTATTICHE
NON ESPRESSE O FRAMMENTARIE 0
LACUNOSE E CON GRAVI ERRORI DI MORFOSINTASSI 1
SUPERFICIALI E PARZIALI 1,5
ESSENZIALI CON ALCUNI ERRORI DI MORFOSINTASSI 2
COMPLETE ED APPROPRIATE 3
CAPACITA’ NON COMPRENDE IL TESTO 0
COMPRENSIONE DEL TESTO
COMPRENDE SOLO ALCUNI PUNTI - GRAVI LACUNE INTERPRETATIVE
1
COMPRENDE PARZIALMENTE IL TESTO 1,5
COMPRENDE LA QUASI TOTALTA’ DEL TESTO CON IL FRAINTENDIMENTO DI ALCUNE STRUTTURE SENZA
PREGIUDIZIO PER IL SENSO GENERALE
2
COMPRENDE IL TESTO ANCHE SE CON ALCUNE INCERTEZZE
3
COMPRENDE AD OGNI LIVELLO E NEI DETTAGLI 4
36
COMPETENZE BRANO NON TRADOTTO 0
TRADUZIONE E RESA IN
ITALIANO
TRADUCE IN MODO CONFUSO, CON ERRORI DI MORFOSITASSI - ERRORI DI LINGUA ITALIANA E SCELTE
LESSICALI NON APPROPRIATE
1
TRADUCE CON LACUNE DI MORFOSINTASSI ED ERRORI NELLE SCELTE LESSICALI
1,5
TRADUCE IN MODO SEMPLICE E CHIARO CON SCELTE LESSICALI QUASI SEMPRE APPROPRIATE
2
TRADUCE IN MODO EFFICACE 2,5
TRADUCE IN MODO EFFICACE, PRECISO E PERSONALE 3
TOTALE
_______
Data:_________
Il Docente
▪ Terza prova scritta:
E’ stata svolta una prova di simulazione nel mese di aprile (che si allega) e ne è stata prevista una seconda alla fine di maggio. La prova simulata e' stata strutturata secondo la tipologia A (trattazione sintetica) e ha coinvolto 5 discipline. Per maggiori dettagli si rimanda al testo della simulazione, allegato al presente Documento. Di seguito si indica la griglia impiegata per la correzione della prova.
37
SCHEDA DI VALUTAZIONE III° PROVA Candidato-------------------------------------------------------- Classe V C Anno scol. 2016 /2017
Indicatori
Descrittori
Non ha trattato l’argomento proposto
Valutazione
Punti
0
Punteggio discipline 1° 2° 3° 4° 5°
Conoscenza
dei contenuti
Non conosce i contenuti richiesti Gravemente insufficiente 1
Conosce solo una minima parte dei contenuti richiesti
Insufficiente 2
Conosce in modo superficiale i contenuti Mediocre 3
Conosce i contenuti in modo essenziale, pur con qualche imprecisione
Complessivamente sufficiente
4
Conosce i contenuti in modo corretto e/o consequenziale
Discreto/ Buono 5
Conosce i contenuti in modo organico ed approfondito
Ottimo/ Eccellente 6
Competenza di rielaborazione e
contestualizzazione dei contenuti, utilizzando
correttezza e proprietà di linguaggio
Rielabora i contenuti e si esprime in modo non adeguato
Gravemente insufficiente 1
Rielabora i contenuti in modo parziale utilizzando un linguaggio impreciso
Insufficiente 2
Rielabora i contenuti in modo superficiale, utilizzando un linguaggio semplice
Mediocre 3
Rielabora correttamente i contenuti, utilizzando un linguaggio lineare, pur con
qualche imprecisione
Complessivamente sufficiente
4
38
Rielabora i contenuti in modo corretto e/o coerente utilizzando un linguaggio sicuro
e/o ben articolato
Discreto/Buono 5
Rielabora in modo ampio ed approfondito i contenuti, utilizzando un linguaggio
chiaro e rigoroso
Ottimo/Eccellente 6
Capacità di sintesi e di giudizio
Analizza in modo confuso l’argomento proposto
Insufficiente 1
Analizza in linea generale gli argomenti richiesti con sufficiente sintesi
Sufficiente 2
Analizza approfonditamente gli argomenti operando una sintesi appropriata
Buono 3
Avellino------------------------------------------- La Commissione:
TOTALE
15
/15
/15
/15
/15
/15
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE : -----------/ 75
----------/ 75 : 5 = -----/ 15 TOTALE PUNTI: ------/ 15
39
5. Obiettivi raggiunti
a) Obiettivi raggiunti trasversali
Sono gli obiettivi che interessano i diversi ambiti disciplinari. In sintesi, essi concorrono alla promozione della persona nella sua globalità.
1) Conoscenza dei contenuti e del linguaggio tecnico, specifici delle discipline di studio a) Conseguire un’ampia educazione linguistica, un’attitudine alla lettura e alla produzione
scritta di testi; b) Conoscere informazioni, regole, procedimenti relativi ai programmi svolti; c) Acquisire un complesso di conoscenze affidabili e precise; d) Possedere dati, fatti, concetti, idee, regole, procedimenti relativi agli argomenti presi in
esame; e) Acquisire la consapevolezza dello spessore storico e culturale delle discipline classiche,
attualizzate nell’adeguamento ai tempi “nuovi” e moderni; f) Acquisire la consapevolezza della nostra identità culturale come popolo erede della
tradizione antica; g) Acquisire l’esatta terminologia tecnica e l’uso del linguaggio specifico delle discipline
per una corretta comunicazione; h) Saper usare registri linguistici e funzioni del linguaggio adeguati alla tipologia degli
argomenti presi in esame; i) Comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro; j) Comprendere metodi o criteri da seguire, teorie a cui riferirsi; k) Tradurre brani letterari e commentare testi che comprendono note esplicative, linee
interpretative e giudizi critici.
2) Analisi a) Saper esercitare le capacità di analisi e rielaborazione delle conoscenze; b) Saper individuare i concetti generali; c) Saper individuare gli aspetti più rilevanti dei processi e dei fenomeni esaminati; d) Saper creare una gerarchia tra le informazioni presenti in un testo; e) Saper individuare il tipo di relazione presente tra le informazioni; f) Saper analizzare in tutte le loro parti le questioni prese in esame; g) Saper scomporre gli argomenti trattati nei loro elementi costitutivi; h) Saper operare transfer su altri contenuti, raccordi pluri e interdisciplinari. 3) Sintesi a) Saper riassumere le informazioni ricavate da più fonti e fare la sintesi di dati e di
concetti; b) Saper impostare un discorso, un ragionamento, un problema da un punto di vista
procedurale; c) Saper individuare gli elementi fondamentali delle questioni trattate; d) Saper svolgere attività indipendenti organizzandosi autonomamente.
40
4) Applicazione a) Saper pensare per modelli diversi e individuare alternative possibili; b) Saper applicare una regola generale e astratta a situazioni concrete; c) Saper applicare i metodi e le regole studiati; d) Saper applicare i principi appresi, in problemi anche complessi; e) Saper ridefinire un concetto, cogliere implicazioni e determinare correlazioni; f) Saper leggere i periodi tra loro in discorso logico; g) Saper rielaborare criticamente ed in autonomia le conoscenze acquisite; h) Saper approfondire, rielaborare e collegare in modo creativo e personale; i) Saper prendere iniziative, affrontare e gestire in maniera corretta situazioni nuove e
problematiche. 5) Valutazione a) Saper riesaminare criticamente le conoscenze acquisite; b) Saper formulare una valutazione critica; c) Saper effettuare la revisione critica del proprio giudizio; d) Saper giustificare la scelta delle proprie argomentazioni; e) Sapersi orientare a livello spazio-temporale nel quadro di riferimento generale; f) Saper verificare i risultati e formulare ipotesi; g) Saper affrontare problemi concreti anche al di fuori dell’ambito disciplinare; h) Saper affrontare problematiche nuove in contesti dinamici.
b) Obiettivi raggiunti disciplinari
a) Obiettivi disciplinari di italiano perseguiti nel corso dell’anno scolastico 2016-17:
Lo studio e l’insegnamento della lingua e letteratura italiana sono stati fondamentali nel corso dell'anno scolastico, perché hanno favorito il consolidamento delle capacità linguistiche ed hanno contribuito alla formazione dell’individuo.
Durante l’attività didattico - educativa si sono perseguiti i seguenti obiettivi generali: • Rendere consapevoli gli alunni della specificità e della complessità del fenomeno
letterario, come espressione della civiltà in rapporto alle altre manifestazioni artistiche • Favorire la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e produzione scritta ed
orale
Gli studenti hanno conoscenze e competenze tali da saper: • collocare un testo in un quadro di confronti e relazioni letterarie, storiche ed artistiche • proporre dei motivati giudizi critici • cogliere attraverso la conoscenza degli autori più rappresentativi le linee fondamentali
della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana
41
• stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi • collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in contesti diversi; • produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, in particolare
nelle tipologie previste per gli Esami di Stato ( analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di ordine generale/ testo argomentativo)
SAPERI MINIMI
I saperi minimi essenziali in uscita dal triennio in termini di conoscenze, competenze e capacità possono essere così schematizzati:
Conoscenze
• conoscenza di una visione di insieme della storia letteraria( Ottocento e Novecento) e degli autori di maggior rilievo e più rappresentativi delle principali correnti letterarie
Competenze
• saper analizzare ed interpretare la tipologia e la struttura dei testi letterari e non letterari
• saper esporre in modo organico
Capacità
• capacità di contestualizzazione dei testi • capacità di collegare argomenti, di organizzare e rielaborare i contenuti assimilati • capacità di esprimere giudizi critici motivati
b)Obiettivi specifici raggiunti in Latino
Lo studio e l’insegnamento della lingua e della letteratura latina ha favorito il consolidamento delle capacità espressive ed hanno contribuito alla formazione dell’individuo. Gli studenti hanno conoscenze tali da saper: ➢ collocare un testo in un quadro di confronti e relazioni letterarie, storiche ed artistiche; ➢ proporre dei motivati giudizi critici; ➢ cogliere attraverso la conoscenza degli autori più rappresentativi le linee fondamentali
della prospettiva storica nella letteratura antica;
Gli studenti hanno competenze tali da saper: ➢ formulare un discorso orale in forma corretta; ➢ tradurre un testo ricostruendone, con esiti diversi, nuclei semantici e struttura morfo-
sintattica
42
SAPERI MINIMI: Il livello minimo di conoscenze raggiunto dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità può essere così schematizzato:
Latino
• Conosce le strutture morfo-sintattiche essenziali;
• Sa analizzare un testo elementare nella sua struttura morfo-sintattica
• Conosce gli autori della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia a quella degli antonini che sono stati oggetto di studio;
• Conosce le opere principali e gli aspetti essenziali del pensiero degli autori principali della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia a quella degli antonini che sono stati oggetto di studio;
c) Obiettivi specifici raggiunti in Greco
Lo studio e l’insegnamento della lingua e della letteratura greca ha favorito il consolidamento delle capacità espressive ed hanno contribuito alla formazione dell’individuo. Gli studenti hanno conoscenze tali da saper: ➢ collocare un testo in un quadro di confronti e relazioni letterarie, storiche ed artistiche; ➢ proporre dei motivati giudizi critici; ➢ cogliere attraverso la conoscenza degli autori più rappresentativi le linee fondamentali
della prospettiva storica nella letteratura antica;
Gli studenti hanno competenze tali da saper: ➢ formulare un discorso orale in forma corretta; ➢ tradurre un testo ricostruendone, con esiti diversi, nuclei semantici e struttura morfo-
sintattica SAPERI MINIMI: Il livello minimo di conoscenze raggiunto dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità può essere così schematizzato:
• Conosce le strutture morfo-sintattiche essenziali;
• Sa analizzare un testo elementare nella sua struttura morfo-sintattica
• Conosce gli autori principali della storia della letteratura greca dall’epoca ellenistica a quella imperiale
• Conosce le opere principali e gli aspetti essenziali del pensiero degli autori principali della storia della letteratura greca dall’epoca ellenistica a quella imperiale
43
d) Obiettivi raggiunti nella disciplina dell’Inglese
Conoscenze ● Funzioni linguistiche, strutture grammaticali, lessico necessari per un utilizzo della
lingua relativa al livello di competenza linguistica di tipo B1- B2; · Approfondimento culturale attraverso lo studio degli aspetti storico-letterari più
importanti caratterizzanti i periodi compresi tra il ‘700 e il ‘900 · Relazioni tra autori e correnti letterarie.
Capacità · Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione
liceale con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea
· Analizzare e confrontare testi letterari anche provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);
· Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte;
● Esporre in modo chiaro e corretto argomenti di civiltà e letteratura inglese ● Produrre testi su tematiche coerenti con il percorso di studio ● Evidenziare capacità di analisi e di sintesi sia nell’esposizione orale che nella
produzione scritta · Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; · Approfondire argomenti di natura non linguistica Competenze
Raggiungimento del livello B1- B2 delle competenze linguistiche fissate dal “ Quadro Comune Europeo di Riferimento”.
e) Obiettivi disciplinari di filosofia perseguiti nel corso dell’anno scolastico 2016-17:
Lo studio della filosofia ha contribuito all'acquisizione di una mentalità aperta e critica, aprendo all’analisi e alla riflessione e fornendo gli strumenti concettuali necessari per porsi di fronte alla realtà con un atteggiamento problematico, libero da pregiudizi, consapevole dei propri limiti e delle proprie aspettative. Gli studenti conoscono:
- i principali problemi filosofici e comprendono il loro significato e la loro portata storica e teoretica;
- conoscono il pensiero dei filosofi più significativi, in riferimento alle tematiche di ordine gnoseologico, etico e politico;
44
Gli studenti sono capaci di: - ricostruire il pensiero di un autore operando i dovuti collegamenti; - confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema,
evidenziando aspetti di continuità e discontinuità; Gli studenti hanno competenze per:
- saper riconoscere ed utilizzare il lessico disciplinare e le categorie principali della tradizione filosofica;
- saper spiegare concetti e teorie con precisione linguistica e rigore logico; - saper analizzare testi e brani antologici filosoficamente rilevanti, enucleando le idee
centrali e i concetti chiave SAPERI MINIMI: Il livello minimo raggiunto dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità può essere così schematizzato:
- Conoscenza del pensiero e dell’opera degli autori trattati durante l’anno scolastico - Capacità di fare confronti, anche se semplici, tra diverse posizioni e scuola filosofiche - Competenza nell’elaborazione di un semplice testo argomentativo su temi di ordine
filosofico
f) Obiettivi disciplinari di storia perseguiti nel corso dell’anno scolastico 2016-17:
Lo studio della storia, attraverso la comprensione e la ricostruzione degli eventi e delle trasformazioni storiche, ha consentito agli studenti di orientarsi e di collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, e di svolgerne un’analisi critica in base a specifici e significativi criteri. Gli studenti conoscono:
- una situazione storica nei suoi elementi politici, economici e culturali; - il concetto di periodizzazione, per ordinare cronologicamente gli eventi e per
inquadrare i diversi fenomeni storici; - che la ricostruzione di un fatto storico è il risultato di un lavoro di ricerca, confronto
classificazione, organizzazione e interpretazione delle fonti; - l’importanza degli strumenti concettuali approntati dalla storiografia e conoscere le
ipotesi fornite dalla lettura dei testi storiografici. Gli studenti sono capaci di:
- esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; - utilizzare termini, concetti e paradigmi storici in rapporto agli specifici contesti
storico- culturali; - utilizzare fonti documentarie e confrontare informazioni tratte da esse per ricostruire
un evento storico, attraverso un percorso di ricerca; - costruire la linea del tempo per collocarvi personaggi ed eventi
Gli studenti hanno competenze per: - saper problematizzare, formulare domande ed inquadrare in scala diacronica le
conoscenze acquisite;
45
- saper selezionare, in base a criteri preventivamente esplicitati, le informazioni contenute in un testo, memorizzarle e ripresentarle in maniera sintetica e critica;
- padroneggiare gli strumenti concettuali propri della storiografia, per individuare e descrivere stabilità e cambiamenti
- saper estrapolare da esse i concetti utili ad una ricostruzione storica.
SAPERI MINIMI: Il livello minimo raggiunto dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità può essere così schematizzato:
- Conoscenza dei tratti fondamentali della storia europea e mondiale trattata durante l’anno scolastico
- Capacità di fare confronti, anche se semplici, tra fatti e personaggi del passato e problemi riguardanti il presente
- Competenza nell’elaborazione di un semplice testo argomentativo su temi di ordine storico
g) Obiettivi disciplinari di FISICA
Lo studio della Fisica ha contribuito a sollecitare le capacità intuitive e logiche, di analisi e di sintesi, di ragionamento induttivo e deduttivo, l’abitudine ad utilizzare un registro linguistico corretto e specifico, le capacità di ragionamento coerente ed argomentato, l’attitudine a descrivere ed interpretare ogni fenomeno osservato, ponendosi problemi e ricercandone la risposta.
Obiettivi minimi disciplinari conseguiti in termini di conoscenze ed abilità : Acquisizione delle principali conoscenze e delle conseguenti abilità operative di base riguardanti:
- I principali fenomeni elettrici (statici e dinamici) e le relative implicazioni energetiche - I principali fenomeni elettromagnetici e le più significative interazioni tra corrente elettrica e campi magnetici - Le abilità risolutive di base circa essenziali problemi numerici afferenti alle tematiche trattate.
Obiettivi minimi disciplinari conseguiti in termini di competenze : - Osservare, descrivere ed operare un’analisi di massima di fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale riconducibili alle tematiche trattate - Cogliere le relazioni tra le variabili (grandezze fisiche) associate ai principali
fenomeni oggetto di studio
h) Obiettivi disciplinari di MATEMATICA
Lo studio della Matematica ha contribuito a promuovere lo sviluppo di una coscienza critica, le capacità intuitive e logiche, di analisi e di sintesi, l’attitudine ad utilizzare un linguaggio
46
essenziale ma rigoroso, la capacità di individuare problemi e di discernere soluzioni appropriate. Obiettivi minimi disciplinari conseguiti in termini di conoscenze ed abilità :
Acquisizione delle principali conoscenze e delle conseguenti abilità operative di base riguardanti:
- I fondamenti delle funzioni reali di una variabile reale - I fondamenti sul concetto di limite - I fondamenti dell’analisi infinitesimale, con particolare riferimento alla continuità ed
alla derivabilità - Le principali caratteristiche grafiche delle funzioni reali in una variabile reale, con
particolare riferimento alle funzioni razionali fratte - Le abilità risolutive di base circa i problemi numerici ed i procedimenti di calcolo
più significativi e ricorrenti afferenti alle tematiche trattate.
Obiettivi minimi disciplinari conseguiti in termini di competenze : - Individuare relazioni e dipendenze
- Comprendere le fasi di un ragionamento riconoscendone la consequenzialità
- Riconoscere collegamenti con altre discipline
- Discernere gli strumenti di calcolo adeguati alla risoluzione di problemi analitici di base
- Interpretare le principali caratteristiche di un grafico.
i) Obiettivi raggiunti nella disciplina delle Scienze
1 Riconoscere e stabilire relazioni 2 Saper effettuare connessioni logiche 3 Integrare criticamente informazioni provenienti da canali diversi 4 Classificare materiali differenti e livelli diversi di organizzazione in ambito biologico e
geologico 5 Formulare ipotesi in base a dati definiti; organizzare anche a gruppi processi per ottenere
informazioni e dati ulteriori e trarre conclusioni dai risultati ottenuti 6 Riconoscere processi formativi sia in campo biologico che in campo geologico
ABILITA' E CAPACITA’ 1.1 Analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi più semplici 1.2 Ricomporre gli elementi sapendone vedere le interazioni 2.1 Usare in modo consapevole il libro di testo e a altri strumenti di consultazione: banche
dati, siti web, dizionari specialistici anche in lingua, tavola periodica e tabelle chimiche...
47
2.2Saper effettuare scelte e connessioni da fonti diverse 3.1 Saper riconoscere le caratteristiche dei principali composti organici 3.2Saper riconoscere il processo di replicazione dell'informazione genica ed identificare le
fasi dell'espressione dei geni 3.3 Interpretare le opportunità fornite dalla nuova biologia molecolare 4.1 Saper riconoscere i principali componenti della litosfera 4.2 Individuare i ruoli distruttivi e costruttivi d ei fenomeni vulcanici e sismici 4.3 Ricostruire le dinamiche generali della litosfera 4.4 Identificare gli elementi geologici che hanno generato il territorio italiano 5.1 Attenersi alle norme di sicurezza per l'uso del laboratorio 5.2 Confrontarsi e comunicare con gli altri per organizzare percorsi al fine di ottenere dati
utili al proprio lavoro 5.3 Formulare relazioni strutturate per comunicare conoscenze e opinioni 6.1 Assumere un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della
salute propria e altrui 6.2 Assumere un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi dell'ambiente. OBIETTIVI MINIMI CONSEGUITI: CONOSCENZE DI BASE : LA CHIMICA DELL'ATOMO DI CARBONIO CONOSCENZE ESSENZIALI: I PRINCIPALI COMPOSTI ORGANICI DI INTERESSE
BIOLOGICO CONOSCENZE DI BASE :LA BIOCHIMICA DEGLI ACIDI NUCLEICI E DELLE
PROTEINE CONOSCENZE ESSENZIALI : LA REGOLAZIONE DELL'ESPRESSIONE GENICA CONOSCENZE BASILARI : LA COMPOSIZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
GENERALE DELLA TERRA SOLIDA CONOSCENZE FONDAMENTALI: L’INTERNO DELLA TERRA E I FENOMENI
VULCANICI E SISMICI CONOSCENZE BASILARI: LA TETTONICA DELLE PLACCHE CONOSCENZE ESSENZIALI: LE RISORSE ENERGETICHE.
l) Obiettivi specifici raggiunti nella disciplina della Storia dell’arte
In sede di programmazione sono stati fissati i seguenti obiettivi: • Valutazione dell’opera d’arte in relazione allo sviluppo della sua contemporaneità; • L’opera d’arte considerata come documento storico di esperienze individuali e sociali; • Analisi dell’opera d’arte nelle sue componenti formali e strutturali per comprendere
come faccia parte della cultura storica, artistica e sociale di ogni periodo. Tali obiettivi sono stati raggiunti in generale da tutta la classe. Va sottolineato che un cospicuo numero di alunni ha una preparazione eccellente grazie al notevole impegno ed allo studio costante che ha permesso loro di ottenere un bagaglio di
48
conoscenze e di comprendere in modo approfondito la natura e i significati dell'opera d'arte, i complessi di valori storici, culturali ed estetici e ad esprimersi, attraverso un adeguato lessico tecnico-artistico, giungendo . Alcuni elementi della classe, in vero, sono in grado di relazionarsi con sicurezza con l’opera e giungere anche a considerazioni critiche personali.
m) Obiettivi specifici raggiunti nella disciplina dell’Educazione Fisica
• Miglioramento delle qualità fisiche • Affinamento delle funzioni neuro-muscolari • Acquisizione delle capacità operative e sportive • Interiorizzazione degli aspetti teorico-pratici relativi alle attività svolte
n) Obiettivi specifici raggiunti nella disciplina della Religione
Conoscenze • Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi
di vita che essa propone • Conoscere sistematicamente gli aspetti fondanti l’itinerario del senso religioso • Conoscere il vertice dell’esperienza cristiana: il comandamento dell’amore • Conoscere la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio • Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale Competenze
• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. • Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte etiche della fede cristiana. • Individuare nel comandamento dell’amore il vertice dell’etica cristiana. • Confrontarsi con la visione cristiana del matrimonio.
Capacità
• Cogliere la natura del senso religioso, inteso come domande sul senso ultimo della vita e della realtà, domande che sono inscritte nel cuore dell’uomo e che si pongono per il fatto stesso che l’uomo vive. • Comprendere che l’interrogativo ultimo sul perché della vita implica una risposta, che sta oltre la capacità della ragione e che si presenta come insondabile mistero. • Cogliere le implicazioni etiche della morale cristiana.
49
• Riconoscere il fondamento ontologico del sacramento del matrimonio.
6. Altri elementi utili e significativi ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio
Attività integrative svolte dalla classe:
Il Consiglio di classe, in attuazione del progetto didattico annuale della classe, che si è posto come obiettivo generale quello di favorire il successo formativo di tutti gli alunni ha deliberato e sostenuto l’adesione della classe alle seguenti attività, individuate tra quelle del piano dell’offerta formativa quali quelle più utili e formative per i bisogni del gruppo-classe e il loro svolgimento sia in orario curricolare che extrascolastico:
ü Attività di potenziamento in Discipline giuridiche-economiche ü Corso di tedesco ü Attività di orientamento in uscita ü Progetto “Chi salva un uomo, salva il mondo intero”. L’armadio della vergogna e le
stragi nazi-fasciste impunite; ospite dell’incontro conclusivo il procuratore militare Dott. Antonio Intelisano
ü Olimpiadi della Chimica ü Preparazione ai test universitari ü Certificazioni linguistiche ü Attività di orientamento ü Visite guidate e viaggi d’istruzione: Roma. Napoli. Barcellona.
7. Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLiL
Lo sviluppo di un modulo di lezioni di Storia dell’arte destinato alla metodologia Clil
ha permesso di approfondire il metodo utilizzato nel corso dell’anno scolastico per la messa a punto di competenze relative alla redazione di una scheda di lettura di un’opera d’arte esposta al Museo di Capodimonte ad un caso analogo in ambito europeo.
L’obiettivo quindi è stato quello di far conoscere una prestigiosa istituzione museale presente in una delle principali capitali europee, scegliere l’artista e analizzare dal sito ufficiale (cfr. fonti) del Museo la scheda di lettura in lingua inglese di un’opera d’arte in esso esposta.
Le conoscenze acquisite nel corso dell’anno scolastico sulle problematiche legate al ruolo dei musei oggi, agli artisti e/ai movimenti artistici in ambito europeo, le competenze relative al saper cogliere la complessità dei rapporti tra città- museo-artista e la capacità di condurre una lettura dell’ opera d’arte sono servite per orientarsi nell’esperienza in lingua inglese.
50
Sono state scelte due capitali europee – Londra e Parigi - ,gli artisti e/o i movimenti artistici in cui maggiormente queste si identificano: Turner per Londra e gli impressionisti per Parigi e, di conseguenza, le istituzioni museali in cui trovano spazio la maggioranza dei dipinti attribuibili a questi artisti e/o movimenti: la Tate a Londra e Musée d’Orsay a Parigi . Fonti: per la Tate, TURNER AT TATE (http://www.tate.org.uk/visit/tate-britain/display/turner-collection/turner-at-tate) per il Musée d’Orsay (http://www.musee-orsay.fr/en/home.html?cHash=1030a57d48). Ore: Dato l’esiguo numero di ore curriculari è stato possibile sviluppare un modulo di sole 3 ore. Risultati: ogni alunno alla fine del modulo ha dimostrato di aver acquisito oltre le conoscenze specifiche sul museo, sull’autore e sull’opera scelti anche la competenza di capire la diversità di approccio alla lettura dell’opera d’arte nei diversi contesti geografici operando un confronto tra Italia e Francia o Gran Bretagna. Nel programma allegato sono elencate le opere scelte da ciascun alunno. Avellino, 5/5/17 I Docenti
F/to il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Anna Gianfelice
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c.2 D.Lgs. n. 39/93
52
Testi Terza Prova
Simulazione effettuata il giorno 24/03/17
Tipologia A. Trattazione sintetica degli argomenti in quindici righe. Durata 120 m. Testi proposti: 1. Greco: Illustri il candidato la teoria dell’anaciclosi polibiana e il suo rapporto con la situazione specifica di Roma 2. Inglese: Outline the main features of War Poets, referring to the texts ( No more than 15 lines). 3. Scienze: Le proteine. Descrivi i quattro livelli strutturali 4. Fisica: Il candidato illustri in un massimo di 15 righi il concetto di circuito elettrico e i suoi principi di funzionamento 5.Storia. Il candidato spieghi quali sono i caratteri fondamentali dell’età staliniana