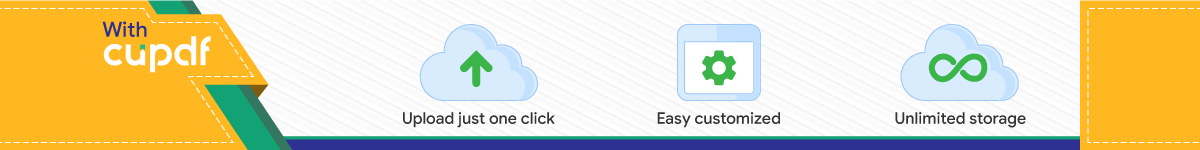

35MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2011TRENTINO
LA STORIA Giovanni Francesco Ziller sbarcò in Sudamericanel 1902: fu a lungo pastore metodista, poi si sposò
La Divina Commediatradotta in Brasile
da un emigrante di Taio
di Alessandro Dell’Aira
Nel bel volume di Ateliê Editorial,curato dall’Università di Campi-nas, stato di San Paolo, il ritrat-
to del traduttore supera per dimensioniquello che Botticelli dedicò a Dante. L’e-dizione moderna riproduce le tavole su-perstiti dell’originale commissionatoda Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medicialla fine del Quattrocento, oggi divisetra il Kupferstichkabinett di Berlino(85) e la Biblioteca Vaticana (7). Il ri-
tratto di João Trentino Zilller, del 1980,si deve al suo erede Zilmar Ziller Mar-cos, cui spettano anche i diritti del testo.Zilmar, docente a riposo della Scuoladi Agricoltura Luiz de Queiroz (Esalq)di Piracicaba, autore di un’Ode allasua scuola e baldo interprete dell’innodell’Esalq su Youtube, è un teorico delsapere accumulato. Ha fondato un circo-lo di pensionati che non ha nulla degliscontati “club di pantere grigie”.
Giovanni Francesco Ziller,nato a Taio il 27 dicembre1878 ed emigrato in Brasilenel 1902, disegnato dal polie-drico Zilmar guarda oltre gliocchiali montati in tartarugae ha un naso importante manon adunco come quello del-l’Alighieri.
Questa terza edizione inte-grale brasiliana della DivinaCommedia tradotta da Zillerè in circolazione da qualchegiorno. La prima e la secon-da uscirono a Belo Horizontenel 1953 e nel 1978. È la primain lingua portoghese intera-mente illustrata dai disegnidel grande artista fiorentino.Costa 280 reais, centoventi eu-ro circa. In Europa varrebbepiù del doppio. Le terzine so-no impaginate in orizzontale,formato landscape. Dante inpagine pari, João Trentino inpagine dispari. Chi arriva infondo all’Inferno deve capo-volgere il volume, così comeDante e Virgilio si giraronoper scalare il corpo di Lucife-ro, il primo avvinghiato alcollo del secondo, diretti inPurgatorio. Questa formulariproduce la soluzione adotta-ta da Botticelli, che ideò 102scene associandone una a cia-scun canto, più due disegnisciolti: Lucifero al centro delcodice e l’Inferno in apertu-ra. In altre parole, se per leg-
gere l’Inferno si scende, perleggere Purgatorio e Paradi-so si sale fino all’«amor chemove il sole e l’altre stelle».Considerate le pose disinvol-te dei lettori di oggi, ciò puòrivelarsi scomodo, oltretuttoperché il volume va sfogliatocome i calendari, facendo at-tenzione a non gualcire le 558pagine formato quarto gran-de. Noblesse, o meglio, Botti-celli oblige. Il librone va aper-to su un piano di lettura, pos-sibilmente inclinato, e nonsulle ginocchia o sul tavolinobasso del salotto.
Giovanni Francesco Zillernacque a Taio il 27 dicembre1878 ed emigrò in Brasile nel1902, informa Zilmar. Eranotempi in cui «gli italiani e gliaustriaci si alternavano nellapreponderanza numerica epolitica della regione». Figliodi genitori austriaci, la lin-gua in cui imparò ad espri-mersi «era un dialetto mistodi un tedesco snaturato e diun distante latino». Studiònelle migliori scuole dellaprovincia, specializzandosinelle materie incluse in unbuon curriculum letterario efilosofico. E «fece della cultu-ra italiana la sua cultura».Continuando, si apprendeche Giovanni Francesco stu-diò anche a Roma, in semina-rio.
Lette in Trentino, questenotizie suonano un po’ va-ghe. Si apprende un po’ dipiù sulle origini di Ziller con-sultando il sito web dei natiin Trentino, che raccoglie unmilione e duecentomila no-mi. Giovanni Francesco erafiglio di Vittore Ziller e Leo-polda Perenthaler. SecondoZilmar, giunse in Brasile daTaio a ventiquattro anni e viiniziò «la carriera sacerdota-le col nome di fra’ Giustino».Non vi sono altri dati sull’or-dine o la famiglia religiosa diappartenenza. Quando si na-turalizzò brasiliano, da none-so che era, volle chiamarsiJoão e scambiò Francesco
con Trentino, in omaggio allaterra d’origine. Questa suascelta, forse, è un indizio del-l’abbandono del saio del Pove-rello di Assisi. João TrentinoZiller iniziò un lungo ministe-ro di pastore della Chiesa me-todista del Brasile. Quandomorì, dopo sessantaquattroanni di magistero, si presu-me nel 1966 all’età di 88 anni,aveva rinunciato anche allostato di pastore metodista.
Ziller si sposò ed ebbe mol-ti figli. Insegnò portoghese,latino, storia e geografia aJuiz de Fora, nello stato diMinas Gerais, quindi nella ca-pitale Belo Horizonte, poi an-che nello stato di San Paolo.
In un sito web brasiliano, mail dato non è sicuro, risultache insegnò anche a Leopoldi-na, nel Rio Grande do Sul,che la moglie si chiamavaLuigia Gazzoni e che ebbedue figlie di nome Angelina(1913) e Abigail (1914). Acqui-sì buona familiarità con lalingua portoghese, tanto chenel 1925 pubblicò un agile te-sto di filologia. Tenne confe-renze sui Lusiadi di Camõese su vari argomenti letterari.Nel frattempo, fino all’età di75 anni, si dedicò alla DivinaCommedia, resa in terzine didecasillabi a rima concatena-ta. Nella metrica lusitana, in-fatti, il nostro endecasillaboè detto decasillabo: l’ultimasillaba non conta perché nonaccentata.
Come dicono i teorici, il bi-lancio del traduttore è fattodi perdite e guadagni. Secon-do Umberto Eco, che “nego-zia” col testo se l’autore è pas-sato a miglior vita, tradurreè «dire quasi la stessa cosa».È arduo salvare il testo origi-nale e nello stesso tempo lametrica, tanto è vero che sem-pre si è fatta dell’ironia sultraduttore-traditore. Ciò checonta davvero, in ogni caso, èmantenersi distanti e non ag-giungere nulla di proprio, odi gratuito.
L’edizione è impegnativa e
iperdidascalica. Prima diogni canto, come in tutte leedizioni commentate, c’è unasintesi a cura di João AdolfoHansen. Nel primo verso, tut-tavia, c’è un di più che avreb-be infastidito l’Alighieri. «Àmeia idade da terrena vi-da...». Letteralmente: «A mez-za età della vita terrena...».Passi per il cammin trasfigu-rato in età, ma quel «terre-na» Dante non lo aveva scrit-to. C’era un modo più sempli-ce di salvare il verso, la rimae la metrica: «No meio do ca-minho desta vida...». Forse aZiller sembrò un calco trop-po fedele all’originale. Direb-bero i puristi: la fedeltà non èmai troppa. Non è questo ilproblema. I guai comincianoquando il traduttore competecol testo di partenza e via vianegoziando aggiunge coseche gli suonano dentro, e chenel testo non ci sono. In codaai canti c’è un saggio pregevo-le: “Note alla Commedia diBotticelli”, di Henrique Picci-nato Xavier. Per i nostri dan-tisti, e non solo per loro, un’e-dizione di tanto valore è unorgoglio. Alla fine della fiera,come si direbbe a Taio, unaDivina Commedia così, “co-ver” del codice mediceo, nonpotrà mancare sugli scaffalidei bibliofili.
A RIPRODUZIONE RISERVATA
La «Divina Commedia» in portoghese; a destra, una delle preziose illustrazioni
È la primaedizione in lingua
portoghese interamenteillustrata dalle tavoleoriginali di Botticelli
La pagina con il profilo (e il ritratto) di João Trentino Ziller
Uno dei casi letterari del-l’ultimo decennio è sta-ta la pubblicazione di
«2666», il grande romanzo diRoberto Bolano. Una delle cin-que parti della sterminata ope-ra è intitolata «La parte dei de-litti» e racconta la sconvolgen-te violenza che da anni domi-na a Ciudad Juarez (che Bola-no nel romanzo chiama SantaTeresa), una grande città alconfine tra Messico e Stati Uni-ti, forse la più violenta al mon-do: da 3000 a 4000 omicidi l’an-no, la maggior parte a causadella guerra tra bande di nar-cotraffico. Centinaia di donneviolentate e uccise, forze del-l’ordine assediate (quando noncomplici), e in più il drammadell’emigrazione verso il Te-xas. L’ombra della violenza diCiudad Juarez arriva ora in
tutta la sua dirompenza anchea Bolzano con la mostra «Fron-tera» della messicana TeresaMargolles, aperta fino al 28agosto. La Margolles non si fer-ma davanti a niente, e se que-sto da un lato spinge l’arte interritori pericolosamente vici-ni alla cronaca e al nudo reali-smo, dall’altro produce operedi fortissimo impatto. Le instal-lazioni centrali dell’allestimen-
to sono due muri, provenientidal Messico e ricostruiti al mu-seo. Contro uno di questi muri(faceva parte di una scuola) so-no stati uccisi quattro giovanidai 15 ai 25 anni. Contro l’altrosono stati trucidati a colpi dimitragliatrice due poliziotti.Sulle pareti sono ancora visibi-li i buchi dei proiettili, ma an-che i graffiti e il filo spinatooriginali, e anche i segni lascia-
ti dalle indagini della polizia.Pezzi di paesaggio urbano chediventano testimonianze di vio-lenza, ma che trasportati in unmuseo diventano anche scultu-re. E lo spettatore, a sua volta,diventa testimone degli omici-di. Una terza installazione è«Plancha»: una lunga piastradi acciaio incandescente sulquale cadono dall’alto, lenta-mente, gocce d’acqua che alcontatto con l’acciaio evapora-no con un sibilo, lasciando un-’alone indelebile. Ma quella èl’acqua con cui sono lavati i ca-daveri all’obitorio. Altre instal-lazioni - come una lunga inci-sione lungo una parete del mu-seo che viene riempita di gras-so di cadaveri - e video raccon-tano la violenza di Juarez, tra-sfigurandola artisticamente.
A RIPRODUZIONE RISERVATA
BOLZANO
Al Museion la mostradi Teresa Margolles
Il video proiettato in questi giorni sulla facciata del Museion
L’arte racconta l’orrore di Ciudad JuarezGrasso di cadaveri e muri con i fori delle esecuzioni
LA POLEMICA
Il Dolomiten accusa: barbarie
«Teresa Margolles lavora con le tracce concrete dellasofferenza: la trasposizione di un oggetto in un con-testo espositivo e il coinvolgimento della collettività
fanno parte dei linguaggi dell’arte contemporanea». Lo affer-ma Letizia Ragaglia, direttrice del Museion di Bolzano, in me-rito alle polemiche sulla mostra sollevate ieri dal quotidianodi lingua tedesca “Dolomiten”, che ha parlato di «barbarie».Ragaglia ricorda la performance “Balkan Baroque” di MarinaAbramovich, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia 1997, incui la Abramovich lavava scheletri su una pila di ossa anima-li come atto di purificazione per la guerra dei Balcani: «Il lavo-ro di Teresa Margolles - aggiunge - non si esaurisce con l’ope-ra esposta, ma è un processo che lascia segni di speranza.“Dar voce” al dolore è quello che l’artista fa ogni giorno con ilsuo lavoro, che vede il coinvolgimento della collettività. Sonoinfatti gli stessi familiari delle vittime a cercarla, a raccontar-le le storie, a portarle le testimonianze delle morti».